Un libro imprescindibile
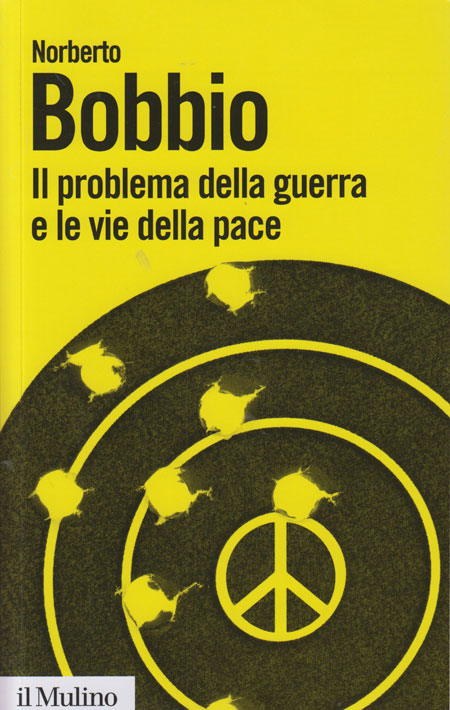
Norberto Bobbio
Il problema della guerra e le vie della pace
Il Mulino
Indice
Prefazione alla quarta edizione
Prefazione alla terza edizione
Prefazione alla seconda edizione
Prefazione alla prima edizione
I. Il problema della guerra e le vie della pace
La bottiglia, la rete e il labirinto. - La guerra come via bloccata. - Una svolta storica. - Realisti, fanatici e fatalisti. - L’equilibrio del terrore. - Per la formazione di una coscienza atomica. - La teoria della guerra giusta. - Vi sono ancora guerre giuste? - La guerra come male apparente. - La guerra come male necessario. - Verso il pacifismo attivo. - Pacifismo strumentale. - Pacifismo istituzionale. - Pacifismo finalistico. - Criteri di giudizio. - Il giudizio, la previsione e la scelta.
II Diritto e guerra
III. L’idea della pace e il pacifismo. - Il concetto della pace. - Il valore della pace. - Concetto e forme di pacifismo.
IV. La nonviolenza è un’alternativa?
Prefazione alla quarta edizione
Questa è la quarta edizione. Le tre precedenti sono uscite, rispettivamente, nel 1979, nel 1984, nel 1991. All’incirca una ogni cinque anni. Il cammino del libro è stato, se pur lento, continuo e regolare.
Ogni edizione ha una propria prefazione. Le ho conservate tutte e tre, perché ognuna riflette la situazione e l’occasione storica in cui la ristampa è avvenuta. La prima edizione, il cui saggio principale risale al 1966, affrontava il problema, che allora si cominciava a discutere, della «formazione di una coscienza atomica», e descriveva tre forme possibili di pacifismo, che chiamavo, il primo, «strumentale» (le varie politiche del disarmo); il secondo, «istituzionale», che distinguevo in «giuridico», ovvero la pace attraverso il diritto, e in «sociale», ovvero la pace attraverso la rivoluzione sociale; il terzo, «finalistico», che distinguevo a sua volta in etico-religioso e terapeutico (la guerra come conseguenza di una malattia da curare).
Nel 1984, quando uscì la seconda edizione, lo scontro tra le due grandi potenze aveva determinato lo stato dei rapporti internazionali chiamato «equilibrio del terrore». Nella prefazione ero costretto a constatare che la «coscienza atomica» non solo non si era formata, ma tanto da parte dei grandi attori politici, quanto da parte di filosofi e studiosi del problema della pace e della guerra, venivano addotti argomenti per legittimare anche la guerra atomica, come se essa non costituisse un salto qualitativo rispetto alle guerre tradizionali.
Nel 1989, prima della terza edizione, pubblicai una raccolta di testi vari, saggi, articoli, discorsi, in cui fra le varie forme di pacifismo che avevo descritto nelle opere precedenti, esprimevo ormai chiaramente la mia preferenza per il pacifismo istituzionale-giuridico, vale a dire per la soluzione che prevede l’istituzione di un Terzo sopra le parti, tanto forte da poter prevenire i tradizionali conflitti fra stati e, qualora un conflitto esploda, da limitarne le conseguenze, e insieme legittimato dal consenso della stragrande maggioranza degli stati componenti il sistema internazionale. Avevo intitolato questa raccolta di scritti Il Terzo assente, per indicare che l’istituzione di un Terzo sopra le parti è la principale esigenza del nostro tempo.
Quando uscì la terza edizione era scoppiata da poco tempo la Guerra del Golfo. L’intervento, se pure indiretto, della Organizzazione delle Nazioni Unite, mi pareva fosse una riprova che l’unico pacifismo credibile fosse quello istituzionale. Ne nacque un dibattito, in cui la maggior parte degli intervenuti sostennero che io avevo torto. Da questo dibattito nacque un libretto, pubblicato nel 1991 dall’editore Marsilio di Venezia, intitolato Una guerra giusta?, che ha ormai soltanto il valore di documento storico.
Questa quarta edizione esce quando, dopo la insperata e imprevista soluzione pacifica, senza spargimento di sangue, della guerra fredda, il mondo si era aperto alla speranza del rafforzamento di una pace duratura. Ma già dal 20 febbraio 1991, da quando il parlamento della Slovenia dichiarò l’indipendenza, seguito il 21 febbraio dal parlamento di Zagabria, che stabilì la priorità della legislazione repubblicana su quella federale, e il 27 febbraio dalla dichiarazione di indipendenza della Bosnia-Erzegovina, ebbe inizio la dissoluzione dello stato jugoslavo, furono poste le premesse di una guerra civile, non meno cruenta della seconda guerra mondiale, con particolare ferocia nella Bosnia- Erzegovina divisa tra Serbi e Musulmani, durata quattro anni. La pace, almeno per ora, è stata stabilita, con gli accordi di Dayton (una base militare dell’Ohio) del 21 novembre 1995, ratificati a Parigi il 14 dicembre 1995. Si legge che il conflitto, nella sola Bosnia, abbia provocato 200.000 morti, e oltre tre milioni fra profughi e rifugiati, e un numero incalcolabile di feriti.
Non parlo delle guerre tribali che si svolgono ininterrottamente con particolare efferatezza in Africa, né delle piccole guerre dei poveri nei paesi non sviluppati, né della guerriglia, i cui focolai sono dispersi in molte parti del mondo. E che dire di quella forma di violenza ancora più limitata, ma non meno efferata, che è il terrorismo, la guerra dei fanatici o dei disperati? L’estensione degli atti di terrorismo nelle più diverse parti del mondo ci pone di fronte a un fenomeno nuovo, al venir meno della esclusività dell’uso della forza pubblica all’interno dei singoli stati, in cui il presidio contro la violenza diffusa ha riposato sinora sulla detenzione, da parte del potere pubblico, del monopolio della forza. Uno dei fenomeni più sconvolgenti nel mondo attuale è l’aumento crescente e irresistibile della violenza privata, esercitata da gruppi eversivi, siano essi politici, siano criminali come la mafia. Può mai uno stato evitare, anche con la polizia più efficiente, che un viaggiatore qualunque depositi una valigia carica di esplosivo in una stazione, dove il portare una valigia non suscita alcun sospetto? Può impedire che il passeggero di una metropolitana depositi un’impercettibile quantità di gas micidiale, che può uccidere, senza che sia possibile alcuna difesa, decine di persone? Il progresso tecnico ha reso sempre più potenti e più facilmente disponibili gli strumenti di morte. La sfida ai costruttori di pace diventa ogni giorno più invincibile. Ci siamo difesi dal terrorismo aereo, se pure con costi di cui è difficile calcolare l’entità, attraverso il controllo dei bagagli negli aeroporti, ma come ci si può difendere dagli attentati sui treni o in una metropolitana, da una macchina carica di esplosivo abbandonata su una strada percorsa da migliaia di macchine?
Ci siamo sempre illusi che la guerra che stavamo combattendo sarebbe stata l’ultima guerra. Il momento in cui ci si poteva abbandonare a questa illusione, è stata la fine del conflitto mortale tra le due maggiori potenze del mondo. L’illusione è durata poco. Delle innumerevoli ragioni per cui gruppi indipendenti entrano in conflitto armato fra loro, gli storici non ignorano le guerre che nascono dalla distruzione dei grandi imperi o dalla fine della coabitazione coatta fra gruppi etnici diversi. Non possiamo dire quindi di essere stati colti di sorpresa. Eppure non ne abbiamo tratte tutte le conseguenze. Quando l’estate si avvicina, non è difficile prevedere gli incendi dei boschi, ma ce ne accorgiamo soltanto quando ormai sono divampati. E ogni anno si pone la solita domanda, senza trovare una risposta convincente, su chi li abbia appiccati. Stranamente, mentre infuriava la guerra nella ex-Jugoslavia, dei movimenti pacifisti si è parlato poco, sempre meno. Eppure non sono stati inerti. Pagine intere dedicate dai giornali e dai mezzi di comunicazione di massa alle notizie della guerra, poche righe alla catena della pace di ferragosto del 1995, cui hanno partecipato migliaia di persone. Voce nobilissima quella dei promotori di pace. Ma chi l’ascolta? Forse che i signori della guerra ascoltano le parole del Papa? Chi crede davvero che l’invocazione della pace degli uomini di buona volontà possa cambiare il corso della guerra e avere un effetto determinante sul tragico destino dei popoli offesi? Si direbbe che la virtuosa manifestazione degli uomini di pace e la più disumana azione di guerra che semina morte siano due eventi che procedono l’uno accanto all’altro e contemporaneamente, senza mai interferire l’uno nell’altro. Ancora una volta, una drammatica conferma che nella storia umana i fautori di guerra sono sempre stati seguiti più dei costruttori di pace. Oggi più che mai i temi del pacifismo devono essere riproposti alla nostra attenzione. Ma non si può parlare di pacifismo in generale, senza le dovute distinzioni. Pacifismo non è soltanto invocare la pace, pregare per la pace, dare testimonianza di volere la pace, accorrere a proprio rischio e pericolo recando aiuti umanitari nei luoghi dove la guerra infuria. Questo è il pacifismo etico-religioso, che si ispira consapevolmente all’etica delle buone intenzioni. Opporre la nonviolenza assoluta in ogni forma, anche la più piccola, di violenza. Offrire l’altra guancia. Meglio morire come Abele che vivere come Caino. Non è più possibile distinguere guerre giuste da guerre ingiuste. Tutte le guerre sono ingiuste. Si obietta che il professare rigorosamente e coerentemente la nonviolenza assoluta serve a salvare la propria anima ma non ha mai eliminato la violenza in questo mondo. Non è forse vero che l’impotenza dell’uomo mite finisce per favorire il prepotente? In una situazione ove per osservare il principio della nonviolenza tutti gli stati fossero disposti a gettare le armi, l’unico che si rifiutasse di farlo diventerebbe il padrone del mondo. Lo stesso Pontefice in occasione della Guerra del Golfo aveva proclamato che la guerra era un’avventura senza ritorno, mentre negli ultimi giorni della guerra nella ex-Jugoslavia sembrò ammettere la legittimità della guerra di difesa. Di fronte a tali obiezioni a me pare che i pacifisti oggi debbano rendersi conto che, se vogliono esercitare un’azione politicamente rilevante, debbono non dimenticare l’etica della responsabilità. Non solo: «Fa’ quel che devi e avvenga quel che può», ma anche: «Fa’ in modo che la tua azione non sia soltanto buona in sé, ma abbia anche conseguenze buone». Di questa forma di pacifismo responsabile vi sono almeno due versioni che chiamerei, per distinguerle dal pacifismo etico-religioso, istituzionali, perché, al fine di eliminare la guerra o almeno di limitarne l’estensione, entrambe ricorrono non soltanto alla parola, al gesto simbolico, ad argomenti persuasivi, ma promuovono il compimento di azioni preventivamente regolate. La prima versione è quella che, richiamandosi alla distinzione gandhiana tra nonviolenza passiva e nonviolenza attiva, prevede la possibilità di predisporre una difesa non armata, che ricorra unicamente ad azioni, come la resistenza passiva, la non collaborazione coi pubblici poteri, la disobbedienza civile, il boicottaggio. La seconda versione, più realistica, e, in quanto più realistica, meno rigorosa, è quella che si fonda sulla distinzione fra la violenza diffusa, e come tale incontrollabile, e la violenza concentrata e controllata, quale quella di un organismo al di sopra delle parti, che dell’uso dei mezzi violenti abbia, esso solo, l’esclusività. Nell’ambito di uno stato, che è il solo legittimato a usare la forza, la maggioranza dei cittadini non ritiene necessario possedere armi, mentre nel sistema internazionale, dove non è stato possibile sinora costituire (e forse non sarà mai possibile) una forza esclusiva al di sopra delle parti, tutti gli stati senza eccezione sono armati. Tanto che, se uno stato non possiede un esercito, non è uno stato, mentre un cittadino inerme non solo è un cittadino ma, almeno sino ad ora, viene giudicato un buon cittadino.
Purtroppo le guerre in corso mostrano anche l’insufficienza del pacifismo istituzionale. La guerra, è vero, chiama sempre la pace. Ma la pace continua ad essere, come sempre è stata, una tregua fra due guerre. Dopo il fallimento della Società delle Nazioni la posta in gioco era più alta: non Società delle Nazioni, ma Nazioni Unite. Era la stessa espressione adottata dalle tredici colonie americane quando si costituirono nel primo grande stato federale della storia, che ebbe il nome di Stati Uniti. Tuttavia, l’espressione Nazioni Unite riecheggia la forma ma non esattamente la sostanza, rimanendo intatta, anche in questo secondo grandioso tentativo di tenere insieme in un sistema giuridico unico gli stati del mondo, la sovranità nazionale. Kant, che conosceva la costituzione degli Stati Uniti, da pochi anni fondati quando scrisse il suo saggio sulla pace perpetua (1795), aveva ben compreso la distinzione tra Völkerbund, o Lega dei popoli, e Völkerstaat, o stato di popoli. Verso quale delle due soluzioni si volgesse la sua preferenza è controverso. Ma nell’art. 2 dello Statuto delle Nazioni Unite si legge che l’«organizzazione [è] fondata sul principio della sovrana uguaglianza di tutti i suoi membri». L’innovazione della Carta delle Nazioni Unite stava nel considerare la guerra di per se stessa come un fatto illecito e, come tale, vietato. Il testo della Carta comincia con queste parole: «Noi, popolo delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità...». L’art. 1 proclama solennemente che il primo fine dell’organizzazione è mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Nell’art. 2 è fatto obbligo agli stati membri di risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionali non siano messe in pericolo. La guerra è posta solennemente fuori legge.
Non ho bisogno di sottolineare l’importanza di questo punto. Nel diritto internazionale dell’età moderna, nato dal sistema dei rapporti fra gli stati europei, denominato ius publicum europaeum, la guerra veniva considerata un diritto degli stati, elemento essenziale del potere sovrano. Caduta ormai la dottrina della guerra giusta, si era ritenuto che il diritto di guerra appartenesse allo stato in quanto tale, attenuato soltanto da un certo numero di obblighi da rispettare nella condotta della guerra. Cari Schmitt descrive la nuova situazione osservando che al bellum justum si era sostituito l’hostis justus, proprio il contrario di quello che accade nella guerra civile, in cui, vissuta da coloro che vi partecipano come guerra giusta, ingiusto è considerato il nemico. Le nefandezze compiute nella guerra fra gli stati dell’ex-Jugoslavia, guerra civile per eccellenza, sono di questo eccesso di violenza nei confronti del nemico una conferma che non ha bisogno di ulteriore commento.
I giuristi sanno che un divieto per essere considerato giuridico nel senso proprio della parola, o jus perfectum, deve essere fatto valere anche ricorrendo all’uso della forza. A differenza della Società delle Nazioni, lo Statuto delle Nazioni Unite aveva proposto di risolvere questo problema compiendo un passo decisivo oltre la confederazione di stati cui si era arrestata la Società delle Nazioni, dettando le norme del capitolo VII, a cominciare dall’art. 42, che prevede la possibilità di un’azione militare per mantenere la pace.
Nella Agenda per la pace, redatta dal segretario generale dell’ONU, Boutros Ghali, datata 31 gennaio 1992, si afferma: «Il Consiglio non ha applicato sinora la più coercitiva di queste misure: l’azione militare prevista dall’art. 42. Nella situazione creatasi tra l’Iraq e il Kuwait ha scelto di autorizzare gli stati membri a prendere misure in suo nome». Quindi aggiunge: «La Carta prevede tuttavia un approccio dettagliato che meriterebbe ormai l’attenzione di tutti gli stati membri».
Questo dimostra quanto sia difficile e, posso dire senza correre il rischio di essere giudicato un irriducibile pessimista, irrealistico, applicare al sistema degli stati procedure e misure che valgono all’interno di ogni singolo stato nei rapporti tra i pubblici poteri e il cittadino. Ogni stato detiene nei riguardi dei suoi cittadini il monopolio della forza legittima, un potere che non è mai esistito, non esiste attualmente e probabilmente non potrà mai esistere in futuro, nel sistema internazionale. Tanto più che un sistema in cui i soggetti componenti mantengono il potere sovrano essenziale, che è l’uso esclusivo della forza legittima al suo interno, è incompatibile con un sistema superiore, che abbia, esso stesso, il monopolio della forza. Da un lato, il sistema esterno degli stati è, per quel che riguarda l’uso esclusivo della forza, ben diverso dal sistema interno a ogni stato, e, dall’altro, il fine ultimo della guerra alla guerra, presuppone una risoluta, progressiva ed efficace, politica di disarmo. I due problemi sono connessi: il monopolio della forza dello stato presuppone il disarmo dei cittadini. Quando finisce una guerra civile la prima operazione del governo vincitore è quella di disarmare le fazioni che si erano sino allora combattute, come è avvenuto in Italia dopo la Guerra di Liberazione. Un’operazione, quella del disarmo, che allo stato riesce quasi integralmente e che, invece, al sistema degli stati non è mai riuscito se non parzialmente, limitatamente a determinate aree geografiche, e spesso soltanto temporaneamente.
Non bisogna nascondersi che la situazione di questo dopoguerra era obiettivamente difficile. La guerra era finita con la vittoria di una coalizione di alleati uniti non per amore ma per forza. In una lotta mortale fra tre sistemi in conflitto fra loro, democrazia, fascismo, comunismo, era inevitabile che fosse sconfitto quello dei tre che si era trovato di fronte coalizzati contro di lui gli altri due. Ma non era prevedibile, e di fatto non è avvenuto, che gli alleati uniti per la vittoria sul comune nemico dovessero restare uniti anche dopo, a guerra finita.
Al contrario della prima guerra mondiale, che aveva acceso la speranza di essere l’ultima guerra, la guerra che pone fine a tutte le guerre, quando finì la seconda guerra mondiale, questa speranza non si aprì agli osservatori più illuminati. Non era ancora finita la guerra calda che già cominciava la guerra fredda. La seconda guerra mondiale fu considerata da molti, tanto da una parte quanto dall’altra, non l’ultima, ma, se mai, la penultima.
Tuttavia, dopo quarant’anni di questo stato dei rapporti internazionali, la terza guerra mondiale non è scoppiata. Era dunque possibile ciò che non era mai accaduto nei secoli passati, che un conflitto tra grandi potenze finisse con la vittoria di uno dei due avversari senza che fosse necessario il ricorso alle armi.
Dopo la seconda guerra mondiale, nei rapporti fra gli stati si erano trovati, fianco a fianco senza mai incontrarsi, due sistemi di rapporti internazionali diversi: il vecchio fondato sull’equilibrio con la sola differenza che le potenze del sistema in equilibrio instabile erano ormai soltanto due e non più di due, come nei secoli precedenti, e il nuovo sistema, nato con le Nazioni Unite, che si potrebbe chiamare il sistema del «potere comune». Non solo il vecchio ha continuato a sopravvivere durante tutti quegli anni accanto al nuovo, ma nella risoluzione del conflitto tra le due super-potenze, il nuovo sistema, quello delle Nazioni Unite, paralizzato dal diritto di veto, non ha avuto nessuna parte.
La pace è stata, come si è detto, la conseguenza della fine dell’equilibrio, vale a dire del prodursi di uno squilibrio delle forze tanto grande da rendere superfluo l’uso effettivo della forza minacciata. E bastata la minaccia della forza. La rottura dell’equilibrio a favore di una delle parti ha reso inutile l’intervento esterno del Terzo al di sopra delle parti che rappresenta il potere comune. Naturalmente una soluzione pacifica ottenuta attraverso la fine di un equilibrio, per intimidazione, non può dar luogo alla «pace concordata» o consensuale, ma rischia di condurre a un altro ben noto genere di pace, che è poi quello prevalso nella storia dell’umanità, alla «pace d’impero», ovvero alla pace non concordata ma imposta, mantenuta da una potenza egemone, come sono state la «pax romana», la «pax del Sacro Romano Impero», la «pax britannica» e, negli anni del potere staliniano, la «pax sovietica», proclamata dai Partigiani della pace, che non erano in realtà pacifisti, ma fautori di una sovietizzazione del mondo.
Per quarant’anni il nuovo sistema di pace concordata, previsto dallo Statuto dell’ONU, è stato conteso dalla pace di equilibrio. Entriamo forse in una nuova fase della storia destinata ad essere contrassegnata dalla pace d’impero? La risposta è incerta, ma, di fronte al ripetersi di trattative di pace che si svolgono alla Casa Bianca, anziché nel Palazzo di Vetro, la domanda è lecita. Per contraccolpo, mentre la pace in grande è avvenuta non per effetto dell’esistenza di un potere comune, ma entro il vecchio sistema di equilibrio, molte guerre minori sono scoppiate, nonostante le Nazioni Unite, e non sono mancate all’umanità, per riprendere le parole già citate del Preambolo, «infinite afflizioni».
La verità è che, nonostante gli innumerevoli istituti di ricerca sulla pace sparsi nelle più diverse parti del mondo, non sappiamo nulla o quasi nulla delle cause delle guerre: economiche, sociali, politiche, ideologiche, religiose, nazionali e, come in questi ultimi tempi, tribali ed etniche. Ma come si può trovare il rimedio ad un male di cui non conosciamo la causa?
Difficile, dunque, evitare, tornando al principio di queste considerazioni, che i realisti paragonino le manifestazioni per la pace alle processioni che un tempo facevano i contadini per invocare la pioggia, e inducano i giornali a non parlarne. Nessuna intenzione offensiva in queste parole. Ho partecipato anch’io a marce per la pace negli anni della guerra fredda, nonostante la preferenza più volte dichiarata per il pacifismo istituzionale. Se le gambe mi reggessero, lo farei ancora. Lo farei ancora, perché? Perché so che se anche tutti i contadini del mondo si unissero per far piovere, la pioggia, qualora cadesse, non dipenderebbe dalle loro invocazioni. Non ho dubbi, invece, che, se tutti i cittadini del mondo partecipassero a una marcia della pace, la guerra sarebbe destinata a scomparire dalla faccia della terra.
15 giugno 1997




















































