Sussidio per gruppi missinari
a cura di Andrea Fontana
(NPG 1987-07-26)
1. Comunione senza confini: il gruppo aperto sul mondo
C'era una volta...
quando dal campanile
della nostra chiesa
non si scorgeva
che un grappolo di case
e pochi campi.
Oggi, stando seduti in poltrona,
penetriamo nei destini di tutto il mondo:
vediamo la profonda crisi della mitica «civiltà»
del nostro vecchio continente;
ma vediamo anche
la fame e la guerra disperata
di altri cinque continenti.
Tutto ciò
non ci fa sembrare
né piú civili
né piú cristiani di loro:
siamo cittadini
non piú di una singola patria,
ma di molte patrie,
anzi del mondo intero.
Siamo forzati
a camminare sulla strada
della cooperazione tra i popoli.
Questo è l'anima
dell'essere missionari oggi:
semplicemente uno scambio di Evangelo,
vissuto nei nostri gruppi
per dare senso alla storia universale
che ci accomuna
in un unico destino di morte o di vita.
Noi siamo consapevoli che l'eucaristia
celebrata ogni domenica nelle nostre parrocchie
è una croce innalzata sull'universo
dei continenti per condurci, solidariamente,
alla risurrezione insieme.
Che significa dunque introdurre
nei nostri gruppi
lo spirito evangelizzatore
per farlo diventare «comunità»
in movimento per la missione?
DOCUMENTI
Gli scopi della missione
«Evangelizzare è la grazia e la vocazione propria della chiesa, la sua identità piú profonda».
Come il suo Signore, la chiesa si sente riempita dello Spirito che la invia ad «annunciare ai poveri il lieto messaggio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a predicare un anno di grazia del Signore» (cf Lc 4, 18-19).
Questa buona novella vuole suscitare nel cuore e nella vita dell'uomo la conversione, che nasce dall'ascolto della gioiosa notizia del Regno di Dio, provoca l'adesione personale a Cristo Signore, dispone nella chiesa al battesimo e all'eucaristia, e si consolida nel proposito di una vita nuova.
È un cammino mai concluso perché accompagna la vita intera di una persona e la storia dell'umanità (n. 26).
Far nascere l'uomo nuovo
La missione della chiesa è salvifica perché il centro di essa è costituito dall'incontro dell'uomo con Cristo che è l'Uomo nuovo.
La chiesa proclama che in Cristo c'è la verità dell'uomo perché in lui ogni persona può rinnovarsi profondamente nella libertà e nell'amore.
La notizia dell'annuncio che la missione comunica con la Parola, i sacramenti e la carità, introduce l'uomo in quell'evento pasquale che cambia l'esistenza, la trasforma con la forza dello Spirito e la fa nuova.
Chi accoglie Gesú Cristo e si lascia investire dall'evento della sua morte e risurrezione partecipa alla sua stessa vita: non vive piú per se stesso, ma vive per il Signore.
Questa realtà misteriosa ma reale faceva dire all'apostolo Paolo: «Non sono piú io che vivo, ma è Cristo che vive in me» (n.27).
Edificare comunità
La predicazione missionaria della Parola genera nuove comunità: «La parola di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli» (AT 6,7). Il concilio Vaticano II ce lo ricorda chiaramente in questi termini: «Il fine proprio dell'attività missionaria è l'evangelizzazione e l'impiantazione della chiesa nei popoli e gruppi in cui essa non ha ancora messo radici».
Oggi le nostre comunità corrono il rischio di mortificare questo slancio missionario a motivo di problemi e situazioni difficili interni alla chiesa nel nostro paese.
Al contrario vogliamo non solo riaffermare l'importanza e la priorità della missione universale e delle specifiche vocazioni missionarie, ma anche promuovere ogni forma di cooperazione tra le chiese sparse nel mondo.
Senza questa prospettiva veramente «cattolica» e senza quest'apertura universale, le nostre comunità corrono il rischio di perdere il senso di quell'unità che si costruisce non per riduzione di interessi o per concentrazioni di iniziative, ma attraverso coraggiose dilatazioni degli spazi della carità (n.28).
Promuovetre i valori del Regno
La chiesa attraverso la missione è spinta a vivere con gli uomini per cercare con loro il vero senso della storia, rivelare il loro destino ultimo e condurli alla salvezza nel Regno di Dio.
Essa non ha di mira interessi ma è unicamente guidata dalla volontà di servire l'uomo, tutto l'uomo e ogni uomo, aprendo il suo animo a Dio e a quei valori in cui si realizza pienamente nel rapporto con lui.
Tali valori trovano espressione nello «shalóm» (pace) che è sintesi di tutti i beni: «Il Regno di Dio e infatti non è questione di cibo o di bevanda ma è giustizia, pace e grazia nello Spirito Santo» (Rm 14,17).
Sono valori che debbono essere tradotti nelle realtà storiche e incarnati nel vissuto sociale (n.29).
(Dal documento CEI Comunione e comunità missionaria, 1986)
Missione: nel Terzo Mondo o in Europa?
Le chiese protestanti hanno dichiarato che la missione esiste dappertutto: missione in sei continenti. La chiesa è in missione ovunque «dominano la miseria umana, l'aumento della popolazione, le tensioni, ovunque si muovono delle forze, ovunque esistono istituzioni rigide...», ovunque il Vangelo non si è ancora imposto, soprattutto nei centri di potere, nei movimenti rivoluzionari, nelle università, nelle città, nei rapporti tra nazioni industrializzate e paesi in via di sviluppo; in tutti questi casi la chiesa deve sviluppare la sua dinamica e portare la sua salvezza.
Questa concezione rappresenta certamente un «salto in avanti» e adatta al tempo moderno l'idea tradizionale e stantia di missione.
La precedente convinzione secondo cui le missioni sarebbero in Africa e altrove, ma non in Europa, viene continuamente messa in questione da chiunque abbia vissuto un giorno di festa o una domenica tra le comunità cristiane del Terzo Mondo e li metta a confronto con la situazione di certi paesi cristiani di antica data.
Missione significa terminologicamente «invio» e oggettivamente «chiesa in movimento»: per chi crede in Dio Padre, creatore onnipotente, in Gesú Cristo, suo figlio unigenito, e nella chiesa, l'esistenza della missione è fuori discussione; si tratta solo di discutere il come, la via e i metodi che essa deve adottare oggi. Nella misura in cui si imboccheranno nuove vie e non si insisterà su soluzioni di ieri per i problemi di oggi, anche il senso della missione diventerà trasparente. Non ci troviamo alla fine della missione, ma piuttosto all'inizio di una nuova e straordinaria epoca missionaria, o in ogni caso di fronte a un invito straordinario e globale a realizzare la missione di Cristo nel mondo d'oggi!
(W. Buhlmann, La terza chiesa alle porte, Roma 1974)
Il compito dei laici nell'evangelizzazione
I laici, che la loro vocazione specifica pone in mezzo al mondo e alla guida dei piú svariati compiti temporali, devono esercitare con ciò stesso una forma singolare di evangelizzazione.
Il loro compito primario e immediato non è l'istituzione e lo sviluppo della comunità ecclesiale - che è il ruolo specifico dei pastori - ma è la messa in atto di tutte le possibilità cristiane ed evangeliche nascoste, ma già presenti e operanti nelle realtà del mondo. Il campo proprio della loro attività evangelizzatrice è il mondo vasto e complicato della politica, della realtà sociale, dell'economia; cosi pure della cultura, delle scienze e delle arti, della vita internazionale, degli strumenti della comunicazione sociale; ed anche di altre realtà particolarmente aperte all'evangelizzazione, quali l'amore, la famiglia, l'educazione dei bambini e degli adolescenti, il lavoro professionale, la sofferenza. Piú ci saranno laici penetrati di spirito evangelico, responsabili di queste realtà ed esplicitamente impegnati in esse, competenti nel promuoverle e consapevoli di dovere sviluppare tutta la loro capacità cristiana spesso tenuta nascosta e soffocata, tanto piú queste realtà, senza nulla perdere né sacrificare del loro coefficiente umano, ma manifestando una dimensione trascendente spesso sconosciuta si troveranno al servizio dell'edificazione del Regno di Dio, e quindi della salvezza in Gesú Cristo.
(Evangelii nuntiandi, n. 70)
PER LA RIFLESSIONE
Lettura dei documenti
I documenti che presentiamo in ogni parte del sussidio servono solo per avviare il discorso; ogni gruppo e/o comunità deve reperirne altri.
Alcuni spunti per la conversazione sui documenti:
- che cosa non condividiamo di essi? - quali spunti dobbiamo ancora approfondire?
- quali proposte di nuova mentalità ci fanno?
- completare con la lettura del documento del Concilio: Ad gentes (traccia utile per la lettura Giovani vangelo e impegno missionario, LDC).
Dopo aver letto Comunione e comunità missionaria:
- preparare una mostra da offrire agli altri gruppi sulle tematiche principali emergenti oggi nelle nostre comunità;
- confezionare un audiovisivo (dia-video) che comunichi il messaggio di «comunione e missione» nel nostro quartiere, parrocchia, città.
Chiesa e missione negli Atti
Esperienza dello Spirito: At 2,1-41 (Pentecoste: unità, universalità, comunicazione):
- At 4,19; 5,29-32: libertà cristiana;
- At 4,31: libertà dell'annuncio. Esperienza della parola: At 3,1-26:
- partire dai fatti, dai bisogni della gente;
- confronto con Gesú Cristo;
- conseguenze pratiche-operative. Esperienza di comunità: At 2,42; 4,32-35: perseveranza nella:
- parola;
- comunione fraterna;
- frazione del pane;
- preghiera.
Esperienza di missione:
- iniziativa di Dio (At 13,1-3);
- protagonisti umani/missionari (At 8,4-5; 11,19-24);
- metodo/stile: universalità (At 15,7-11); accoglienza dei valori (At 14,15-18; 17,22-31).
Esperienza di comunità perseverante: At 14,21-23.
Discutiamo delle affermazioni
- «Le missioni oggi non sono piú valide perché ogni religione è buona e porta alla salvezza».
- «L'era del colonialismo è finita».
- «Predicare un'altra religione significa non rispettare le culture dei vari popoli».
- «Andare in missione è evadere dagli impegni qui».
- «I problemi del Terzo Mondo si risolvono con un nuovo ordine politico qui da noi...».
Verifichiamo l'apertura al mondo del nostro gruppo
- Quale percentuale di argomenti che affrontiamo nelle serate del nostro gruppo riguardano «gli altri», di fuori?
- Le iniziative che produciamo sono rivolte solo a far coesione tra di noi o anche ad occuparci dei problemi del mondo? Perché?
- Su quali argomenti «missionari» o mondiali sapremmo offrire un nostro contributo costruttivo particolare? Su quali non sappiamo assolutamente niente, né riusciremmo mai ad esprimerci? - Pur senza perdere la nostra identità di gruppo, che cosa potremmo fare per lasciarci penetrare un po' di piú dai problemi del mondo e dallo spirito «missionario»?
PER L'AZIONE
1. Iniziare la sensibilizzazione del gruppo:
- prendere occasione da «ottobre missionario» io «quaresima di fraternità» e proporre incontri, esperienze, cineforum;
- diffusione delle riviste missionarie, raccolta di nuovi abbonamenti, vendita di libri missionari;
- progettare d'ora in poi un incontro di preghiera mensile per le missioni;
- nel Consiglio Pastorale Parrocchiale suscitare il problema di una apertura missionaria qui e nel Terzo Mondo;
- allestire una mostra missionaria; - cercare persone da avviare ad una formazione missionaria piú approfondita per animare gli adolescenti. Per un aiuto ci si può rivolgere al proprio Centro diocesano missionario.
2. Rendersi conto che siamo privilegiati e dobbiamo restituire anche materiamlmente ciò che possediamo al Terzo Mondo.
Si prepara un grande cartellone diviso in due parti:
- da una parte si scrivono, una di seguito all'altra, ben evidenti, tutte le cose che noi abbiamo (noi «sviluppati»);
- dall'altra parte si scrivono, ben visibili, le cose che i poveri hanno (non parliamo di valori umani, ma solo di cose materiali).
Compilata la doppia lista, si prende in esame la lista che ci riguarda. Su di essa si segnano con un colore convenzionale o un segno, tutte le cose che noi abbiamo e ci provengono dagli altri, soprattutto dai paesi poveri.
Con un altro segno convenzionale si segnano le cose che noi abbiamo e causano la povertà del «Terzo Mondo», generano situazioni di sottosviluppo, di sviluppo senza beneficio per i poveri. Con un terzo segno di evidenziano quelle coseche noi possediamo e possiamo e dobbiamo condividere o restituire, per praticare almeno la giustizia a livello umano.
Se si vuole ancora, si può segnare con un quarto segno tutte le cose che ci permettiamo il lusso di sprecare.
Di fronte a questo cartellone policromo, le considerazioni possono diventare fin troppo ovvie. Importante non è avere delle reazioni emotive superficiali, ma approfondire, rendersi conto della realtà, per impegnarsi a cambiare il nostro modo di essere.
PER LA PREGHIERA
NON HO TEMPO
Sono uscito, Signore:
fuori tutti andavano venivano,
camminavano correvano.
Correvano le bici,
le macchine, i camion, la strada,
la città, tutti...
Arrivederci scusi... non ho tempo.
Non posso attendere,
ripasserò... non ho tempo.
Termino questa lettera perché non ho tempo.
Avrei voluto aiutarti...
ma non ho tempo.
Non posso accettare
perché non ho tempo.
Non posso riflettere,
leggere non ho tempo. Vorrei pregare,
ma non ho tempo.
Tu comprendi, Signore, vero?...
non abbiamo tempo...
Il bambino gioca:
non ha tempo subito... piú tardi...
Lo scolaro deve fare i compiti:
non ha tempo... piú tardi...
Lo studente ha un sacco di lavoro:
non ha tempo... piú tardi...
Il giovane ha gli allenamenti da fare:
non ha tempo... piú tardi...
Lo sposo novello
ha la casa da arredare:
non ha tempo... piú tardi...
Il padre di famiglia
ha i bambini:
non ha tempo... piú tardi...
I nonni hanno i nipotini...
non hanno tempo... piú tardi...
Sono malati! Hanno le loro cure:
non hanno tempo... piú tardi...
Sono moribondi, non hanno...
Troppo tardi!... non hanno piú tempo!...
Signore, tu che sei fuori del tempo
sorridi nel vederci lottare col tempo.
Tu sai quello che fai
e non ti sbagli quando distribuisci
il tempo agli uomini.
Stasera ti chiedo di fare coscienziosamente
nel tempo che Tu mi dai
quello che Tu vuoi che io faccia.
(M. Quoisi)
2. La missione ai laici: nuove figure di missionari oggi
Duemila anni di storia della chiesa.
Duemila anni di storia della missione.
In duemila anni milioni di missionari.
Volti diversi, esperienze diverse, stili diversi.
Ci furono missionari anonimi che, spinti dalla persecuzione,
portarono il Vangelo di città in città.
Grandi missionari che fondarono chiese e comunità.
Missionari monaci che innalzarono la tenda del Vangelo
in mezzo ai barbari e ai popoli nomadi.
Altri si donarono generosamente fino al martirio
penetrando in territori sconosciuti:
Africa, Asia, America Latina, fino ai confini del mondo.
Per molto tempo la missione fu compito di alcuni.
Finché la chiesa intera cominciò a sentirne la responsabilità:
in Italia nacquero istituti missionari
che diedero spazio a sacerdoti, laici, donne.
Fino al Concilio Vaticano II quando
la chiesa scopre di essere
per sua natura missionaria.
Soprattutto nel mondo di oggi:
le chiese locali si scoprono «sorelle», corresponsabili
e ciascun cristiano,
sulle orme di Cristo,
come Charles de Foucauld,
si sente «fratello universale».
In questa realtà sta nascendo un nuovo tipo di missionario
e nuovi modi di servire la missione e la comunione tra le chiese:
non piú il missionario
con barba fluente,
casco coloniale e fucile in mano,
non il missionario-eroe ed esploratore,
non il leggendario uomo delle foreste,
ma il missionario per il dialogo
tra le culture e le religioni,
annunciatore e operatore del Regno, uomo alla ricerca di nuovi modi
per liberare l'uomo e vivere il Vangelo, per un cristianesimo europeo, africano, asiatico,
americano e sud-americano.
Insieme per la missione
di rendere riconoscibile
il Cristo nel mondo d'oggi.
DOCUMENTI
Tre modi di essere missionari oggi
Vi è un primo modo di essere missionari oggi, e si attua nel contesto della propria chiesa d'origine (antica o giovane), andando a quei gruppi umani e ambienti culturali che non sono piú «chiesa»: non tanto per un'azione di recupero, quanto per far nascere la chiesa in realtà umane e culturali nuove (ad es., nella realtà e cultura operaia). È la missione tipica, ad es., dei preti operai e di quanti - laici, religiosi, sacerdoti - operano come «gente di frontiera» nei vari settori della vita familiare, sociale, assistenziale, politica.
La condizione generalmente minoritaria della chiesa, ormai anche nelle vecchie comunità d'Europa, e le sollecitudini di una società in rapida trasformazione, esigono che tutti i cristiani - e non soltanto alcuni - siano gente di frontiera: ogni cristiano, in forza del battesimo e della confermazione, è un inviato, un missionario nella propria realtà locale. Egli è chiamato a vivere la sua vocazione personale, secondo i vari ministeri e i vari carismi in funzione dell'unica e radicale vocazione della comunità ecclesiale alla missione, in modo attivo, necessariamente in tensione evangelizzatrice verso i «lontani» del proprio settore o ambito d'azione, perché divengano «vicini» nella fede.
Ogni cristiano è oggi chiamato ad essere in qualche modo animatore dei propri fratelli nella fede perché rompa continuamente le barriere dell'istituzione per divenire «chiesa-missione».
Il secondo modo di essere missionari oggi è quello di coloro che vanno presso un'altra chiesa locale come collaboratori pastorali, sacerdoti, religiosi, laici, per dare e accogliere le esperienze di vita cristiana e di fede, esprimendo cosí la tensione missionaria della chiesa di origine più come intercomunione di persone e di beni con le altre chiese sorelle.
Finalità caratteristica di questo tipo di servizio missionario è di aiutare la crescita pastorale di una comunità ecclesiale, perché diventi (o ridiventi) adulta.
Il terzo modo di essere missionari è quello di coloro che vanno presso un'altra chiesa locale per la prima evangelizzazione, cioè specificamente per quei gruppi umani e ambiti culturali, anche piccoli, nei quali Cristo non è ancora annunciato. Sono i missionari «ad gentes». Con questo tipo di impegno essi esprimono la corresponsabilità delle chiese locali per l'annuncio del Vangelo a tutte le genti. Per questo tipo di impegno missionario, piú che per gli altri, si esige una consacrazione a vita e una forma di vita comunitaria, come primo segno visibile della chiesa.
I missionari «ad gentes» sprimono un carisma e un ministero particolare che non sostituisce né esaurisce tutto l'impegno milionario della chiesa locale; tanto meno esaurisce l'impegno di una comunione e di corresponsabilità universale di tutte le chiese.
(da «Amico» - Istituto Missioni Consolata)
Il mare è piú grande del pozzo
Si dice che il recente disastro del Challenger abbia tarpato le ali allo spirito della frontiera, come, invece, i successi del Vojager nel fotografare il lontanissimo Urano ne avevano esaltato le prospettive.
Il mito della frontiera
Il mito della frontiera, tipico dell'ottocento degli Stati Uniti, sembra aver contagiato il mondo e la nostra civiltà: sempre protesi in avanti nel superamento di ogni tipo di fontiera. L'ignoto diventa luogo di conquista. Il diverso è luogo di conquista. Non ci sono barriere, non ci sono limiti. Il nuovo, l'inedito, l'invenzione è cercata con tutti i mezzi e tutte le forze. Immense energie vengono investite per superare sempre ogni nuova frontiera. Non importa se questo, poi, è a vantaggio di pochi. Non importa se genera disoccupazione. Non importa se altri, popoli, culture, conoscenze, spariscono. Apparentemente è una grande prospettiva per l'umanità. Ma non è da questo spirito che vogliamo imparare ad essere uomini di frontiera.
Essere uomo di frontiera
Se sei un inviato, se sei in movimento, se accetti la missione stessa di Cristo, allora non puoi non essere uomo di frontiera. E mi piacerebbe dire pure: uomo di oltre frontiera, cioè disposto ad attraversare non solo la frontiera geografica, ma tutte le frontiere che separano, che isolano, che discriminano, che chiudono. Tali sono le frontiere di religione, di razza, di ideologia, di classe sociale, di cultura, ecc.
Sei in movimento, e questo non si riduce all'ambito della tua casa, della tua comunità cristiana, del tuo popolo. Esso va oltre; questo camminare missionario non ha alcuna frontiera a cui si può fermare, come ha detto Gesú: «Mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra» (AT 1,8).
Gesú ha tolto ai suoi discepoli il «guscio» nazionale, il «guscio» etnico e il «guscio» religioso per fare di loro uomini in movimento oltre le frontiere, fino agli estremi della terra: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura» (Mt 16,15).
Il tuo impegno non ha frontiere, le sorpassa tutte perché esso è a misura dell'impegno di Cristo.
Non ti lasciare imprigionare da nessuna frontiera che significhi chiusura nel tuo piccolo mondo, rigidità, immobilità o discriminazione.
Era sempre vissuta nel piccolo pozzo. La rana, dalla nascita, non ne era mai uscita.
Quando un'altra rana, che veniva dal mare, si avvicinò al pozzo, fecero due chiacchiere.
- Da dove vieni, disse la rana nel pozzo.
- Vengo dal mare.
- E quel tuo mare è piú grande del mio pozzo?
- Senz'altro. Dovresti vedere. È cosí grande che i suoi confini non si vedono.
- Vuoi dire che c'è piú acqua là, da te, che nel mio pozzo?
- L'acqua del mare è quasi infinita.
- Non ci credo. Tu mi stai ingannando. Come puoi dire che c'è piú acqua là che nel mio pozzo? Come puoi provare che il tuo mare è piú grande del mio pozzo? Non venire a raccontarmi storie, bugiarda.
- Non ti illudere, viene a vedere, ti invito ad uscire.
- Non ne vale la pena. Tu mi inganni.
E dicendo questo, si tuffò nell'acqua del suo pozzo, oltre il quale riteneva non ci fosse niente di valido da sperimentare.
Non accettare di rimpicciolire lo spazio della tua missione.
(da «Amico» - Istituto Missioni Consolata)
Volontariato internazionale: dove stiamo andando?
Crediamo di essere abbastanza coscienti dei cambiamenti che stanno avvenendo nel volontariato internazionale. Non solo, ci rendiamo anche conto che si tratta di mutamenti sostanziali e non formali. Toccano le motivazioni e i contenuti del volontariato. Siamo però anche coscienti del fatto che il vero problema non è il volontariato, ma il malsviluppo, che tocca sia i paesi poveri che i paesi ricchi. Quando parliamo di malsviluppo non vogliamo fare della «teoria», intendiamo parlare dei problemi che investono milioni di persone che nel mondo soffrono la fame, la malnutrizione, la mancanza di libertà, la tossicodipendenza, la disoccupazione, la contaminazione dell'aria e dell'acqua.
Problemi questi, presenti sia nei paesi dell'emisfero nord, che in quelli dell'emisfero sud.
È questa la piattaforma comune, la base che mette sullo stesso piano i paesi del Nord e del Sud. E questa piattaforma è il malsviluppo. Partendo da questa comunanza di problemi bisogna operare per umanizzare le relazioni e il dialogo tra i popoli, e riteniamo che questo sia il compito specifico delle' ONG, Organizzazioni Non Governative e popolari: partecipare cioè alla trasformazione, al cambiamento delle strutture che oggi rendono disumane le relazioni tra i popoli.
Lo specifico delle ONG
Nel panorama vasto e complesso della Cooperazione Internazionale le ONG hanno un loro specifico da esprimere, da potenziare: la loro radice popolare; è questa che dà linfa, che permette di vivere e concretizzare la loro filosofia, la loro politica.
E però, questo specifico popolare le rende anche vulnerabili, continuamente in fase di confronto dialettico con la società ove operano e ove devono confrontarsi e a volte contrapporsi.
Esaminiamo due tipi di organizzazioni non governative.
Il primo tipo di ONG sono quelle che realizzano progetti, con volontari o senza. Il loro intervento è passato dalla microrealizzazione ai progetti unisettoriali e plurisettoriali. Oggi questi organismi stanno riflettendo su come questi progetti sono realizzati e sui loro metodi di valutazione. Inoltre si rendono conto che per realizzare progetti di sviluppo bisogna far fronte a spese elevate e per questo stanno vedendo aumentare considerevolmente la loro dipenenza dai fondi pubblici, con il rischio di perdere la loro base popolare.
Il secondo tipo di ONG, piú raro, è composto da quelle che integrano l'azione di cui sopra con un lavoro di «educazione alla mondialità».
Per esse il malsviluppo si vince anche con un cambiamento di mentalità, con una trasformazione delle strutture che rendono ingiusti i rapporti internazionali.
Questo significa anche produrre sussidi (fascicoli, audiovisivi, ecc.) e, pur tenendo conto delle molte forme di lavoro benevolo che un organismo riesce ad esprimere, questi necessitano di finanziamenti.
Purtroppo, per questo settore è molto difficile riuscire a reperirli. La nostra esperienza ci dice quanto questi sussidi siano importanti.
Gli organismi di volontariato internazionale sono quelli che vivono maggiormente il cambiamento in atto.
Essi si trovano di fronte ad alcuni interrogativi.
Se tutti i popoli sono in una situazione di «malsviluppo» e questo si deve combattere con la compartecipazione, cioè la partecipazione di tutti, l'invio dei volontari deve trasformarsi in una relazione che va nei due sensi?
Ad esempio, persone dei paesi del Sudinserite per periodi determinati a lavorare nelle nostre organizzazioni. Si tratterà di trovare dei finanziamenti, tipo borse di studio, per permettere ad animatori africani o latino-americani di effettuare un servizio di volontariato presso di noi.
Forse in questo modo ci renderemo conto di che cosa significhi per i nostri partners ricevere volontari che non sono stati selezionati da loro stessi.
Allora si potrà parlare di scambio tra i popoli.
Per quanto riguarda i progetti, è arrivato il momento di adottare come metodo l'inserimento di nostri volontari in progetti che la popolazione locale ha già avviato e che necessitano di essere potenziati.
Sappiamo che queste condizioni non si riscontrano in tutti i paesi, pertanto regole rigide da applicare ovunque e comunque sono piú pericolose che utili.
È però necessario che una politica di partecipazione allo sviluppo sia adottata tenendo conto di quelle che sono le esigenze dei nostri partners e le loro possibilità di coinvolgimento in un processo di autosviluppo.
I volontari
Che tipo di volontario parte oggi? Quali sono le motivazioni che lo spingono?
I candidati che oggi si presentano chiedendo di partire, generalmente non portano etichette, rappresentano la gente comune, sono diversi da quelli che negli anni '70 si presentavano con forti motivazioni politiche o religiose.
Di quali valori sono portatori?
I volontari oggi sono spesso chiamati ad operare in progetti dai costi elevatissimi, sono aumentate le responsabilità di gestione.
La buona volontà non è piú sufficiente, deve essere accompagnata da una seria professionalità.
Che dobbiamo ritrovare anche negli organismi.
Una domanda sorge di conseguenza. Che tipo di volontariato è questo?
È il volontariato del futuro o è la sua fine?
Cerchiamo pure una risposta a queste domande, ma non dimentichiamo che il problema è un altro: utilizzare uno strumento che ci permetta di incidere sui processi ingiusti che attualmente regolano i rapporti internazionali.
È anche vero che siamo convinti che lo sviluppo si realizza con le persone e non con le cose. Sono gli uomini i protagonisti di ogni cambiamento veramente significativo.
Proviamo a far incontrare le persone, avviciniamo le culture, facciamo in modo che i popoli si conoscano.
Su questa base sicuramente gli organismi non governativi hanno qualcosa da dire.
(Mario Fornero, da «Volontari per lo sviluppo», giugno 1986)
PER LA RIFLESSIONE
Documenti e ricerca biblica
L'analisi dei documenti può aiutare il gruppo a formarsi un'idea del nuovo volto del «missionario» e degli ambiti in cui oggi viene a trovarsi.
Si può pertanto discutere sui seguenti punti.
- Quale stile di missionario presentano i documenti citati?
- A partire dal documento n. 2 («Il mare è piú grande del pozzo») individuare le «frontiere» che il gruppo missionario deve superare.
- Elaborare uno schema su un cartellone che dia tutti i significati che il termine «missionario» può avere (ad esempio: missionario «ad gentes», missionario nel quartiere, missionario laico, volontariato, ecc.): cf la tipologia nel documento CEI «L'impegno missionario della Chiesa italiana».
Per quanto riguarda la ricerca biblica: leggere e riflettere sulle grandi vocazioni missionarie presentate nella Bibbia: Mosè, Abramo, Apostoli, san Paolo; anche il discorso di Gesú in Mt 10:
- quali sono le caratteristiche essenziali del missionario presentate in questi brani?
Revisione personale di vita
- Come vivo la dimensione missionaria della mia fede: testimonianza, attività concrete, interesse generico?
- Come concretizzo la mia vocazione ad essere missionario? Nel mio ambiente? Oppure ho pensato di «partire»?
- E se io fossi chiamato a partire come sacerdote, come laico per il Terzo Mondo? Come reagirei? E la mia famiglia? Che cosa vorrei fare laggiú?
- Mentre intanto non parto, che cosa posso impegnarmi a fare per vivere uno stile di vita cristiano e missionario qui?
PER L'AZIONE
Proponiamo due attività, alla scoperta di ciò che c'è al di là della frontiera.
1. La prima è una ricerca: ne indichiamo i passi successivi:
- scoperta nominale dei propri missionari, quanti sono, chi sono, che fanno, perché lo fanno, ecc.;
- ordinare il tutto su un cartellone, magari con foto, mettendo i nomi con tutte quelle informazioni che li fanno conoscere a tutti;
- fare una o piú interviste a questi missionari; se sono a portata di microfono intervistarli direttamente, altrimenti scrivere, spiegando prima il perché della vostra lettera e di tutte le domande che fate;
- mettersi in contatto con dei missionari se non ce ne sono della vostra propria comunità parrocchiale, informarsi al Centro missionario diocesano e mettersi in contatto con quelli originari della diocesi e scrivere loro intervistandoli sul tema della «donazione», della «missione», sul significato e sul valore di donare la propria vita per gli altri;
- in caso che non sia possibile fare tutto questo si possono organizzare degli incontri di riflessione e di dibattito usando filmini o diapositive missionarie o esperienze di missione piú in ambienti di frontiera (tossicodipendenti, disoccupati, bande giovanili...).
2. La seconda attività che proponiamo è un'indagine: un'indagine sulla propria città per conoscere la realtà oltre la frontiera del proprio gruppo:
- che cosa pensano e come vivono le altre aggregazioni di giovani;
- quali settori della città (categorie sociali, ambienti...) sono da «evangelizzare»;
- con quali possibilità si può «andare» da loro per aprire un dialogo, una collaborazione, uno scambio.
Esprimere una sintesi dell'indagine su un cartellone.
PER LA PREGHIERA
COSA VUOI, SIGNORE, CHE IO FACCIA?
C'è un disegno di Dio sulla mia vita.
C'è un posto anche per me
a servizio del Regno.
Se mi rifiuto, nessuno mi può sostituire.
Se dico «no», si apre un vuoto nel mondo.
Dio ha già posto il suo seme
nel mio cuore.
La mia povertà non mi può spaventare.
Dio ha dato talenti alle mie mani.
Qualcuno mi aiuta a farli fruttare per lui?
La parola di Dio è luce sul mio cammino.
Cristo è l'amico che mi apre la strada.
La Chiesa, moltitudine di fratelli,
mi accompagna.
Lo Spirito di Dio dà forza ai miei passi.
Posso offrire un terreno generoso.
L'occhio attento ai segnali di Dio.
L'orecchio in ascolto del grido del fratello.
Un cuore che si lascia educare dall'Amore.
Qual è il mio posto nel banchetto della vita?
Ho la pazienza del contadino
che attende la messe?
Ho la fiducia di chi non si sente solo.
Mi apro alla domanda e alla preghiera.
3. Il futuro di Dio incombe: che cosa evangelizzare
Il servizio che la chiesa deve rendere al mondo
non è un'attività di conquista o di proselitismo,
ma la risposta al comando di Cristo
di «fare la Pasqua in memoria di Lui»,
un debito da pagare al suo Amore
e insieme una risposta
ai processi storici di liberazione e di umanizzazione,
una risposta al cammino verso un cristiano
a dimensione universale che dentro la storia di oggi
scorge i «segni del Regno»,
l'uomo nuovo che nasce dalla rovina delle nostre civiltà.
Qui, come nel cosiddetto Terzo Mondo:
la missione non è soltanto partire,
la missione è una dimensione essenziale al cristiano,
è l'anima di ogni chiesa o parrocchia.
Essere missionario significa riscoprire l'urgenza
di dare delle risposte
alle sfide che i popoli di oggi lanciano alle chiese di oggi.
Anzi lo Spirito Santo ci precede
per indicarci nella storia il cammino verso il Regno,
là dove a causa delle nostre paure
o a causa del nostro gretto immobilismo
non abbiamo ancora avuto il coraggio di arrivare.
Là il futuro di Dio è già cominciato.
Non noi aspettiamo il ritorno di Cristo, ma Cristo aspetta noi,
in compagnia di atei, peccatori, cinesi, africani...
Quando apriremo gli occhi
e riconosceremo Cristo che bussa alla nostra porta
per camminare insieme verso il Regno?
DOCUMENTI
Ri-evangelizzare l'Italia
Apriamo un giornale qualsiasi di un giorno qualsiasi della settimana. Non c'è da stare molto allegri.
L'umanità intera è minacciata da segni di morte: attentati contro la vita (guerre, pericolo nucleare, corsa agli armamenti, terrorismo, gente condannata a morire di fame, aborto, eutanasia); violenze di ogni genere contro la dignità e l'integrità della persona umana (deportazioni, torture, sequestri di persone, droga, disoccupazione, emarginazione sociale); dilagante spettacolo di comportamenti contrari alla morale (corruzione privata e pubblica, attentati contro la famiglia, pornografia, prostituzione, criminalità organizzata).
Ci sarebbe da scoraggiarsi, se non si avvertisse nello stesso tempo, in tanta gente e specialmente nei giovani, il desiderio profondo di cambiare, di arrivare ad un mondo diverso, piú giusto, piú umano, costruito nella fraternità e nella pace.
Questa situazione, con le sue ombre e le sue luci, chiama in causa tutti i cristiani in ogni parte del mondo.
Anche la chiesa italiana si sente interrogata con estrema urgenza e si chiede: che risposta possiamo dare di fronte agli smarrimenti e alle attese degli uomini di oggi?
I nostri vescovi affermano che è necessaria e urgente, oggi, una nuova evangelizzazione del nostro paese. Le stesse comunità cristiane hanno bisogno di essere rievangelizzate. I battezzati devono arrivare a capire che per essere veri cristiani non basta frequentare la chiesa, andare a messa la domenica, fare un po' di bene al prossimo, mandare i bambini al catechismo, ecc. È necessario riprendere in mano la Buona Notizia e decidere che cosa vogliamo fare da qui in avanti per metterla in pratica sul serio e annunciarla ai vicini e ai lontani.
Il «nuovo slancio missionario», auspicato dai nostri vescovi, deve partire proprio dalle parrocchie e dalle diocesi. Ogni comunità deve impegnarsi a testimoniare e annunciare la Buona Notizia atutti: a coloro che già appartengono alla comunità perché siano testimoni credibili, e a coloro che sono «fuori le mura», cioè ai non credenti vicini e lontani, perché anche loro arrivino a capire e credere che tutta l'umanità è una grande famiglia di fratelli, che Dio ama e vuole salvare.
(Nota EMI sul documento CEI «Comunione e comunità missionaria»)
Evangelizzare la cultura
I cristiani prendono coscienza oggi che la cultura è diventata in senso proprio un campo di evangelizzazione. Infatti, vasti settori culturali non hanno mai accolto o rifiutano la luce del Vangelo. Cosí in nome della nostra fede e nel rispetto delle libertà, riscopriamo l'urgenza di annunciare la buona novella al mondo attuale. Il Vangelo è un fermento posto al cuore dei valori che caratterizzano una cultura e le danno un senso etico.
L'ethos da evangelizzare
Evangelizzare vuol dire discernere i valori culturali suscettibili di essere arricchiti, purificati e perfezionati dalla forza del Vangelo. Evangelizzare equivale a raggiungere l'anima stessa delle culture vive, e rispondere alle loro attese piú alte facendole crescere nella dimensione stessa della fede, della speranza e della carità cristiane.
Questo lungo e coraggioso processo di inculturazione ha il compito di trasformare i modelli di comportamento tipici di un ambiente, i criteri di giudizio, i valori dominanti, le abitudini e i costumi che segnano la vita lavorativa, il tempo libero, la prassi della vita familiare, sociale, economica, politica. Come non vederlo? Tutti questi elementi che costituiscono l'ethos di una cultura sono altrettanti terreni di inculturazione del Vangelo.
Il concilio non ha avuto esitazioni su questo punto capitale.
La fede è chiamata a esercitare un impatto reale su tutti i settori della vita comune.
Pur rispettando la giusta autonomia delle realtà terrene, i cristiani, con la loro attiva testimonianza, incarnano il Vangelo fino a trasformare effettivamente i comportamenti individuali e sociali. Cosí essi evangelizzano lo stesso ethos della loro comunità umana. Negarlo equivarrebbe a misconoscere la forza innovatrice del Vangelo.
Critica dei valori che contrastano con il Vangelo
Evangelizzare consiste, dunque, anche nel criticare e perfino nel denunciare ciò che, in una cultura, contrasta col Vangelo e intacca la dignità dell'essere umano, individuale e collettivo. La chiesa guarda con preoccupazione evangelica la distanza che si è stabilita tra se stessa e le culture moderne. Queste rischiano di rinchiudersi in se stesse, in una specie di involuzione spirituale: «La chiesa nel concilio ha riconosciuto che un solco drammatico si era scavato tra la chiesa stessa e la cultura».
Ma denunciare i valori antievangelici e antiumani che talvolta macchiano le culture, non basta. È importante soprattutto mettere in luce le attese spirituali delle mentalità attuali, gli addentellati e i punti di ancoraggio per il messaggio del Vangelo.
È una questione capitale.
Ci chiede Giovanni Paolo II: «Voi dovete aiutare la chiesa a rispondere a queste domande fondamentali per le culture attuali: come il messaggio della chiesa è accessibile alle nuove culture, alle forme odierne di intelligenza e di sensibilità? Come la cjiiesa di Cristo può farsi intendere dallo spirito moderno, cosí fiero delle sue realizzazioni e al tempo stesso cosí inquieto per il futuro della famiglia umana? Chi è Gesú Cristo per gli uomini e le donne di oggi?».
La Evangelii nuntiandi ha colto perfettamente l'intuizione apostolica che promuove l'evangelizzazione delle culture: «Per la chiesa, non si tratta soltanto di predicare il Vangelo in fasce geografiche sempre piú vaste o a popolazioni sempre piú estese, ma anche di raggiungere e quasi sconvolgere mediante la forza del Vangelo i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti d'interesse, le linee di pensiero, le fonti ispiratrici e i modelli di vita dell'umanità, che sono in contrasto con la parola di Dio e con il disegno della salvezza».
(Card. Poupard)
Evangelizzare la pace
Tra la riconciliazione già realizzata in Gesú Cristo e la pienezza dei tempi si situa il tempo della chiesa. La chiesa è in Cristo «sacramento, ossia, segno e strumento dell'unione intima con Dio e dell'unità di tutto il genere umano». Essa, che è una e universale nella varietà dei popoli e delle culture, può favorire i vincoli tra le nazioni.
Missione della chiesa e dei cristiani
Fin dal primo momento, la chiesa nascente cominciò a suscitare nei diversi popoli la coscienza dell'unità e lo spirito di riconciliazione. La ricerca e la difesa della pace ha costituito sempre nella coscienza della chiesa uno dei suoi piú grandi obblighi. E neppure nelle epoche piú oscure della storia, questa coscienza ha mancato di manifestarsi in qualche modo. Nei tempi piú vicini a noi, la dottrina e gli insegnamenti del suo magistero hanno denunciato ripetutamente i mali della guerra e hanno sollecitato le esigenze della pace.
La pace, opera della giustizia
La pace, aspirazione di tutti gli uomini e di tutti i popoli, è un dono di Dio che mediante «la croce, alzata sul mondo, lo abbraccia simbolicamente e ha il potere di riconciliare nord e sud, est e ovest». Pace non vuole dire soltanto assenza di guerra, non si riduce al solo equilibrio di forze contrarie, né nasce da un dominio dispotico, ma con ragione e pertinenza si definisce come opera della giustizia.
Non esiste vera pace, se non esiste giustizia: «La pace costruita e mantenuta sulle ingiustizie sociali e sul conflitto ideologico non potrà mai convertirsi in una pace vera per il mondo».
La giustizia si esprime principalmente nel rispetto alla dignità delle persone e dei popoli e nell'aiuto efficace alla loro attuazione. La pace, continuamente minacciata dal peccato, si deve formare nel cuore dell'uomo: «Anzitutto, sono i cuori e gli atteggiamenti delle persone che devono essere cambiati, e questo esige un rinnovamento, una conversione degli individui».
Inoltre, la pace segue i suoi propri cammini, che sono irriducibili: il rispetto al «diritto naturale delle genti», la creazione di un nuovo ordine internazionale, il rispetto degli accordi adottati, la rinuncia all'egoismo nazionalista e alle ambizioni di dominio, il cambiamento di mentalità dei popoli verso i loro presunti avversari e il dialogo come via per la soluzione dei conflitti.
In una situazione come quella in cui viviamo è molto difficile che vi siano le condizioni minime per poter parlare di una guerra giusta. La capacità di distruzione delle armi moderne, nucleari, scientifiche e anche convenzionali, sfugge alle possibilità di controllo e di proporzione. Perciò si deve tendere all'eliminazione assoluta della guerra e alla distruzione di armi tanto micidiali come le armi nucleari, biologiche e chimiche. Questo non sarà possibile senza un cambiamento di coscienza che porti a respingere la guerra e ad estirpare le ingiustizie che l'alimentano; bisogna arrivare al disarmo delle stesse coscienze.
La costruzione della pace è una responsabilità di tutti. Con questa mentalità evangelica, seguendo gli insegnamenti della chiesa e la testimonianza dei migliori cristiani, desideriamo esaminare i problemi che si pongono oggi in relazione con la pace e con la guerra, desiderosi di aiutare i cristiani e gli uomini di buona volontà ad illuminare le loro coscienza su queste complesse questioni e promuovere lo sviluppo della pace in proporzione alle loro forze.
(Documento dei vescovi spagnoli, 1986)
Evangelizzare i valori
Un altro principio dello sviluppo, in quanto attiene alla solidarietà, è la necessità di promuovere i valori che rechino veramente beneficio agli individui e alla società. Non basta raggiungere e aiutare coloro che sono nel bisogno. Dobbiamo aiutarli a scoprire i valori che li mettano in grado di costruire una nuova vita e di prendere il loro legittimo posto nella società con dignità e giustizia. Tutti hanno il diritto di perseguire e di raggiungere ciò che è buono e vero. Tutti hanno il diritto di scegliere quelle cose che elevano la vita, e la vita di una società non è in alcun modo moralmente neutra. Le scelte sociali portano conseguenze che possono promuovere come avvilire il vero bene della persona nella società.
Nel campo dello sviluppo e, in special modo, dello sviluppo dell'assistenza sono stati offerti dei programmi che pretendono di essere «liberi da valori», ma che in realtà rappresentano controvalori per la vita. Quando si esaminano programmi di governo o sistemi di aiuti che virtualmente costringono comunità e paesi ad accettare programmi di contraccezione o progetti di aborto come prezzo per lo sviluppo economico, allora bisogna dire chiaramente e con forza che queste proposte violano la solidarietà della famiglia umana, perché negano i valori dell'umana dignità e dell'umana libertà.
Ciò che è vero per lo sviluppo della persona mediante la scelta dei valori, che elevano la vita, si applica anche allo sviluppo della società. Tutto ciò che impedisce la vera libertà milita contro lo sviluppo della società e delle istituzioni sociali. Lo sfruttamento, le minacce, la soggezione forzata, il rifiuto di possibilità da parte di un settore della società a un altro, sono inaccettabili e contraddicono alla nozione stessa di solidarietà umana. Simili attività, sia all'interno di una società sia tra le nazioni, possono purtroppo sembrare ben riuscite per un certo tempo. Tuttavia, quanto piú a lungo permangono tali condizioni, tanto piú è probabile che finiscano per essere la causa di ulteriore repressione e di crescente violenza. I semi di distruzione sono già seminati nell'ingiustizia istituzionalizzata. Il negare i mezzi di un compiuto sviluppo a un qualsiasi settore di una determinata società o a una qualsiasi nazione, può soltanto portare all'insicurezza e alla tensione sociale. Ciò fomenta l'odio e la divisione e distrugge la speranza di pace.
La solidarietà, che stimola lo sviluppo integrale, è quella che protegge e tutela la legittima libertà di ciascuna persona e la giusta sicurezza di ciascuna nazione. Senza questa libertà e sicurezza vengono a mancare le condizioni stesse per lo sviluppo. Non soltanto gli individui. ma anche le nazioni devono essere in grado di partecipare alle scelte che le riguardano.
(Giovanni Paolo II, Messaggio per la XX giornata mondiale della pace, 1987)
PER LA RIFLESSIONE
Presentiamo cinque piste per la riflessione (personale e di gruppo) sul tema di questa unità:
- Circa i documenti riportati: elaborare, dopo una lettura e un esame attento di essi, un elenco di urgenze che il mondo d'oggi pone alla missione dei cristiani, sia nelle nostre comunità sia nel Terzo Mondo.
- Documenti suggeriti: integrare la riflessione con la lettura dell'esortazione apostolica «Evangelii nuntiandi» di Paolo VI (reperibile in qualsiasi libreria cattolica).
- Alcune domande: quali direzioni di intervento propongono alla nostra comunità i documenti letti? quali motivazioni ci propongono per metterci «in stato di missione»?
- Procurarsi il fascicolo «La pace non c'è... costruiamo la pace» (FOCSIV, via Stradella 10 - 20120 Milano). Dopo averlo esaminato a gruppetti, si può lavorare per esprimere su cartelloni cifre e problemi sulla pace, e passare in rassegna le vie d'uscita a cui possiamo partecipare come giovani: la difesa popolare non violenta; obiezione di coscienza al servizio militare; obiezione fiscale alle spese militari; obiezione professionale; servizio civile nel volontariato internazionale; l'anno di volontariato sociale; la non-violenza.
- Missioni «a casa». Una grande realtà di emarginazione e di sofferenza sta toccando oggi l'Italia: la presenza di stranieri in gran numero, la cui vita non è certo facile.
Cosa si può fare concretamente per i profughi, per gli studenti esteri, per gli immigrati clandestini, per gli emigranti della speranza, per tutti quei «forestieri» che bussano alle porte di casa nostra?
PER L'AZIONE
Vi sono alcune occasioni «d'oro», momenti forti, in cui tutta la comunità cristiana è chiamata a riflettere per farsi carico dei problemi dell'evangelizzazione e della missione. Un gruppo a dimensione missionaria non se li lascerà sfuggire, sia come momenti di particolare impegno per sé, sia per allargere a tutta la comunità cristiana tali momenti.
I grandi appuntamenti
- 6 gennaio, Epifania: giornata mondiale dell'infanzia Missionaria (indetta dalle Pontificie opere missionarie): si celebra durante il periodo natalizio e invita i fanciulli e i ragazzi alla riflessione, alla preghiera e all'offerta per i coetanei del mondo (cf anche la carte dei diritti dei bambini dell'UNICEF);
- 18-25 gennaio, Ottavario di preghiere per l'unità dei cristiani: occasione per sottolineare il dialogo ecumenico alla ri
cerca di una reale cooperazione tra le Chiese separate e allenamento alla tolleranza verso le religioni e tutti i valori positivi delle culture diverse dalla nostra;
- ultima domenica di gennaio, Giornata mondiale dei malati di lebbra.
Soprattutto ci sono due periodi che si prestano a varie iniziative per una presa di coscienza missionaria:
- Ottobre missionario, che richiama soprattutto il compito di evangelizzazione;
- Quaresima di fraternità, che richiama soprattutto la solidarietà umana.
Le occasioni di calendario vissute in maniera profonda, possono costituire il lancio di una programmazione, fatta sull'arco dell'anno intero, con iniziative differenziate (cf l'ultima parte del presente sussidio) e con una revisione per tirare le fila e iniziare un nuovo cammino.
PER LA PREGHIERA
PREGHIERA PER L'ANNO 2000
Anno Duemila.
Tempo di paura o primavera d'amore?
Atomo: trionfo dell'uomo o patibolo dell'umanità?
Signore, aiutaci!
Detentori ormai di una particella
della Tua potenza,
eccoci davanti a Te, deboli, fragili,
piú poveri che mai, vergognosi
delle nostre coscienze rattoppate
e dei nostri cuori a brandelli.
Signore, abbi pietà di noi!
Noi abbiamo costruito chiese,
ma la nostra storia
è una guerra senza fine;
noi abbiamo costruito ospedali, ma noi,
per i nostri fratelli,
abbiamo accettato la fame.
Perdono, Signore,
per la natura calpestata,
per le foreste assassinate,
per i fiumi inquinati...
Perdono per la bomba atomica,
il lavoro a catena,
la macchina che divora l'uomo
e le bestemmie contro l'Amore.
Noi sappiamo che Tu ci ami
e che a questo amore, noi dobbiamo la vita.
Strappaci dall'asfissia dei cuori
e dei corpi.
Che i nostri giorni non siano piú deturpati
dall'invidia e dall'ingratitudine,
dalle terribili schiavitú del potere.
Donaci la felicità di amare il nostro dovere.
Nel mondo mancano milioni di medici:
ispira i Tuoi figli a curare;
nel mondo mancano milioni di maestri;
ispira i Tuoi figli ad insegnare;
la fame tormenta i tre quarti della terra;
ispira i Tuoi figli a seminare;
da cent'anni gli uomini hanno fatto
quasi cento guerre:
insegna ai Tuoi figli ad amarsi.
Perché, Signore, non vi è amore
senza il Tuo Amore.
Fa' che ogni giorno, e per tutta la vita,
nella gioia, nel dolore, noi siamo fratelli,
fratelli senza frontiere.
Allora i nostri ospedali
saranno anche le Tue cattedrali,
e i nostri laboratori
i testimoni della Tua grandezza.
Allora, non accettando altre tirannie
che quella della Tua Bontà,
la nostra civiltà martoriata dall'odio,
dalla violenza e dal denaro,
rifiorirà nella pace e nella giustizia.
(Raoul Follereau)
4. Costruire un gruppo a dimensione missionaria
I nostri gruppi hanno mille problemi quotidiani da risolvere;
sulle scrivanie si ammucchiano circolari, ciclostilati, pubblicazioni...
Di tutti, su tutto.
«Parlare delle missioni?
Ma la missione è qui!»
«Suscitare vocazioni missionarie? Ma è qui
che abbiamo bisogno di preti!»
Fare tale affermazioni significa denunciare
di essere attaccati ad una mentalità
che privilegia l'avere sull'essere,
che pensa ancora alla missione
come a un abbandono
per «partire»...
Abbiamo capito nelle pagine precedenti che non è cosí.
«C'è piú gioia nel dare che nel ricevere; quello che io ho te lo dò...».
Ha di piú chi dona di piú.
E poi ci sono i proclami ufficiali: i documenti della chiesa
che affermano con chiarezza l'universalità della missione
e che la chiesa è missionaria
per natura.
Allora?
«Fidei donum», «Ad gentes», «L'impegno missionario
della chiesa italiana», «Comunione e comunità missionaria»
sono documenti che denunciano l'incoerenza di tutti.
Perché dunque starcene
nel chiuso delle sacrestie
o radicati alle nostre diocesi d'origine?
Se riusciamo a combinare poco qui non è perché ci mancano preti o suore,
ma perché dobbiamo rivedere
la nostra mentalità.
L'apertura missionaria permetterà
di respirare aria nuova ai nostri gruppi
e anche di ricevere certo piú di quanto daremo: sicuramente.
DOCUMENTI
Obiettivi per un impegno missionario
Nel contesto di una chiesa tutta missionaria, in cui ogni membro e ogni comunità è soggetto e destinatario della missione, si rivelano piú chiari gli obiettivi di un impegno missionario. Essi mirano a porre veramente la comunità ecclesiale in tensione missionaria attraverso un dinamico processo di consapevolezza e di azione.
Una prima tappa di questo processo consiste nella formazione di una coscienza missionaria. Essa è una mentalità e un'attitudine convinta, per cui il credente e la comunità cristiana si sentono chiamati ad irradiare la propria fede, a rendere conto agli altri, in qualsiasi situazione, della speranza che è in loro. Questo, in forza del loro stesso essere cristiani, essere chiesa. Il discepolo di Cristo è di per se stesso un apostolo, un inviato; la chiesa è convocata per essere mandata.
La coscienza missionaria si traduce poi nella testimonianza della vita e delle opere, cioè nell'assunzione di un modo di essere presenti e attivi nel mondo che edifichi il Regno di Dio. Qui l'animazione ha il compito di rivelare tutto il senso e il valore missionario che ha il vivere da cristiani nell'esistenza di ogni giorno, secondo la vocazione propria di ciascuno, nell'ambiente umano ed ecclesiale in cui si è inseriti. È un punto fondamentale della missionarietà da recuperare in pienezza. Troppi cristiani, gruppi o comunità, pensano ancora di operare missionariamente solo quando si occupano di precise iniziative missionarie e dimenticano che la testimonianza di una vita autenticamente cristiana è la prima ed indispensabile evangelizzazione. «L'uomo contemporaneo ascolta piú volentieri i testimoni che i maestri... e se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni».
Dalla testimonianza occorre passare all'annuncio del Vangelo nel nostro ambiente. In un'epoca in cui la missione come primo annuncio tocca in qualche modo tutti i continenti, la nostra chiesa «abbia la piena coscienza di essere inviata anche a coloro che non credono in Cristo e convivono nello stesso territorio». Siapre qui un campo vasto per un lavoro di prima evangelizzazione o rievangelizzazione in Italia, forse ancor troppo disatteso da noi. Come potrebbe essere credibile una chiesa che volesse evangelizzare altrove e non in casa sua? L'animazione missionaria ha l'obbligo di affermare, che «la missione è pure qui, che la nostra chiesa, non altre, ne è la prima responsabile, con tutte le sue forze vive.
Con tutto ciò rimane inalterato nella sua necessità ed urgenza primaria il compito dell'annuncio del Vangelo a tutte le genti e della cooperazione con le altre chiese. Un compito formidabile per la massa delle persone cui si rivolge, per la varietà dei popoli e delle culture che incontra, per le difficoltà e i problemi che pone, per la scarsità di uomini di cui tuttora dispone. Perciò questa missione universale incombe su tutte le chiese e costituisce il mandato di Cristo per eccellenza.
Forme e mezzi di animazione e cooperazione
Vista come dimensione essenziale del cristiano e della comunità ecclesiale, inserita e integrata pienamente nella pastorale, la missione esige molteplici mezzi di animazione e di cooperazione.
Un posto privilegiato spetta alla cooperazione missionaria spirituale, che si esplica mediante la preghiera, la sofferenza, la testimonianza di fede e di vita cristiana. La chiesa dei primi tempi è stata esemplare in questo senso, sostenendo il compito dell'evangelizzazione con l'orazione assidua, il coraggio nelle prove e persecuzioni, l'irradiazione di un'esistenza rinnovata dalla carità, come aveva chiesto il Maestro e Signore.
La conoscenza della realtà missionaria è un'altra forma indispensabile di animazione e di cooperazione. Essa deve tendere non solo a informare, ma a formare le coscienze dei fedeli e delle comunità. A questo servono la predicazione, la catechesi, le testimonianze dei missionari o di chi ha avuto esperienze e contatti con essi, ma soprattutto, nel mondo attuale, i diversi strumenti di comunicazione sociale. L'interesse missionario si rivela autentico quando si trasforma in gesti concreti di servizio e di donazione. Per le missioni, il popolo cristiano ha sempre dato con generosità e creatività. Dall'offerta tradizionale si è giunti all'attuazione di molteplici iniziative che spesso vanno al di là del soccorso materiale, per tradursi in un dono piú profondo e personale. È fondamentale mettere l'accento sullo spirito con il quale si dona, perché ciò che si dà risponda a una convinzione interiore e sia in coerenza con tutta un'impostazione cristiana di vita. Va sottolineato anche che al dono fatto corrisponde sempre un dono ricevuto, in forza di quello scambio di beni che scaturisce dalla missione, in quanto comunione e partecipazione.
La promozione delle vocazioni missionarie è il cuore di ogni animazione perché diretta a suscitare l'elemento primo e indispensabile della missione. L'annuncio del Vangelo domanda annunciatori, la messe richiede operai, la missione vuole missionari.
(da «L'impegno missionario della Chiesa Italiana», CEI 1982, nn. 33-34)
Uno schema di pastorale missionaria
1. Costruire un gruppo missionario: un itinerario percorribile;
- proposte e/o esperienze significative;
- formazione degli animatori;
- piano pastorale e programmazione di tempi di realizzazione;
- iniziative di sensibilizzazione e di «aggancio»;
- emersione del gruppo.
2. Animazione missionaria delle comunità. Dare una dimensione missionaria:
- alla liturgia, soprattutto nelle occasioni privilegiate;
- alla catechesi, educando alla mondialità ed a gesti concreti di solidarietà;
- ai gruppi di ragazzi ed adolescenti, proponendo esperienze missionarie;
- nei gruppi familiari, vivendo la solidarietà verso tutti;
- dando il primo posto alla evangelizzazione nella pastorale;
- realizzare un dialogo con i lontani, altre religioni, altre culture.
3. Attività del gruppo di animazione missionaria:
- diffusione di riviste missionarie;
- formazione e preghiera;
- giornate, mostre, recitals, ecc;
- solidarietà economica e gemellaggi;
- collegamento con i missionari con lettere e fotografie;
- gestione dell'«Ottobre missionario» e «Quaresima di fraternità»;
- campi di lavoro;
- animazione della realtà parrocchiale: ragazzi e giovani, quartiere, emarginati.
PER LA RIFLESSIONE
Proponiamo tre piste.
* I documenti: dopo l'esame e la discussione attenta dei documenti e dello schema presentato nelle pagine precedenti:
- formulare degli obiettivi precisi e concreti per i prossimi mesi nel gruppo: quali settori della missione privilegiare, quali iniziative mettere in cantiere...;
- individuare alcune iniziative di sensibilizzazione piú adatte all'ambiente e metterle in calendario ogni anno, curandole bene e inserendole nel piano pastorale della parrocchia;
- avviare il discorso per una vigorosa evangelizzazione dei nostri ambienti.
La crescita della sensibilità missionaria può essere vissuta anche attraverso l'informazione: oltre ai documenti già citati nelle pagine precedenti, si possono consultare i vari numeri delle riviste missionarie presenti sul mercato (Mondo e Missione, Nigrizia, Missione oggi, CEM mondialità, Terzo Mondo Informazioni, Amico...) o il Regno (Attualità, Documenti), sempre attento alle dimensioni di evangelizzazione, missione, valori mondiali...
* Inchiesta: per programmare sul concreto della situazione, elaborare un questionario e avviare una ricerca di mentalità nel quartiere: che cosa pensa la gente dei missionari, che cosa ne dice degli aiuti al Terzo Mondo, quali informazioni possiede e dove le attinge sulle situazioni di povertà, fame, sottosviluppo; se conosce le altre religioni; che cosa pensa del nucleare, della pace, dei tossicodipendenti, ecc. I risultati possono essere pubblicati sul giornale della parrocchia o su un volantino.
* Animazione: revisione delle proposte che si fanno ai gruppi nel dopo-cresima per studiarne le conseguenze missionarie: come partecipano i ragazzi, che cosa si può proporre loro...
PER L'AZIONE
Qualche spunto pratico per una presenza costante del tema missionario nelle attività di un gruppo ecclesiale.
1. Bacheca: «occhi aperti sul mondo». Una bacheca fissa, all'ingresso del luogo di ritrovo, informa mensilmente dei principali avvenimenti nella chiesa universale. Seguendo con un po' di cura le riviste missionarie, non sarà difficile avere notizie, ritagli, fotografie.
2. Preghiera. In molte parrocchie c'è l'abitudine della «Messa missionaria» mensile. I temi che toccano la chiesa universale e il mondo intero dovrebbero essere abitualmente presenti nella preghiera della comunità.
3. Solidarietà con le missioni. Su questo punto non c'è che da far lavorare la fantasia, realizzando quei metodi di raccolta di fondi che ormai tutti conoscono. Ogni comunità dovrebbe giungere a dare non «il di piú», ma una parte del suo bilancio ordinario, per sottolineare il fatto che non vogliamo essere dei privilegiati di fronte a fratelli meno ricchi di noi. In molte parrocchie si è sperimentato con successo il sistema dell'uno per cento donato da famiglie che s'impegnano a detrarlo mensilmente dal proprio stipendio.
4. Revisione della catechesi, in modo che abbia sempre presente il cristianesimo come fatto universale, le missioni come elemento vitale della chiesa. Introduzione nella scuola di religione dello studio delle principali religioni non cristiane, con l'approfondimento dei temi «dialogo fra le religioni», «dovere dell'annuncio cristiano», ecc.
5. Anche nella azione con gli ammalati, l'apertura ai temi missionari può essere di aiuto. C'è già in Italia, oltre alle forme tradizionali e sempre valide di offerta della preghiera e della sofferenza, qualche esperienza nuova: ad esempio, scambi di articoli e notizie fra riviste per handicappati italiane e giapponesi, e scambi di corrispondenza diretta fra ammalati.
PER LA PREGHIERA
AIUTAMI A VIVERE PER LORO
Signore, perdonami, perché io mi sono abituato
ad andare nei quartieri poveri;
io posso andarmene di nuovo,
ma loro no.
Signore, perdonami, perché io mi sono abituato
al puzzo degli scoli;
io posso allontanarmene, ma loro no.
Signore, perdonami, perché io posso accendere la luce,
ma dimentico
quelli che non lo possono fare.
Signore, perdonami, io posso fare
uno sciopero della fame, ma loro no,
perché essi sono già sempre affamati.
Signore, perdonami, io devo dir loro
che l'uomo non vive di solo pane,
ma non metto tutto il mio impegno
perché essi abbiano il pane quotidiano.
Signore, io voglio amarli, ma non per me.
Signore, io sogno di morire per loro,
ma tu aiutami a vivere per loro.
Signore, io voglio essere con loro,
quando verrà l'ora della Luce.
(Padre C. Mugica, assassinato il 1° maggio 1974)
VENGA IL TUO REGNO
Venga la pienezza di vita, mio Dio e Padre,
fra tutti gli uomini:
io credo nel tuo regno, Padre, anche se non lo vedo.
Esso cresce misteriosamente, per tuo dono
e per la buona volontà dell'uomo, dovunque qualcuno
ha il coraggio
di essere uomo e amare; dovunque una mamma
dà vita alla sua creatura,
un uomo spezza il pane con un uomo,
un uomo muore per un uomo.
Mio Dio, io credo al tuo seme che cresce nel silenzio,
al tuo lievito che nel silenzio fermenta tutta la pasta.
Ma non posso dimenticare la sofferenza,
le tragedie e la fame,
l'apatia e la noia di tanta gente che non sa piú
perché vivere e perché morire. Signore mio Dio,
affretta i tempi del tuo regno.
5. Educare nel gruppo a vivere la missione
E ora tocca a voi battervi,
gioventú del mondo!
Siate intransigenti sul dovere di amare.
Non cedete, non venite a compromessi, non retrocedete.
Ridete in faccia
a coloro che vi parleranno di prudenza, di convenienza,
che vi consiglieranno
di «mantenere il giusto equilibrio»,
questi poveri campioni del «giusto mezzo».
E poi, soprattutto, credete nella bontà del mondo.
Nel cuore di ogni uomo vi sono tesori prodigiosi:
a voi scovarli.
La piú grande disgrazia che possa capitarvi
è di non essere utili a nessuno,
è che la vostra vita non serva a nulla»
(R. Follereau).
Educare significa realizzare queste parole profetiche,
rispondere ad un appello vasto quanto il mondo:
educheremmo degli uomini incompleti
se non dessimo loro una sensibilità mondiale,
educheremmo dei cristiami a metà
se non li aprissimo alla missione...
Tracciare un progetto educativo, coerente e unitario,
che gradatamente permetta di aprire
i nostri gruppi ad accogliere il mondo farà sí che i nostri gruppi
escano dal ghetto e diventino un «piccolo universo»
in cui si parlano le lingue di tutti gli uomini di oggi,
dall'africano all'asiatico, dall'operaio al professore.
Non sarà difficile,
se crediamo veramente che l'altro,
soprattutto se diverso da noi, ci arricchisce.
DOCUMENTI
Una chiamata a cui rispondere
Dio chiama tutti. La chiesa nasce missionaria ed è missionaria per vocazione.
Coloro che hanno ricevuto il battesimi, con la cresima si assumono, in particolare, la responsabilità e l'impegno di annunziare Cristo ai vicini e ai lontani, ovunque.
Ma non è possibile annunziare e parlare di qualcuno senza averlo incontrato. Bisogna conoscere Cristo di persona, nel costante ascolto della sua parola, fino a trasformare le azioni e il pensiero secondo il pensare e l'agire di lui.
Ricevere un dono e offrirlo ancora
I vescovi del nostro paese, in una lettera indirizzata a tutti i ragazzi nell'Anno internazionale del fanciullo (1979), hanno indicato questo cammino di fede e questo impegno missionario di testimonianza: «Anche voi ragazzi siete capaci di far conoscere Gesú. Non dovete aspettare di diventare adulti per essere suoi testimoni. Voi desiderate un mondo nuovo, dove gli uomini siano piú buoni, piú giusti e piú onesti. Questo piace a Dio; anzi, è il suo desiderio.
«Che cosa farai da grande?», vi domandano a volte gli adulti. Qualcuno ha già un suo progetto, altri non ancora.
Una cosa è sicura: Gesú continuerà a chiamarvi, ogni giorno. Vi farà nascere nel cuore desideri grandi e progetti stupendi. Aprirà i vostri occhi ai bisogni dei fratelli e vi chiederà di impegnarvi per loro.
Tra voi ci sono i futuri genitori, i futuri operai e contadini, insegnanti e medici, i futuri sacerdoti, i religiosi, le suore.
Ognuno, domani, come oggi, avrà un posto e una missione da compiere. E ogni missione è grande e deve essere rispettata. Il mondo nuovo che già oggi cominciate a costruire, lo costruirete anche domani, se userete sempre per il bene di tutti, i doni che il Signore vi dà>i.
Comunità missionarie
Nessuna comunità cristiana può considerare il Vangelo di Gesú un tesoro da custodire in modo geloso, solo per sé. Se la fede dei cristiani non si fa missionaria, rischia di essere falsa e ripugnante. I discepoli di Gesú dovevano andare innanzi a lui in ogni città e luogo per preparargli la strada (cf Lc 10,1-16). L'essere missionari è per i cristiani e per la chiesa un impegno preciso, fonte di vitalità e di crescita.
Credere in Gesú il Cristo è sempre un inserirsi nelle vicende della vita, un morire a se stessi, un donarsi a tutti. Per questo la fede comporta necessariamente un atteggiamento missionario.
Alla luce degli insegnamenti del Concilio Vaticano II, nella chiesa è diventata piú viva la coscienza missionaria. In molte diocesi e parrocchie si sono costituiti centri e movimenti di spiritualità e animazione missionaria.
Tra le chiese delle varie nazioni si è rinnovata una maggiore collaborazione, uno scambio di forze e di amore: missionari, preti, religiosi e laici, impegni di carità e solidarietà, confronti di esperienze diverse, esprimono la varietà e la ricchezza della missione della chiesa oggi nel mondo. i
(dal Catechismo degli adolescenti «Vi ho chiamato amici»)
Gruppi e movimenti per il Terzo Mondo
Il cristiano sa che alla sera della sua vita sarà giudicato sull'amore, ossia sulle opere di carità che avrà fatto, o non avrà fatto, verso i piú bisognosi.
È certamente impossibile ricordare tutte le iniziative nate nella chiesa per rispettare i diritti dei poveri e costruire quella giustizia che Dio, amico dei poveri, vuole per loro.
Una forma moderna, fra le piú impressionanti per ampiezza ed efficacia, è quella dei movimenti per il Terzo Mondo.
Sono formati da persone di tutte le età e condizioni, che si uniscono per conoscere i problemi e promuovere aiuti verso i popoli in via di sviluppo in Africa, Asia, America Latina, continuamente minacciati dalla fame, dalle malattie, dallo sfruttamento.
In prima fila, con una loro vocazione specifica, stanno i missionari, per i quali annunciare Gesú Cristo Salvatore vuol dire anche continuare i «segni» di amore di Gesú.
Dovunque si può amare gli altri. Solo in missione Dio fa la grazia che ogni giorno l'amore diventi eroismo. Solo chi ha visto può parlare!
Con i missionari, collaborano una miriade di gruppi formati per lo piú da laici, organizzati a livello internazionale, nazionale e locale. Sotto forma di servizio civile, alternativo a quello militare, o di volontariato permanente essi si impegnano a portare aiuto in paesi bisognosi, andando magari di persona per qualche tempo.
Contro un'immagine talvolta diffusa, occorre riconoscere che questo aiuto al Terzo Mondo viene generalmente programmato con intelligenza e profondo rispetto delle popolazioni cui si rivolge. Si è desiderosi di dare qualcosa, ma soprattutto convinti di dover ricevere dai poveri qualità di vita che l'Occidente ricco sta pericolosamente dimenticando: la sobrietà e il distacco, il senso dei valori spirituali, l'amicizia e la fraternità, il rispetto della vita.
Proprio perché influenzati dall'esperienza a favore dei poveri lontani, molti giovani hanno scoperto i poveri vicini, quelli delle periferie delle città, di certe zone di montagna ormai abbandonate. Oggi la giustizia attesa da molti riguarda il riconoscimento di diritti elementari come quello del lavoro, della casa, della salute, del tempo libero.
Per esercitare la giustizia, il cristiano deve rendersi competente nei problemi, partecipare ad iniziative di studio, riconoscere gli organismi esistenti a difesa degli indigenti, mantenendo però sempre il cuore aperto al gesto concreto di solidarietà e di aiuto nelle diverse circostanze della vita.
(Dal Catechismo degli adolescenti «Io ho scelto voi»)
Quali iniziative per gli adolescenti?
Il Signore vuole dei figli, non degli schiavi, uomini capaci quindi di dire a lui un sí generoso. Nessuno come un cristiano, perciò, gioisce per la libertà delle persone. Nessuno piú di lui avrà timore e quindi combatterà la schiavitú in tutte le sue forme: l'ignoranza, gli istinti egoistici, la dipendenza forzata da cose e persone, l'avidità di ricchezze e potenza, in una parola, la schiavitú del peccato e del male.
Iniziative di liberazione
Un primo modo consiste nel richiamare le persone sui diversi problemi e bisogni presenti nella chiesa e nella società. Una forma concreta di vasta risonanza sono le giornate che la chiesa, a livello mondiale e particolare, dedica lungo l'anno a situazioni e problemi che condizionano la vita di molta gente. Ne enumeriamo alcune: la giornata per gli emigranti, la giornata per i lebbrosi, la giornata per la pace, la giornata per la vita, la giornata missionaria. Il periodo quaresimale, e in diverse regioni anche l'avvento, viene proposto come tempo di particolari impegni di carità verso i poveri. Quello che conta però non è il solo aiuto materiale, ma il rendersi consapevoli dei problemi umani che sono alla radice della povertà, liberandosi quindi da ignoranze e da pregiudizi e rendendosi disponibili ad interventi intelligenti ed efficaci. Quanto ciò sia indispensabile lo mostra una delle forme di schiavitú fra le piú violente e quasi disperate, quella della droga, per la cui liberazione non bastano gesti spontanei di buona volontà. Analogo al problema della droga, ricordiamo quello dello sfruttamento mediante prostituzione, il lavoro minorile, il problema del recupero e reinserimento di giovani devianti.
Anche in Italia fioriscono iniziative di grande valore e di meriti indiscutibili. Ricordiamo diversi centri a favore dei tossicodipendenti; i centri di difesa e promozione della vita; i consultori familiari; le comunità di accoglienza per giovani in difficoltà; i gruppi di impegno e promozione sociale nelle borgate delle grandi città... Veramente dove c'è amore, c'è libertà per chi lo riceve e per chi lo dona. Perché dove sta l'amore, sta Dio.
Iniziative di comunione e di pace
Fedeli al Maestro, i cristiani, come comunità e come singoli, sono impegnati per edificare la pace nel mondo. Per questo essi prendono iniziative concrete, collaborano generosamente con persone e movimenti, anche non cristiani.
Non vi è certamente la comunione e la pace di Gesú, dove le persone sono discriminate a causa del loro stato di salute. Opere come quelle del Cottolengo, a Torino e in altre città d'Italia; i «piccoli rifugi» per distrofici; raccolte del sangue e donazione di organi del corpo per malati; accoglienza e valorizzazione degli handicappati nella scuola, nel lavoro; assistenza per i malati di mente; fino alla cura che molti ragazzi di loro iniziativa sanno prendere verso qualche loro compagno in difficoltà sono tante vie aperte a chiunque voglia percorrere le strade della comunione. È tipico del nostro tempo il sorgere di barriere fra le generazioni, per cui gli anziani, che vanno oggi crescendo di numero, crescono anche in solitudine e si sentono inutili. Emarginati sono pure i nomadi, i lavoratori del terzo mondo in Italia, gli sradicati per diversi motivi. Qui le iniziative non possono essere che localizzate. È facile vedere vicino alle grandi stazioni ferroviarie luoghi di aiuto; esistono gruppi di giovani che si impegnano a ridare valore alla presenza degli anziani nella società.
Che dire di quella barriera mostruosa fra popolo e popolo che è la guerra, piú o meno estesa, ma sempre dolorosa e portatrice di morte? Si può affermare che oggi, nell'era nucleare, non si è cristiani se non si ha una mentalità di pace e non si fanno le opere della pace. Ormai da una decina di anni, il papa incita i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà a vivere il primo giorno dell'anno, come una giornata dedicata alla riflessione e alla preghiera per la pace. Molti ragazzi, in diverse diocesi italiane, formano gruppi che lavorano per la pace, con interventi efficaci contro le divisioni presenti nella comunità, sotto forma di razzismo, di odio, di emarginazione, di tensioni violente.
(dal Catechismo degli adolescenti «Io ho scelto voi»)
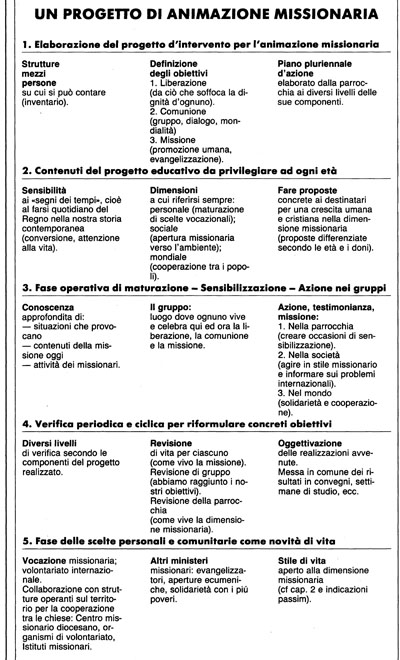
PER L'AZIONE
L'insieme delle riflessioni e delle proposte fin qui hanno fatto emergere la necessità di educarci gradualmente ad una visione delle nostre comunità come «comunione per la missione». Molto si può fare con gli adulti, ma se deve essere un cammino educativo, occorre incominciare dai ragazzi e dagli adolescenti per dare una dimensione missionaria alla catechesi, nel contesto del dopo-Cresima soprattutto.
Riteniamo a questo punto di dover solo piú aggiungere alcune osservazioni.
1. La proposta missionaria trova il suo terreno naturale solo in un progetto di «educazione liberatrice».
L'educazione liberatrice:
- trasforma l'educando in soggetto del suo proprio sviluppo;
- è creatrice, perché deve anticipare il nuovo tipo di società;
- deve essere aperta al dialogo... e promuovere la comprensione dei giovani tra di loro e con gli adutli;
- deve affermare le particolarità locali e nazionali e integrarle nell'unità pluralista del continente e del mondo;
- deve favorire la personalizzazione delle nuove generazioni e promuovere il senso comunitario;
- deve capacitare le nuove generazioni alla trasformazione permanente che lo sviluppo suppone;
- è necessaria per rimediare dalle schiavitú ingiuste a condurre i popoli da condizioni di vita meno umane a condizioni piú umane.
2. Apriamo gli occhi.
La ricerca vuole aprire i nostri occhi sulla realtà di emarginazione nel nostro stesso ambiente, in casa nostra.
Si può articolare in questi momenti:
- dibattito per coscientizzarsi e chiarire cosa si intende per «emarginato» ed «emarginazione»;
- ricerca sul campo per scoprire-censire le persone che nel proprio ambiente (quartiere o paese) vivono in una situazione di emarginazione;
- dalla ricerca si prende coscienza della loro situazione sociale e ambientale;
- si cerca di capirne le cause;
- si può procedere anche ad una duplice inchiesta tramite questionario: individuare cosa pensano di se stessi e della loro situazione gli «emarginati»; individuare cosa pensa la gente per bene della realtà degli emarginati e dei propri emarginati.
Il risultato di questa duplice inchiesta può essere sintetizzato in due cartelloni paralleli, o rifluire in un dibattito, o sul giornale parrocchiale, o essere comunicato come esperienza nella messa domenicale.
Un'altra tecnica può essere la seguente:
- disegnate una grande carta geografica del mondo da esporre nella stanza di un gruppo oppure in un luogo visibile a tutti; su di essa delimitate con colori diversi le varie zone di sofferenza;
- disegnate una carta geografica del mondo, simile alla precedente, sulla quale di limitate a vari colori la diffusione delle varie religioni del mondo;
- disegnate una carta geografica dell'Italia colorando a vari colori le zone che secondo voi sono maggiormente scristianizzate; in un dibattito cercate di individuare le cause.
3. I momenti di riflessione e di preghiera vissuti con tutta la comunità devono trovare riscontro in precise proposte di impegno. Anche qui, alcuni esempi tra molti già offerti nelle pagine precedenti;
- per ragazzi delle elementari scambio di doni. Si può fare una raccolta di «giocattoli» in favore dei bambini piú poveri, organizzare una festicciola per lo scambio di doni. Questi giocattoli possono essere dati direttamente ai bambini poveri del posto oppure una «delegazione» di bambini può portare questi doni in un orfanotrofio o qualcosa di simile, dove ci siano dei coetanei in «situazione di emarginazione». Sta agli animatori aiutare i bambini a vivere con semplicità e profondità questi gesti;
- per i ragazzi delle medie: visita agli ammalati.
Si fa una mappa degli ammalati del paese. A gruppetti di due o tre si va a visitarli. Eventualmente si privilegiano gli ammalati piú soli. Ogni gruppo dia sfogo alla sua fantasia sul che cosa fare con questi ammalati o persone molto sole. Nessuna aria di falsa compassione, ma spontaneità, creatività, capacità di ascoltare, niente fretta. Parlare insieme, scherzare, magari anche pregare insieme, scambio di doni, spiegazione del perché della visita...;
- per i giovani: festa dell'anziano.
Non si tratta di portare il «pacco doni» di Natale, piuttosto di organizzare un incontro nel quale l'anziano diventa protagonista. È importante, eventualmente, impostare un lavoro che abbia una certa continuità.
Alcune attività:
- prestarsi a fare dei lavori gratuiti all'ospizio;
- organizzare dei turni di assistenza agli anziani piú bisognosi di aiuto continuo;
- organizzare la festa dell'anziano nella quale gli anziani siano protagonisti e non solo spettatori; scenette, barzellette, ballo... e poi molto spazio per l'ascolto.
DOCUMENTAZIONE
Offriamo, per continuare il lavoro, alcuni punti di riferimento, tra i piú importanti, affinché ogni gruppo o parrocchia sappia a chi rivolgersi per continuare la sua azione.
Centro missionario diocesiano
Si propone di formare una coscienza missionaria in tutte le componenti della comunità diocesana: sacerdoti, religiosi, religiose, laici, associazioni, movimenti e gruppi. Si adopera particolarmente perché la dimensione missionaria animi gli organismi operativi della pastorale nella diocesi.
Aiuta la comunione tra i vari organismi che collaborano nell'animazione missionaria della chiesa e per il coordinamento delle iniziative missionarie.
Promuove centri di formazione, di riflessione, di preghiera e sviluppa la sensibilità ecumenica e il dialogo con le culture. Cura direttamente il collegamento della comunità diocesana con i missionari originari della medesima.
Sensibilizza la comunità diocesana perché assuma e sostenga, nella corresponsabilità e in uno spirito di vera comunione, scambio e dialogo, un servizio di cooperazione con le chiese sorelle.
Potete contattare il centro missionario nella curia vescovile della vostra diocesi che vi fornirà tutto ciò che desiderate per l'animazione missionaria.
Organismi di volontariato internazionale
La federazione che riunisce la maggior parte di questi organismi ha sede a Milano, via Stradella 10, tel. (02)22.04.60; oppure a 00165 Roma, Via Palombini 6 tel. (06)62.23.494.
Altri indirizzi di organismi di volontariato che potete invitare per una sensibilizzazione o un confronto:
- CISV: Comunità impegno servizio volontariato, Corso Chieri 12-16, 10132 Torino, tel. (011)894307;
- CLMC: Comunità laici missionari cattolici, Via Bruno Buozzi 19A, 16126 Genova, tel. (010)256628;
- CPS:Comunità promozione sviluppo, Via M. Natale 8, 80069 Vico Equense, tel. (081)8799928;
- CUAMM: Collegio universitario aspiranti medici missionari, Via S. Francesco 126, 35111 Padova, tel. (049)31106;
- LVIA: Associazione laici volontari, Via Meucci 36, 12100 Cuneo, tel. (0171)62558;
- MLAL: Movimento laici America Latina, P.za Pasquale Paoli 3, 00186 Roma, tel. (06)6569963;
- VIS: Volontariato internazionale per lo sviluppo, P.za Conti Rebandango 22, 10155 Torino, tel. (011)264527.
Movimenti
- MEM: Movimento giovanile missionario delle PP.00.MM., Via Propaganda 1, 00187 Roma, tel. (06)6795916;
- LMS: Lega missionaria studenti, Via degli Astalli 16, 00186 Roma, tel. (06)679.77.55;
- MGM: Movimento giovanile missionario, Via Levico 14, 00100 Roma, tel. (06)86.70.80;
- SERMIG: Servizio Missionario Giovani, Via Arcivescovado 12, 10121 Torino;
- OMG: Operazione Mato Grosso, Centro salesiano, 20020 Arese.
Audiovisivi
- Messis Film (Missionari della Consolata), Viale delle Mura Aurelie 12, 00165 Roma, tel. (06)63.66.10;
- Messis Film (Missionari Comboniani), Via L. Lilio 80, 00143 Roma, tel. (06)59.13.455;
- Oltremare Film, Via S. Martino 8, 43100 Parma.
A queste editrici si può richiedere il catalogo della loro produzione per scegliere ciò che interessa.
Produzione sulle missioni si può trovare anche presso:
- LDC, C.so Francia 214, 10096 Leumann (To), Tel. (011)9591091. (Serie «Esperienze missionarie»);
- San Paolo Film, Via A. Pio 75, 00145 Roma, tel. (06)51.32.941;
- PP.00.MM. Audiovisivi, Via Levico 14, 00100 Roma, tel (06)86.70.80.
Biblioteche
Centri di informazione libraria sui temi Terzo Mondo e missione:
- Biblioteca Lega Missionaria Studenti, Via Astalli 16, 00186 Roma, tel. (06)6797755;
- Biblioteca Mani Tese, Via Cavenaghi 4, 20149 Milano, tel. (02)4697188;
- Biblioteca PIME, Via Mosè Bianchi 94, 20149 Milano, tel. (02)4980741;
- Biblioteca Centro Studi Terzo Mondo, Via Morgagni 39, 20129 Milano, tel. (02)2719041;
- Biblioteca Pontificia Università Urbaniana, Via Urbano VIII 16-17, 00100 Roma, tel. (06)6568640;
- Biblioteca Istituto Missioni Consolata, Via Ferrucci 14, 10138 Torino, tel. (011)446446;
- Biblioteca SMA (Società Missioni Africane), Via Borghero 4, Genova, tel. (010)384614;
- Biblioteca Istituto Storico della Compagnia di Gesú - Reparto Bibl. missionrio, Borgo S.S. Spirito 5, 00193, Roma, tel. (06)656.98.41;
- Biblioteca SID (Society for International Development), Palazzo Civiltà del Lavoro, 00144, Roma EUR;
- IDOC, Via S. Maria dell'Anima 30, 00186 Roma, tel. (06)6568332.
Riviste
- Amico, mensile per animatori missionari con tracce di lavoro, documenti, incontri di preghiera, C.so Ferrucci 14, 10138 Torino, tel. (11)446.446;
- Cem-Mondialità, bimestrale dei Saveriani per l'educazione dei ragazzi alla mondialità, V.le S. Martino 6bis, 43100 Parma;
- I.M. (Italia Missionaria), mensile per adolescenti del PIME, Via M. Bianchi 94, 20149 Milano, tel. (02)49.80.741;
- Missioni Consolata, mensile per la famiglia a carattere di rivista, C.so Ferrucci 14, 10138 Torino, tel. (011)446.446; - Mondo e missione, mensile del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere), Via Mosè Bianchi 94, 20149 Milano, tel. (02)4980741;
- Nigrizia, rivista mensile dei Missionari Comboniani dedicata all'Africa e al mondo nero, V.le Pozzo 1, 37129 Verona, tel. (045)23534;
- Piccolo Missionario, mensile per ragazzi medesima redazione di Nigrizia; - Il ponte d'oro, mensile dell'infanzia missionaria, P.O. Infanzia Missionaria, Via Propaganda 1, 00187 Roma;
- Popoli e Missioni, rivista mensile delle Pontificie Opere Missionarie (in doppia edizione: per animatori e per tutti), Via Propaganda 1, 00187 Roma, tel. (06)67.95.554;
- Progetto, mensile del Servizio Diocesano giovanile, Torino, tel. (011)9591091;
- SIAL (Servizio Informazioni America Latina), quindicinale, via Bacilieri 1-4, 37139 Verona S. Massimo, tel. (045)56.48.50;
- Il Regno, Attualità - Documenti, V. Nosadella 6, 40100 Bologna, tel. (051)330301.




















































