Luis A. Gallo
LO SPIRITO DI VITA
Elledici 1998
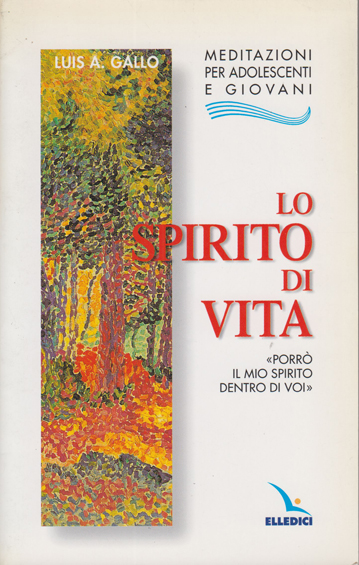
0. Introduzione
1. In Gesù di Nazaret, lo Spirito è passione per la vita
2. In Gesù di Nazaret, lo Spirito è figliolanza nei confronti di Dio
3. In Gesù di Nazaret, lo Spirito è fraternità verso tutti
4. In Gesù di Nazaret, lo Spirito è tenerezza verso i più piccoli
5. In Gesù di Nazaret, lo Spirito è energia vivificante
6. In Gesù di Nazaret, lo Spirito è conoscenza penetrante delle persone e degli avvenimenti
7. In Gesù di Nazaret, lo Spirito è coraggio e tenacia
8. In Gesù di Nazaret, lo Spirito è sorgente viva di preghiera
9. In Gesù di Nazaret, lo Spirito è perdono dei peccati
10. In Gesù di Nazaret, lo Spirito è libertà davanti a tutto e a tutti
11. Lo Spirito è la potenza divina con cui il Padre risuscita Gesù
12. Mediante lo Spirito, Gesù risorto porta a compimento la storia
13. In Dio, lo Spirito è da sempre il principio divino della solidarietà aperta
INTRODUZIONE: IL RITORNO DELLO SPIRITO
Nella nostra vita cristiana siamo sempre sollecitati a focalizzare la figura, per molti probabilmente poco conosciuta, dello Spirito Santo.
Proprio perché si tratta di uno «Spirito», sia pure con l’iniziale maiuscola, il tema può sembrarci meno concreto, meno afferrabile. Eppure l’esperienza ci mette costantemente a contatto con tanti «spiriti». Non nel senso di quegli esseri misteriosi che, nella convinzione di più di uno, popolano invisibilmente il mondo provocando sia il bene (angeli) che il male (demoni), ma nel senso di quelle forze che spingono gli uomini e le donne, singoli e in gruppo, ad agire in svariate direzioni. Si usa dire, per esempio, che uno è sospinto da uno spirito d’orgoglio, d’invidia, di superbia… Queste forze in effetti esistono. È il caso di una tribù dell’Africa, che si scaglia contro un’altra perché ha dentro di sé un’aggressività che la spinge a voler imporsi ad essa o perfino ad eliminarla; oppure di un gruppo di giovani naziskin che aggredisce un extracomunitario e lo pesta perché si lascia trascinare da una forza razzista che l’accieca; o ancora, di un’associazione di volontari che brucia le sue energie giovanili e consuma il suo tempo nell’assistenza a handicappati perché una generosità incontenibile la spinge a donarsi generosamente ad essi. Ecco alcuni degli «spiriti» con cui si muovono le persone… Si potrebbero moltiplicare gli esempi all’infinito, in tutti gli ambiti dell’esistenza personale e sociale.
D’altra parte, stiamo assistendo negli ultimi decenni ad un pullulare di gruppi e associazioni che si rifanno allo Spirito Santo, intendendo per esso lo Spirito di Dio. Sono i gruppi del «rinnovamento nello Spirito» che, in svariatissime forme, si diffondono a macchia d’olio nelle chiese cristiane e anche fuori di esse. Una cosa sembra accomunarle: l’esperienza «Spirituale» (con la maiuscola, appunto perché dello Spirito). Ad essi non interessa infatti sapere che esiste lo Spirito; vogliono invece avere a che fare con lo stesso Spirito, e sentire gli effetti della sua presenza e delle sue mozioni. Non pochi tra essi ci tengono ad individuare anche i doni concreti con cui lo Spirito divino agisce in mezzo alla comunità: guarigioni corporali o psichiche, consolazioni spirituali, capacità di parlare diverse lingue … Non si può negare che, contrariamente a quell’esilio dello Spirito che ha caratterizzato la vita di fede dei cristiani negli ultimi secoli, oggi si stia producendo un vasto ritorno del medesimo Spirito in maniera travolgente, fino a preoccupare le Chiese istituzionali perché in buona parte ciò sfugge al loro controllo.
Tutto ciò rende urgente un discorso sullo Spirito. Ne dobbiamo parlare per cercare di chiarirci le idee. Ma parlarne come? Purtroppo le circostanze storiche hanno portato le Chiese a parlare dello Spirito in un linguaggio sempre meno comprensibile e afferrabile da parte di tante persone. Il cammino iniziato nei primi secoli, quando come risposta a certe tendenze ereticali si cercò di definirne l’identità in termini dogmatici, come successe nel secondo Concilio Ecumenico, quello Costantinopolitano del 381, sfociò, col passare dei secoli, nella formulazione semplicistica presente anche nei catechismi: lo Spirito è la terza Persona della Santissima Trinità. Un’affermazione in se stessa esatta e perfettamente ortodossa, ma che finì per non dire più niente alla maggioranza dei cristiani. Forse per questo attualmente si sta tentando di parlarne in modo più libero, meno «ufficiale», anche lasciando da parte quelle affermazioni tradizionali. Ancora più povera è quella allusione allo Spirito come la colombella bianca che è raffigurata in tanti dipinti, e che finisce per non dire nulla, o per suggerire dei sensi completamente fuorvianti.
Si può quindi parlare in molti modi dello Spirito Santo. Ma noi, cristiani, siamo convinti che sia Gesù di Nazaret in persona la Parola piena e definitiva su tutto ciò che è importante nella vita, quel Gesù che riconosciamo come il rivelatore per eccellenza, come colui nel quale e mediante il quale ha trovato la sua massima trasparenza tutto ciò che Dio voleva manifestare agli uomini per la loro salvezza. Quindi, anche e principalmente quello che si riferisce al mistero grande e trascendente di Dio stesso. È vero, e fa parte anche delle convinzioni cristiane, che ci sono le testimonianze dell’Antico Testamento, anteriori a Gesù, e in esse la presenza dello Spirito è molto rilevante e i risvolti della sua azione sono molto svariati; ma noi crediamo che solo in Gesù Cristo esse trovano pieno compimento e realizzazione.
Ne consegue che, per parlare con proprietà dello Spirito, non c’è altra strada che quella di passare attraverso di lui. I vangeli ce lo presentano, infatti, come l’uomo spirituale per eccellenza, come un carismatico incomparabilmente pieno dello Spirito di Dio. I racconti del suo battesimo in Mt 3,13-17, Mc 1,9-10 e Lc 3,21-22, riflettendo ciò che le prime comunità pensavano di lui, lo evidenziano chiaramente. Particolarmente solenne è poi l’affermazione che l’evangelista Luca mette sulla sua bocca quale inaugurazione della sua missione nella sinagoga di Nazaret, citando il profeta Isaia: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi ha mandato ad annunciare la buona novella...» (Lc 4,18).
Stupisce pertanto che, alle volte, si parli dello Spirito senza passare per questa via. Solo percorrendola si può essere sicuri di non sbagliare. Nelle pagine che seguiranno cercheremo quindi di addentrarci per questa strada, affacciandoci con grande rispetto all’esperienza spirituale fatta da Gesù di Nazaret. Sarà nostra intenzione scoprire la presenza e la manifestazione dello Spirito Santo di Dio in lui, individuare quella Forza divina che lo spingeva costantemente dal più profondo del suo cuore a vivere e ad agire in un determinato modo. Il tentativo ci aprirà un panorama certamente meraviglioso, e ci permetterà di cogliere i diversi risvolti della figura di questo Spirito Santo che, come afferma la nostra fede, è «Signore e dà la vita» (Credo niceno-costantinopolitano).
I temi che affronteremo saranno i seguenti:
1. In Gesù di Nazaret, lo Spirito è passione per la vita
2. In Gesù di Nazaret, lo Spirito è figliolanza nei confronti di Dio
3. In Gesù di Nazaret, lo Spirito è fraternità verso tutti
4. In Gesù di Nazaret, lo Spirito è tenerezza verso i più piccoli
5. In Gesù di Nazaret, lo Spirito è energia vivificante
6. In Gesù di Nazaret, lo Spirito è conoscenza penetrante delle persone e degli avvenimenti
7. In Gesù di Nazaret, lo Spirito è coraggio e tenacia
8. In Gesù di Nazaret, lo Spirito è sorgente viva di preghiera
9. In Gesù di Nazaret, lo Spirito è perdono dei peccati
10. In Gesù di Nazaret, lo Spirito è libertà davanti a tutto e a tutti
11. Lo Spirito è la potenza divina con cui il Padre risuscita Gesù
12. Mediante lo Spirito, Gesù risorto porta a compimento la storia
13. In Dio, lo Spirito è da sempre il principio divino della solidarietà aperta
Capitolo 1
IN GESÙ DI NAZARET, LO SPIRITO È PASSIONE PER LA VITA
Leggendo i vangeli non è difficile arrivare a convincersi che Gesù di Nazaret sia vissuto con una grande passione nel cuore. L’evangelista Luca gli attribuisce queste parole, che permettono di intravedere la profonda impressione da lui causata in chi lo osservava: «Fuoco sono venuto a portare alla terra, e come vorrei che fosse già acceso!» (Lc 12,49). Qualcosa gli bruciava nel petto, e questo ardore lo spingeva ad agire con entusiasmo incontenibile e con grande determinazione in una precisa direzione. Da parte sua il vangelo di Giovanni, narrando quell’impressionante intervento nel quale mise sottosopra il mercato allestito sotto i porticati del Tempio a servizio del culto, dice che allora i suoi discepoli si ricordarono di ciò che era scritto nella Bibbia: «Lo zelo per la tua casa mi divora» (Gv 2,13-17). Egli appariva quindi ai loro occhi come qualcuno che era «divorato dallo zelo».
Indagando ancora nei vangeli si arriva con facilità ad individuare quale sia stato quel fuoco e quello zelo: non era altro che l’irrefrenabile passione per il regno di Dio. Già fin dalle sue prime battute il vangelo di Marco ne dà testimonianza. Presentando infatti l’inizio della sua attività, afferma: «Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea proclamando la buona novella di Dio e diceva: ‘Il tempo è compiuto e il regno di Dio è imminente: convertitevi e credete a questa bella notizia’» (Mc 1,15).
Il retroterra della passione di Gesù
Chi conosce anche minimamente la Bibbia sa tuttavia che Gesù non inventò l’espressione «regno di Dio», da lui stesso frequentemente utilizzata per designare ciò che stava al centro delle sue preoccupazioni. Egli la ereditò dall’Antico Testamento. Infatti, negli scritti che era andato elaborando il popolo ebreo sin dai tempi antichi, questa espressione ed espressioni equivalenti, come quelle che davano al Dio JHWH il titolo regale (Sal 28,10; 44,3; 47,3; 95,3) o gli attribuivano l’azione di regnare (Sal 93,1; 96,10; 97,1; 99,1; 141,1.13; 149,2; Es 14,28; Is 33,22; 44,6; 52,7; ecc.), non sono infrequenti. Ma, soprattutto, tale espressione era finita per designare un futuro intervento meraviglioso di Dio in favore del popolo e del mondo intero, il quale avrebbe rinnovato in positivo tutto: gli uomini, le loro reciproche relazioni, la loro relazione con Lui e con il mondo. C’era nella tradizione biblica ancora un’altra parola che designava il risultato sostanziale di questo intervento: era la parola shalôm, pace. Ma pace intesa non come semplice assenza di guerra o come la mera «tranquillità dell’ordine» (S. Agostino), bensì come il compimento di tutte le legittime aspirazioni degli uomini e dei popoli.
Furono principalmente i profeti quelli che, pieni di passione per le sorti del popolo, parlarono di questo intervento divino futuro che avrebbe trasformato la faccia della terra riempiendola di gioia e felicità. E siccome essi non avevano esperienza di un simile mondo così trasformato, utilizzarono per parlarne l’unico linguaggio adeguato, quello della poesia. Basta ricordare un brano tra tanti, a modo d’esempio, per averne un’idea. È quello del profeta Isaia il quale, parlando dell’effetto che avrebbe fatto seguito all’azione del futuro intervento di Dio, dice:
«Il lupo dimorerà insieme con l’agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La vacca e l’orsa pascoleranno insieme; si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell’aspide; il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi…» (Is 11,6-8).
Gesù di Nazaret conosceva le Scritture. Sin da piccolo, come ogni maschio giudeo, era stato iniziato alla loro lettura e alla loro comprensione. La frequentazione della scuola dei rabbini per imparare la Bibbia era un obbligo per ogni ebreo di sesso maschile. Abbiamo quindi il diritto di supporre che più di una volta quei testi profetici che riguardavano il regno futuro di Dio siano caduti sotto i suoi occhi, e abbiano prodotto una profonda impressione nel suo animo sensibile. Non siamo in grado di sapere quali siano stati quelli che più l’hanno colpito. Sta però di fatto che, quando egli si lanciò nella sua attività, lo fece con il cuore pieno di questa certezza: ciò che era stato annunciato dai profeti «per gli ultimi giorni», quando il tempo sarebbe arrivato a maturità come il grano d’estate, era ormai imminente; il regno di Dio da essi pronosticato stava cominciando ad essere realtà.
Nelle narrazioni evangeliche Gesù dimostra di esserne profondamente convinto. E un’altra profonda convinzione traspare ancora dalle pagine dei vangeli: quella di essere lui stesso l’inviato da Dio per annunciare l’arrivo del regno. Annunciarlo con le parole e soprattutto con gli atti. Oltre a parlarne, infatti, servendosi come i profeti dei simboli più svariati (la luce, l’acqua, il banchetto, il lievito, il grano di senapa, l’ovile…) per illuminarne le diverse sfaccettature, egli pose dei segni concreti del suo arrivo.
Questi segni sono alcuni d’indole individuale, altri d’indole sociale. Guarigioni di ciechi, sordi, muti, paralitici, lebbrosi, liberazione da spiriti nocivi che tormentavano le persone, perdono dei peccati in nome di Dio, sono altrettanti segni da lui posti nell’ambito individuale. Quelli posti nell’ambito sociale riguardano invece la convivenza tra le persone e i gruppi: difesa della pari dignità della donna e dell’uomo, eliminazione dell’emarginazione dei peccatori, attenzione privilegiata ai più poveri e deboli, ai più piccoli tra i membri della società. Essi fanno toccare con mano l’avvento di un mondo radicalmente trasformato secondo il disegno originale di Dio.
Una lettura dei vangeli che segua con attenzione questa sua travolgente attività, mirata a testimoniare la venuta, nella sua persona e nella sua azione, del regno promesso, non può non rimanere colpita dalla passione che vi traspare: Gesù non è un tranquillo operatore di beneficenza, è un vulcano che lascia traboccare il fuoco che gli brucia dentro. Dove lui arriva, fugge il mondo vecchio fatto di malattia, alienazione, ingiustizia, emarginazione, peccato, per lasciare posto al mondo nuovo fatto di benessere vero, di amore, di accoglienza, di gioia e felicità.
La versione giovannea
Finora abbiamo attinto ai vangeli sinottici, che si muovono sostanzialmente nella stessa lunghezza d’onda. In essi la passione di Gesù appare polarizzata attorno all’annuncio del regno di Dio. L’evangelista Giovanni segue invece un altro schema, tutto suo. E anche per quel che riguarda la preoccupazione centrale di Gesù, si esprime in altri termini. È soprattutto la parola «vita», spesso accompagnata dall’aggettivo «eterna», quella che viene particolarmente da lui privilegiata. L’aggettivo non deve depistare. Spesso, infatti, è stato interpretato nel senso che la preoccupazione di Gesù sarebbe stata la vita dell’aldilà, quella che si avrà nel cielo, dopo la morte; oppure ciò che viene più di una volta chiamato «vita spirituale», o perfino «vita soprannaturale». In concreto, la comunione filiale con Dio per mezzo suo nello Spirito Santo. Non c’è dubbio che anche ciò faceva parte della sua preoccupazione. Basta leggere i vangeli per averne un’innegabile conferma. Ma il senso che la parola «vita» ha nel vangelo di Giovanni è estremamente ricco e realistico, soprattutto se lo si intende alla luce di quanto Gesù fa: abbraccia la totalità dell’esistenza umana, in tutti i suoi molteplici risvolti, a cominciare da quelli più elementari che riguardano il benessere corporale. È significativo che lo stesso Giovanni, seppure in molto minore quantità dei sinottici, racconti interventi suoi mirati a guarire degli ammalati nel corpo (Gv 4,46-54; 5,19; 9,1-7).
Recentemente, nella sua enciclica «Evangelium Vitae» papa Giovanni Paolo II l’ha messo chiaramente in evidenza. Egli, infatti, interpretando quella che ritiene essere la frase-nucleo della missione di Gesù - «Io sono venuto perché abbiano la vita, e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10) - commenta:
«In verità, Egli si riferisce a quella vita 'nuova' ed 'eterna', che consiste nella comunione con il Padre, e a cui ogni uomo è gratuitamente chiamato nel Figlio per opera dello Spirito Santificatore. Ma proprio in tale 'vita' acquistano pieno significato tutti gli aspetti e i momenti della vita dell'uomo» (n.1c).
Il senso, quindi, della missione di Gesù, ciò che dava unità e forza a tutta la sua attività, era la vita in pienezza delle persone, di ogni singola persona. Egli voleva davvero, appassionatamente, che avessero «la vita e l’avessero in abbondanza», e cioè in tutte le sue dimensioni. A questo scopo orientava tutto ciò che diceva e faceva. Per questo anche diede, in definitiva, la propria vita, quando le circostanze lo richiesero. Era questo il modo di glorificare Dio, facendo avvenire il suo regno nel mondo.
Chi muove Gesù è lo Spirito
Nella narrazione del battesimo di Gesù dei vangeli sinottici (Mt 3,13-17; Mc 1,9-11; Lc 3,21-22) è presente, tra gli altri, un elemento di rilievo: lo Spirito scende su Gesù come una colomba. Anche nel racconto di Giovanni il Battista, egli dice di aver visto «lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui». Non solo, afferma che chi lo ha inviato gli ha detto: «L’uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo» (Gv 1, 32-33).
Questa concorde testimonianza, non frequentemente riscontrabile, tra i quattro vangeli, sta a testimoniare una profonda convinzione dei primi discepoli: in Gesù abitava in forma stabile lo Spirito di Dio. E non abitava in maniera inerte e passiva, bensì in maniera intensamente dinamica. Infatti, come si vede nel seguito della narrazione, è lo Spirito che lo muove costantemente verso la realizzazione della sua missione, a cominciare dai quaranta giorni passati nel deserto tra tentazioni diaboliche (Mt 4,1-11; Mc 1,12-13; Lc 4,1-13). Le guarigioni da lui operate sono ugualmente attribuite a quella energia che, uscendo da lui, «guariva tutti» (Lc 6,19; cf Mc 525-31; Lc 8,43-46), e gli esorcismi mediante i quali liberava coloro che erano sotto il potere degli spiriti, sono ascritti al «dito di Dio» (Lc 11,20; Mt 12,28). Due metafore - energia e dito - con le quali i sinottici esprimono la presenza vivificante dello Spirito operante in lui.
Giovanni, in un altro contesto, manifesta la stessa convinzione. Si tratta dell’intervento di Gesù durante la festa delle Capanne, nella quale, in mezzo alla solenne processione che portava l’acqua viva dalla fontana di Siloe al Tempio, si sente la sua voce che proclama: «Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sorgeranno dal suo seno». E l’evangelista aggiunge esplicitamente che egli intendeva riferirsi allo Spirito Santo (Gv 7,37-38). Almeno secondo alcuni interpreti, i fiumi di acqua viva, a cui alludono le sue parole, sgorgano dal suo stesso seno. È lo Spirito che promana da lui, perché è in lui. L’immagine dell’acqua per parlare dello Spirito è infatti presente anche in un altro testo del medesimo vangelo, quello in cui si narra l’incontro di Gesù con la donna samaritana presso il pozzo di Giacobbe. A lei, che gli chiede l’acqua viva per non dover tornare al pozzo ad attingerla, Gesù risponde: «Chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete; nzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna» (Gv 4,13-14). È facile cogliere il nesso che c’è in questo testo tra «acqua» e «vita eterna», nel senso sopra accennato. Ed è facile anche percepire come l’evangelista pensi a Gesù come sorgente di vita piena precisamente perché è pieno di Spirito Santo.
Fuoco e acqua sono due realtà che si respingono a vicenda nella nostra esperienza; ma nel mondo dei simboli possono stare molto bene insieme. Tutti e due servono a trasmettere la stessa convinzione: Gesù di Nazaret è un uomo pieno dello Spirito di Dio, uno Spirito che è fuoco ed è acqua viva, e che non lo lascia tranquillo ma lo spinge costantemente a uscire in qualche modo da se stesso per andare verso la realizzazione dell’unica grande volontà di Dio, suo Padre: che gli uomini e le donne «abbiano la vita, e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10).
PER IL LAVORO PERSONALE E DI GRUPPO
Leggi con attenzione Lc 3,1-16 e 21-22; 4,1 e 14-20; 6,19; 12,49 e cerca di cogliere la presenza dello Spirito di Dio in Gesù, e la direzione in cui lo muove.
Domandati con sincerità quale spirito o quali spiriti ti spingono ad agire. Se ti lasci muovere dallo stesso Spirito che muoveva Gesù o da altri spiriti, quelli dell’orgoglio, dell’invidia, del desiderio di possedere, di dominare…
Preghiera
Gesù, fratello, amico e mio Signore,
leggendo i vangeli
mi colpisce il fuoco che ti bruciava dentro.
Quella forza incontenibile che ti spingeva
a cercare appassionatamente la pienezza di vita della gente
era lo Spirito di Dio che ti riempiva il cuore.
Non è certo lo stesso Spirito che anima me;
anzi, sento altri fuochi che ardono nel mio petto...
Contagiami con il tuo Spirito,
perché anch’io cerchi con entusiasmo
ciò che hai cercato tu. Amen.
Capitolo 2
IN GESÙ DI NAZARET, LO SPIRITO È FIGLIOLANZA NEI CONFRONTI DI DIO
L’esperienza filiale di Gesù
Gli studiosi dei vangeli rilevano un dato di singolare importanza: Gesù di Nazaret si rivolgeva a Dio invocandolo come «abbà». Ne sono testimonianza, diretta o indiretta, alcuni testi del Nuovo Testamento: Mc 14,36; Rm 8,15; Gal 4,6. Si tratta di un termine, preso dall’uso familiare degli ebrei, che ai tempi di Gesù era adoperato dai figli, specialmente dai figli piccoli ma non solo da essi, per rivolgersi al proprio genitore. Aveva quindi una carica affettiva molto accentuata, dal momento che denotava intimità e fiducia. Va pertanto tradotto come «babbo», «babbo carissimo», e non semplicemente come «padre». Secondo alcuni esegeti, anche quando tale termine manca e al suo posto c’è «padre», in più di un’occasione bisogna pensare che originariamente esso c’era. Così, per esempio, nella preghiera del Padre nostro.
Che Gesù di Nazaret abbia adoperato questo termine per rivolgersi a Dio e abbia invitato anche altri a farlo, costituisce una delle molte sconvolgenti novità da lui apportate nello svolgimento della sua attività in ordine al regno di Dio. Infatti, il senso della trascendenza del Dio tre volte santo (Is 6,3) col passare del tempo era andato crescendo nel popolo d’Israele in tale modo che da qualche secolo il suo nome - il tetragramma sacro JHWH - non era più pronunciato. Al suo posto si usavano altri termini o espressioni, quali «Adonai» (Signore mio o nostro), «i cieli», «l’Altissimo», per evitare di profanarlo. Solo il Sommo Sacerdote, una volta l’anno, quando attraversava la tenda che separava il Santo dei Santi dal resto del tempio per compiere il rito della purificazione (Lv 16), lo pronunciava con gran timore e riverenza.
Nessun giudeo del tempo di Gesù avrebbe osato violare quest’usanza. Egli invece la trasgredì audacemente: invocava Dio con l’appellativo che aveva appreso nella sua esperienza famigliare. Accostare questi due termini - «Dio» e «babbo» - significava produrre una specie di cortocircuito imperdonabile secondo la mentalità allora imperante in Israele. Fu questo uno dei motivi per i quali lo condannarono a morte. Effettivamente, l’accusa che gli venne mossa nel processo religioso, quello che si svolse davanti al tribunale del sommo sacerdote Caifa e del sinedrio, fu di bestemmia (Mt 26,65-66; Mc 14,63-64). E la sua bestemmia consisteva nell’essersi dichiarato in quel momento Figlio di Dio ma, più in là e più in profondità, la sua vera bestemmia consisteva per i capi religiosi nell’aver egli proposto un modo di onorare Dio e di rapportarsi con Lui differente da quello che essi praticavano e insegnavano, e che era di conseguenza comune nel popolo. Egli si discostava così da quel tremendo rispetto sacro che Dio richiedeva, osando accorciare le distanze tra lui e gli uomini fino all’inverosimile.
Ma se Gesù osò fare questo, era perché rispondeva alla sua esperienza personale. Dal modo in cui si rivolgeva a Lui, utilizzando l’appellativo familiare di «babbo», trapela infatti la sua maniera abituale di rapportarsi con Dio: un rapporto fatto di intimità e fiducia e di familiarità estrema. Il dato colpisce ancora maggiormente se si tiene conto della sua condizione di uomo adulto (aveva attorno ai trent’anni quando iniziò la sua attività pubblica: cf Lc 3,43; Gv 8,57), che non apparteneva alla classe sacerdotale (cf Eb 7,13) più abituata al tratto con Dio nel culto, ed era intensamente impegnato in un’attività travolgente. Non si trattava quindi di un bambino o di un adolescente, nei quali prevale di solito l’emotività, né di un esaltato misticheggiante, ma di un uomo maturo e indiscutibilmente dotato di grande realismo.
Uno dei momenti più forti di tale esperienza deve essere stato, possiamo supporlo, quello della preghiera. Che Gesù pregasse personalmente, oltre a farlo con gli altri suoi connazionali nei momenti stabiliti dall’uso, è attestato più di una volta nei vangeli (Mc 1,35; Lc 6, 12; Eb 5,7; ecc.). Giovanni riporta un’ampia e solenne preghiera - la cosiddetta «preghiera sacerdotale» - che egli avrebbe fatto durante l’ultima cena, dopo aver parlato a lungo con i suoi amici (Gv 17,1-26). Ma, soprattutto, impressiona l’ampio racconto che fanno i sinottici della sua travagliata preghiera nell’Orto degli Ulivi, prima di essere tradito e consegnato ai suoi avversari (Mt 26,36-45; Mc 14,32-40; Lc 22,39-45). Secondo la narrazione di Marco, proprio in quel contesto di angoscia mortale egli pronunziò la parola che gli era tanto familiare, aggiungendo poi la dichiarazione della sua intera disponibilità al Suo volere: «Abbà, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu» (Mc 14,36). È una preghiera fatta d’intensa fiducia, ma allo stesso tempo di estremo abbandono.
Luca porrà poi sulle sue labbra, quando egli si troverà già sul patibolo della croce, innalzato tra il cielo e la terra e in preda alla più profonda sensazione di abbandono, le parole più di una volta ripetute dai salmisti dell’Antico Testamento (Sal 16,5; 31,6.16): «Nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23,46), ma anteponendovi l’invocazione filiale «Padre» che, come abbiamo visto, dovrebbe essere probabilmente sostituita da «Babbo». Così, ciò che egli aveva costantemente vissuto trovò la sua espressione culminante nel momento apice della sua vita. Egli si abbandonò fiduciosamente, pur in mezzo ai terribili dolori fisici e alla più angosciante sensazione di solitudine, nelle mani di Colui che aveva sempre invocato come Padre tenero e sollecito. Morì come figlio, affidandosi all’amore indefettibile di Dio.
Da tutto questo si può desumere che Gesù di Nazaret era pieno di uno spirito intensamente filiale. Un atteggiamento di profonda figliolanza impregnava ogni suo pensiero, ogni sua parola, ogni sua azione. L’evangelista Giovanni riporta queste parole come dette da lui: «Il Figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa» (Gv 5,19). Siano o no uscite testualmente dalla sua bocca, tali parole descrivono bene ciò che i suoi discepoli avevano percepito a contatto con lui: egli si sentiva intensamente figlio, e come tale cercava di modellarsi in tutto su suo Padre. Si spiega anche così la sua sovrana libertà davanti a tutto e a tutti, sulla quale torneremo più avanti.
Lo Spirito di figliolanza comunicato ai discepoli
In Gesù, quindi, quello Spirito che lo riempiva e lo spingeva costantemente ad assumere certi atteggiamenti, era uno Spirito di figliolanza. Fu questo stesso Spirito che egli «contagiò» anche a coloro che l’avevano seguito. Il racconto di Gv 20,19-23 si può intendere in questa luce. Egli narra che la sera dello stesso giorno della sua risurrezione, Gesù si presentò ai suoi discepoli, ancora intimoriti per quanto era successo appena poche ore prima, e dopo aver augurato loro la pace, «disse loro di nuovo: ‘Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi’. Ciò detto, alitò su di loro e aggiunse: ‘Ricevete lo Spirito Santo’…». Certamente l’episodio ha una portata molto più vasta di quello che noi evidenziamo, ma lo si può capire anche in questa prospettiva: Gesù comunica il suo stesso Spirito ai suoi discepoli, perché vivano come egli visse nei confronti di Dio.
Abbiamo un’eco di questa convinzione in diversi scritti neotestamentari. Soprattutto nelle lettere di Paolo. In quella scritta ai cristiani della Galazia egli, che li aveva iniziati alla libertà in Cristo, si batte appassionatamente perché si mantengano ad ogni costo in essa. Non vuole che si lascino assoggettare da nessuno e da niente. Dice loro con grande determinazione: «Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi; state dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù» (Gal 5,1). In tale contesto egli si appella alla loro condizione filiale, frutto dell’intervento di Dio stesso nella persona del suo Figlio, e poi aggiunge: «E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei vostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio» (Gal 4, 6-7).
E nella lettera ai Romani, il cui tema in parte coincide con quello della lettera ai Galati, egli afferma, a conclusione di un impegnativo ragionamento: «La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5). Trapela da queste parole la ferma convinzione dell’Apostolo circa la presenza dello Spirito nei cuori di coloro che credono in Gesù Cristo: Egli è presente perché vi è stato «riversato» - è facile cogliervi l’immagine dell’acqua viva utilizzata anche da altri scritti del Nuovo Testamento per parlare dello Spirito da Dio -, e perciò li impregna totalmente. Ora, questo Spirito è appunto uno Spirito di figliolanza. Lo rileva ancora Paolo più avanti, nella stessa lettera: «Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: ‘Abbà, Padre!’» (Rm 8,14-15).
È indubitabile che Paolo aveva imparato da Gesù queste cose, pur non avendo avuto contatti personali con lui durante la sua vicenda terrena. Egli sapeva che, come Gesù, coloro che credono in lui sono mossi dallo stesso Spirito di figliolanza, e che questo Spirito li muove ad avere gli stessi atteggiamenti di Gesù nei confronti di Dio. Soprattutto, quello che è tipico di chi vive in un’intimità filiale e non nella paura: l’amore di figli, quello che accorcia le distanze, così come la paura degli schiavi l’aumenta. Un altro scrittore del Nuovo Testamento affermerà, in perfetta armonia con quanto dice Paolo: «Nell'amore non c'è timore, al contrario l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore» (1 Gv 4,18).
PER IL LAVORO PERSONALE E DI GRUPPO
Raccogliti in qualche angolo silenzioso e cerca di immaginare Gesù in preghiera intima con Dio; sentilo rivolgersi a Dio chiamandolo «Abbà», e lasciati sorprendere e stupire dai suoi profondi sentimenti di tenerezza filiale e di fiducia sconfinata…
Pensa ai tuoi rapporti personali con Dio. Vedi se sono impregnati da questo stesso Spirito di figliolanza, o se invece li pervade uno spirito di paura, di affanno o di sfiducia.
Preghiera
Non finisco di stupirmi, o Gesù,
della familiarità con cui ti rivolgevi a Dio.
La tua era una preghiera tutta pervasa
da un atteggiamento di figliolanza tenera e allo stesso tempo forte.
Tu concentravi tutta la tua coscienza di figlio
in quelle parole con cui ti rivolgevi a Lui «Abbà»!
Fa’ che io ascolti lo Spirito che dentro di me grida: «Babbo!»,
e che mi lasci trasportare da lui nel parlare con Dio.
Così la mia preghiera assomiglierà un po’ alla tua. Amen.
Capitolo 3
IN GESÙ DI NAZARET, LO SPIRITO È FRATERNITÀ VERSO TUTTI
Gesù di Nazaret, fratello tra fratelli e sorelle
Se lo Spirito dinamicamente presente in lui fece dell’uomo Gesù di Nazaret un figlio che si rapportava con piena confidenza e tenerezza con Dio fino a chiamarlo «babbo», questo stesso Spirito fece di lui un fratello tra fratelli e sorelle. Impressionano, infatti, da questo punto di vista, nella lettura dei vangeli, sia le parole che l’agire di Gesù. Tanto più che quest’ultimo corrobora e illumina il senso delle prime.
C’è una parabola da lui raccontata come risposta alla domanda di uno dei rabbini sul comandamento principale della Legge, che svela luminosamente la disposizione radicale e, possiamo anche dire, viscerale che egli stesso aveva: è la parabola del buon Samaritano (Lc 10,30-37). Davanti all’uomo lasciato semimorto dai ladri ai margini della strada, mentre il sacerdote e il levita proseguono la loro strada senza fermarsi, il Samaritano si lascia invece impressionare e si commuove profondamente. La parola usata dal testo originale per descrivere tale commozione fa riferimento alle viscere: egli, dice la narrazione, si sentì toccato nel più intimo delle sue viscere. E quella commozione lo portò a «usargli misericordia», a «farsi prossimo» suo. Diventò così vero fratello di colui che, secondo la maniera di vedere del tempo in Israele, era un nemico (cf Gv 4,9).
I vangeli ci presentano un Gesù vivamente coinvolto nelle situazioni concrete di coloro che incontra sulla sua strada, siano essi uomini o donne. Egli si dimostra sensibilissimo ai loro bisogni e alle loro attese, e la sua sensibilità lo porta a vibrare con essi, a commuoversi intensamente davanti alle loro sofferenze e alle loro gioie, e a venire incontro alle loro necessità. Bastano un paio di esempi per averne la conferma.
Anzitutto, l’episodio della guarigione del lebbroso, raccontato in Mt 8,2-3 e Mc 1,40-42. Si sa in quali condizioni vivessero coloro che erano vittime di tale infermità a quei tempi. Una spaventosa emarginazione li escludeva dalla convivenza con gli altri, strappandoli non solo agli affetti più intimi, ma impedendo loro anche la partecipazione agli atti più importanti della vita del popolo. Erano dei veri morti in vita. Mentre il vangelo di Matteo è estremamente conciso nel narrare l’episodio, quello di Marco, pur nella sua brevità, fornisce dei dettagli molto rivelatori circa gli atteggiamenti e le reazioni di Gesù. Dice infatti che davanti alla supplica accorata dell’ammalato, egli, «commosso fino alle viscere», stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, guarisci»; e in quel momento la lebbra scomparve e l’infermo guarì. Quel lasciarsi toccare nel vivo della propria sensibilità dice molto circa l’atteggiamento fraterno di Gesù, un atteggiamento che non è solo commozione emotiva, ma che lo porta a passare al di sopra della istintiva repulsione provocata dalla visione del malato e anche a non attenersi ai vincoli stabiliti dalla Legge nei confronti dei lebbrosi (Lv 13,44-46), e sfocia in un’azione concreta di liberazione dal male fisico e dalle svariate sue conseguenze.
L’altro episodio è quello della risurrezione del figlio della vedova di Nain, raccontato in Lc 7,12-15. La scena iniziale è straziante: una madre vedova, accompagnata da molta gente del paese, cammina piangendo dietro la bara in cui portano a seppellire il suo unico figlio. Gesù la incontra e, anche qui, reagisce anzitutto visceralmente. Il testo, infatti, utilizzando lo stesso termine dell’episodio del lebbroso, dice: «Vedendola, il Signore si commosse profondamente e le disse: ‘Non piangere!’». Lo si coglie tra le righe: egli è toccato nel vivo dalla scena che ha davanti agli occhi, si lascia coinvolgere dal dolore della donna e interviene esortandola a non piangere. Un’esortazione che potrebbe suonare a sarcasmo o a sterile commiserazione, ma che acquista il suo vero senso da quanto segue: «E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: ‘Giovinetto, dico a te, alzati!’. Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla madre». Ancora una volta la sensibilità fraterna di Gesù si esprime a due livelli: quello della commozione intensa, e quello dell’attuazione concreta in cui essa sfocia. Tra l’altro, come nell’episodio anteriore, la sua reazione fraterna, mirata a strappare madre e figlio da situazioni estremamente negative, lo porta a passare al di sopra delle leggi della purità rituale, dal momento che egli, toccando la bara, ne resta automaticamente intaccato (cf Lv 21,11; 22,4).
Questi due esempi, che potrebbero moltiplicarsi rivisitando i vangeli, fanno toccare con mano come lo Spirito che muove Gesù sia veramente una forza che lo spinge a farsi attivamente fratello degli altri, amando appassionatamente la loro vita e la loro vera felicità. Anche quando egli interviene con durezza o con ira, come quando si rivolge a coloro che stravolgono il rapporto con Dio facendolo diventare formalista o leguleio (cf per esempio Mc 3,1-5), è mosso da una profonda preoccupazione per la condizione in cui essi si trovano. Per lui, essere fratello non è un semplice sentimento, privo magari di chiaroveggenza, ma un farsi seriamente e attivamente responsabile della vita e della morte degli altri. È, in definitiva, una espressione di quella passione per il regno di Dio che gli riempie il cuore. Si spiega così come questo Spirito di fraternità lo porti a occuparsi particolarmente di coloro che di vita ne hanno di meno.
Tale atteggiamento incontenibilmente fraterno è stato quello che lo portò alla morte in croce. Il vangelo di Giovanni raccoglie queste parole che egli avrebbe detto nell’ultima cena, parlando con i suoi intimi: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici» (Gv 15,13). Le abbia dette o no Gesù personalmente, si tratta di parole che esprimono la netta convinzione di coloro che erano vissuti accanto a lui: egli portò il suo amore fraterno fino all’estremo di dare la vita per coloro che amava. Prendendo sul serio la sua responsabilità per la vita di tutti, e particolarmente di quelli che ne erano più spogliati ad opera di altri, egli finì per scontrarsi con coloro che erano mossi da altri spiriti. Quelli che cercavano i loro interessi prescindendo dagli altri e perfino sfruttandoli a proprio vantaggio, si sentirono minacciati nella loro sicurezza da ciò che egli proponeva e faceva, e decisero di eliminarlo. La sua fu una morte piena di fraternità. Mediante essa egli arrivò ad essere, come amava dire Charles de Foucauld, il «Fratello universale».
La fraternità dei discepoli
«Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24). Il chicco caduto in terra fu Gesù stesso con il suo Spirito di fraternità. Morto in croce e sepolto, non rimase sterile; al contrario, una volto risorto si dimostrò straordinariamente fecondo: le prime comunità dei suoi discepoli si aggregarono come altrettante fraternità mediante lo Spirito da lui ricevuto (cf At 2,1-4).
Fu l’azione di questo Spirito che portò quegli uomini e quelle donne a vivere cercando di essere «un cuore solo e un’anima sola» e di avere «tutto in comune» « (At 4,32). Essi, infatti, erano stati come contagiati dallo stesso Spirito che aveva mosso Gesù il quale aveva detto, quasi come lasciando il suo testamento a coloro che lo accompagnavano nell’ultima cena: «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri» (Gv 13,34) e «Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati» (Gv 15,12).
Oltre al libro degli Atti degli Apostoli, che narra le vicende di queste prime comunità, e specialmente di quella sorta come madre di tutte a Gerusalemme, anche gli altri scritti del Nuovo Testamento sono pieni di testimonianze sulla presenza e l’azione di questo Spirito di fraternità in esse. Spigolando nelle lettere paoline se ne possono raccogliere alcune che meritano particolare attenzione.
Una di esse è tratta dalla lettera ai Galati, là dove l’Apostolo elenca gli effetti della presenza dello Spirito di Dio e di Gesù. Egli scrive: «Il frutto dello Spirito […] è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Gal 5,22). Si tratta, come si vede chiaramente, di atteggiamenti che segnano i rapporti tra i membri di una comunità, e li converte in rapporti veramente vivificanti, come vivificante è lo Spirito dal quale promanano. Fanno parte dell’atteggiamento fraterno che caratterizzava il comportamento dello stesso Gesù.
Accanto a questa ce n’è un’altra, che evidenzia, per contrasto, ciò che richiede lo Spirito di una vera fraternità quale vittoria su altri spiriti che possono impadronirsi del cuore degli uomini generando rapporti mortificanti tra di essi. La si ritrova nella lettera ai Filippesi, tra i quali l’amore fraterno trovava qualche difficoltà ad esprimersi. Paolo, che d’altra parte nutriva per essa un «profondo affetto nell'amore di Cristo Gesù» (Fil 1,8), e che li considerava «fratelli suoi carissimi e tanto desiderati» e li riteneva «sua gioia e sua corona», li esorta ad un più intenso spirito fraterno con queste accorate parole: «Se c'è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c'è conforto derivante dalla carità, se c'è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi sentimenti. Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso, senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù» (Fil 2,1-5).
Bastano queste pochi testi per far capire quale sia il ruolo che svolse - e continua a svolgere - lo Spirito di Dio, che è anche lo Spirito di Gesù, nelle comunità che a lui s’ispirano: perché è uno Spirito «che dà la vita» (Credo niceno-costantinopolitano), esso tende a creare dei rapporti intensamente fraterni, fatti di atteggiamenti e di azioni che mirino a farsi corresponsabili della vita in pienezza degli altri.
PER IL LAVORO PERSONALE E DI GRUPPO
Rileggi lentamente la parabola del Buon Samaritano in Lc 10,30-37 prestando attenzione soprattutto agli atteggiamenti del sacerdote, del levita e del samaritano.
Scegli qualche altro racconto evangelico in cui vedi emergere la figura di Gesù che incarna atteggiamenti fraterni
Domandati fino a che punto è questo stesso Spirito di fraternità quello che ti muove a giudicare, a parlare, ad agire e reagire.
Preghiera
Sei stato un formidabile «Buon Samaritano», o Gesù,
nella tua attuazione appassionata per il regno di tuo Padre.
Ti sei lasciato muovere costantemente dallo Spirito di fraternità,
il quale ha modellato ogni tuo atteggiamento,
e ha guidato ogni tuo pensiero,
ogni tua parola, ogni tua azione.
Ti chiedo di darmi il tuo stesso Spirito:
che venga al mio cuore e lo riempia totalmente.
Allora ciò che uscirà da esso sarà soltanto amore;
allora sarò capace di rendermi attivamente corresponsabile
della vita e della morte degli altri! Amen.
Capitolo 4
IN GESÙ DI NZARATE, LO SPIRITO È TENEREZZA VERSO I PIÙ PICCOLI
Una «predilezione spirituale»
Come abbiamo già rilevato precedentemente, sia pure di passaggio, nello svolgimento della sua attività in favore del regno di Dio Gesù di Nazaret dimostrò di avere una particolare predilezione verso i più piccoli e deboli del suo popolo. Nel discorso inaugurale fatto alla sinagoga del suo paese, tale predilezione venne collegata espressamente da lui stesso all’unzione dello Spirito di Dio che lo permeava: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio» (Lc 4,18). Chi siano i poveri ai quali fa riferimento il testo è precisato in parte dal testo stesso, che continua dicendo: «per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi»; ma la vera precisazione viene da quanto egli stesso fece.
Nella società del suo tempo c’erano diversi fattori che generavano grossi conflitti, dai quali si derivavano umilianti emarginazioni e dolorose esclusioni. Nei confronti di tali conflitti lo Spirito lo spinse a comportarsi in un determinato modo, che si coglie in maniera molto evidente negli scritti evangelici.
Uno di essi era di matrice prevalentemente religiosa. La thorà, ossia la Legge data da Dio attraverso Mosè come strada per la vita e la felicità del popolo e dei singoli suoi membri, era finita per convertirsi paradossalmente, con il passare del tempo, in un fattore di profonda divisione, e in definitiva di morte, tra due blocchi di persone. Infatti, quelli che la osservavano con grande zelo e devozione, soprattutto il gruppo dei farisei, si consideravano a questo titolo giusti davanti a Dio e, quasi come fatale conseguenza, finivano spesso per considerare gli altri, i non osservanti, i disprezzati peccatori (Lc 18,9), come esclusi dall’eredità del regno e dalla benedizione divina; in una parola come maledetti da Dio, (cf Gv 7,49). E questi ultimi ritenevano se stessi come tali, e quindi vivevano molte volte con quel peso sulla coscienza, un peso che li schiacciava e li faceva soffrire. Tra quelli che erano ritenuti peccatori, a prescindere dalla loro condizione personale, occupavano i primi posti gli esattori delle tasse e le prostitute; ma dopo di essi una lunga serie di altri uomini e donne venivano etichettati automaticamente come appartenenti alla categoria degli esclusi: i lebbrosi, i ciechi, gli zoppi, i pastori, i figli naturali fino alla ottava e nona generazione…
Mosso da quello Spirito di fraternità che era amore appassionato per la vita di tutti, Gesù accolse questi peccatori con una tenerezza sconcertante, che non tardò a scandalizzare gli altri, i giusti. Le tre parabole di Lc 15,4-32, ma specialmente l’ultima, quella del figliol prodigo che torna a casa ridotto a un rudere umano e viene accolto con un amore incondizionato dal padre, provocando la reazione sdegnata del fratello maggiore, intendevano giustificare il suo operato davanti a coloro che criticavano il suo modo di comportarsi (cf Lc 15,1-3). È commovente seguire nelle narrazioni evangeliche questo modo sconvolgente di agire di Gesù, che finì per guadagnargli la fama di «amico dei pubblicani e dei peccatori» (Mt 11,19; Lc 7,34). La sua sensibilità per essi lo portò a invitarli a venire da lui per avere sollievo: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò», si legge nel vangelo di Matteo (Mt 11,28). Sono parole che riflettono certamente un suo modo costante di agire. È che, davanti alle folle «sperdute come pecore senza pastore», egli si sente toccato vivamente nelle sue viscere (Mc 6,34), ed esce incontro a loro pieno di tenerezza e di sollecitudine.
Un altro fattore generatore di conflitto e di emarginazione era di tipo economico. Coloro che in Israele avevano in mano le ricchezze, e con esse anche il potere, finivano spesso per essere completamente insensibili verso gli altri, che costituivano la maggior parte del popolo. Non solo, più di una volta perfino li sfruttavano. Era il caso del re Erode e la sua corte, che viveva nell’opulenza e nello sfarzo senza nemmeno accorgersi della presenza del povero Lazzaro, il mendico che aspettava le briciole della loro mensa alle porte del palazzo (Lc 16,19-21); o il caso dei sommi sacerdoti del tempio, che trovavano nel Tempio, la «santa Dimora dell’Altissimo» (Sal 46,5; 68,6; 74,2), una consistente fonte di benessere, e la convertivano in un «covo di ladri» (Mt 21,13; Mc 11,17; Lc 19,46); o ancora il caso dei padroni delle terre coltivabili o dei grandi mercanti, che avevano abbondantemente assicurato il loro alto tenore di vita grazie al lavoro altrui o alla propria sagacia negli affari. Accanto ad essi le grandi folle vivevano spesso stentatamente, prive di sicurezza e perciò anche di vero benessere, a volte fino ai limiti della miseria.
Anche davanti alla situazione di questi poveri Gesù s’intenerì. E perché lo muoveva uno Spirito di compassione verso di essi, diventò critico verso i ricchi egoisti ed indifferenti, sollecitandoli, come nel caso di Zaccheo, ad uscire dalla loro condizione di privilegio per andare incontro agli altri (Lc 19,1-10). Si vede che egli non sopporta una convivenza nella quale alcuni nuotano nell’abbondanza mentre gli altri patiscono privazione fino ai livelli più elementari della vita. Ha troppo a cuore la «vita in pienezza» (Gv 10,10) di tutti, e specialmente di quelli che ne sono più spogliati, per rimanere indifferente davanti a questo stridente contrasto.
Un terzo fattore di conflitto era di natura socioculturale, e si radicava nella differenza sessuale tra uomo e donna. Una differenza che, come nella maggior parte delle società del tempo, aveva dato origine all’umiliante emarginazione delle donne. In Israele la donna era considerata alla stregua di un oggetto a servizio dell’uomo. Non godeva di diritti, ma era solo costretta a compiere dei doveri, ad assolvere dei compiti: procreare figli, di preferenza maschi, e accudire nei servizi domestici il marito e i figli. Una deteriore interpretazione dello statuto del «libello del ripudio», proveniente dai tempi antichi (Dt 24,1), aveva aggravato ancora di più la sua condizione assoggettandola alla volontà anche capricciosa e velleitaria del marito. Le discussioni intavolate tra gli avversari e Gesù circa il divorzio (Mt 19,1-9; 1-12) e circa la risurrezione dei morti (Mt 22,23-34; Mc 12,18-27; Lc 20,27-40) sono come una spia che permette di intravedere tale situazione.
Ancora una volta Gesù si dimostrò sensibile di fronte a chi restava emarginato ed escluso. I suoi atteggiamenti verso le donne che incontrava o che lo seguivano sono di una impressionante novità se riferiti al contesto culturale: egli le accoglie nel suo seguito (Lc 8,1), le tratta con infinito rispetto (Lc 10,38-42), difende la loro dignità (cf Mt 19,8-9; Mc 10,8-9) e gliela restituisce quando l’hanno persa (Lc 7,26-50; Gv 8,1-11). Non lo si vede mai avvicinarsi ad una donna se non con un atteggiamento profondamente accogliente e rispettoso. Ne è un esempio emblematico il suo dialogo con la Samaritana (Gv 4,5-42), nel quale è precisamente l’acqua viva, simbolo dello Spirito, ciò che dà inizio all’incontro, un incontro che finisce con la piena restituzione della donna, per più di un motivo emarginata - era donna, era samaritana, era adultera - alla sua dignità. Non solo, ma col trasformarla in una entusiasta annunciatrice del Messia atteso.
È interessante il fatto che, oltre ad agire in questo modo, Gesù abbia anche indicato tale modo come criterio definitivo per giudicare della maturità vera di una persona. Nel brano riguardante il giudizio finale, infatti, sono centrali queste sue parole: «In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose (dare da mangiare, da bere, visitare gli ammalati, i carcerati…) a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me», e, in forma negativa che toglie ogni dubbio: «In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l’avete fatto a me» (Mt 23,40.45).
Dietro a Gesù, coloro che hanno assimilato il suo Spirito
Le comunità nate attorno alla proposta di Gesù vissero, nella misura in cui si lasciarono muovere da quello stesso suo Spirito, secondo il criterio da lui enunciato con la condotta e con le parole. E, quando si lasciarono prendere da altri spiriti, lo abbandonarono.
Solo a modo di esempio prendiamo il caso - purtroppo negativo, ma che può aiutare a capire le cose per contrasto - della comunità dei Corinzi, alla quale Paolo sentì il bisogno di rinfacciare l’inautenticità della celebrazione eucaristica. Con estrema determinazione l’Apostolo scrive loro: «Voi non celebrate la cena del Signore», anzi, ciò «che fate vi fa più male che bene» (1 Cor 11,20.17). Ed enuncia anche la motivazione del suo tagliente giudizio: «Quando vi radunate in assemblea vi sono tra di voi divisioni […], e ciascuno, quando partecipa alla cena, prende prima il proprio pasto, e così uno ha fame, l’altro è ubriaco» (1 Cor 11,19-21). Vi è, quindi, nella comunità, chi mangia e beve fino all’ubriachezza, e chi invece soffre la fame. Non è così che Gesù pensò i rapporti tra le persone, ma esattamente al contrario, ossia ponendo al centro dell’attenzione i bisogni dei più deboli ed emarginati.
In un inno che la chiesa canta allo Spirito, gli viene dato, tra diversi altri titoli, quello di «padre dei poveri» (cf Sequenza della Pentecoste). Forse rispecchia un’esperienza più volte ripetuta nella storia bimillenaria della chiesa: ogni volta che si è verificato in essa un risveglio dell’attenzione privilegiata verso i più poveri, questo risveglio veniva associato al rifiorire della presenza viva dello Spirito. Basta pensare alla linfa «spirituale» infusa nella comunità ecclesiale da Francesco di Assisi e dai suoi seguaci. Pauperismo, nel buon senso della parola, e presenza viva dello Spirito sono andati sempre di pari passo nella vita della chiesa. È la logica del vangelo di Gesù, nel quale lo Spirito vivificante spinge ad occuparsi con particolare premura e tenerezza dei più deboli.
Oggi, in un momento storico in cui la globalizzazione progressiva si accompagna a una povertà veramente planetaria, lo Spirito di Gesù sembra tornare alla ribalta. I numerosi movimenti e gruppi che si iscrivono nell’alveo del «rinnovamento nello Spirito» troveranno nell’atteggiamento sollecito di Gesù verso i più poveri, verso gli esclusi ed emarginati creati da una struttura economica impostata sul criterio del profitto ad oltranza, un criterio decisivo della loro autenticità.
PER IL LAVORO PERSONALE E DI GRUPPO
Ripensa alle opzioni concrete fatte da Gesù proprio perché era mosso da uno Spirito che lo rendeva più sensibile ai più bisognosi e deboli.
Chiediti quali sarebbero oggi le sue opzioni nel mondo in cui tu vivi: nel piccolo mondo della famiglia, della scuola, del lavoro, del divertimento…, e nel grande mondo che ha le dimensioni del pianeta.
Chiediti con quale Spirito ti poni tu davanti a coloro che sono i più deboli, emarginati, indifesi ed esclusi nella convivenza attuale.
Preghiera
Lo Spirito di Dio era in te, Gesù,
e perciò ti sei lanciato
ad «annunziare la buona novella ai poveri,
a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi».
La tua opzione per «gli ultimi» ti è costata dei grossi sacrifici,
e non sei indietreggiato neanche davanti alla morte.
Vorrei avere anch’io un po’ del tuo Spirito:
ti chiedo di condividerlo con me,
perché io possa condividere le tue scelte
e il tuo coraggio. Amen.
Capitolo 5
IN GESÙ DI NAZARET, LO SPIRITO È ENERGIA VIVIFICANTE
Una forza vivificante si sprigionava da lui
L’evangelista Luca dipinge a grande pennellate una scena per così dire «di attuazione» del regno di Dio da parte di Gesù prima del suo discorso sulle beatitudini. Egli racconta che una grande folla, venuta da ogni dove, si era riunita per ascoltarlo e per trovare mediante lui la guarigione dalle malattie. E aggiunge ancora che «tutti cercavano di toccarlo, perché usciva da lui una forza che sanava tutti» (Lc 6,17-19).
Un altro episodio, raccontato questa volta dai tre vangeli sinottici con sfumature diverse, permette di cogliere la medesima impressione causata da Gesù nella gente. Si tratta della guarigione della donna emorroissa, guarigione operata durante il tragitto verso la casa di Giairo, capo della sinagoga, dove lo attendeva la figlioletta di circa dodici anni, morta, che egli avrebbe poco dopo restituito alla vita (Mt 9,18-26; Mc 5, 21-43; Lc 8,40-56). La condizione in cui versava la donna emorroissa che gli si avvicina era davvero straziante. Anzitutto dal punto di vista corporale, per via della sua malattia che la rendeva debole e fragile, ma anche dal punto di vista economico, dal momento che «aveva sofferto molto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando» (Mc 5,25), e dal punto di vista sociale e perfino religioso, perché la sua malattia la includeva automaticamente nella lista di quelle persone che dovevano essere evitate, pena il contagio dell’impurità rituale in cui esse incorrevano, e che impediva loro di partecipare alle celebrazioni cultuali (cf Lv 15,25). Si potrebbe quindi dire che la morte era presente in lei in svariate maniere e che la teneva sotto il suo dominio.
Quando questa donna, piena di speranza e di fiducia, tocca il lembo del mantello di Gesù, essa sente immediatamente che il flusso di sangue si arresta e che la salute e la vita ritornano nel suo corpo infermo. Risulta molto illuminante ciò che segue nel racconto: Gesù si volta verso la folla per chiedere chi l’ha toccato, e alla reazione stupita dei suoi discepoli i quali gli fanno notare che è quasi schiacciato da tutte le parti dalla gente, risponde: «Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una forza è uscita da me» (Lc 8,46). È possibile che questa frase non sia testualmente sua, ma che esprima piuttosto la certezza acquisita a poco a poco dai discepoli circa la presenza in lui di questa energia divina che, uscendo dalla sua persona, comunicava vita sconfiggendo la morte. Ma una cosa è certa: tale convinzione si fondava su qualcosa di molto concreto da essi colto a contatto con lui. Poco dopo infatti il racconto culmina nella scena in cui egli si incontra faccia a faccia con la figlia di Giairo ormai morta, e con la stessa energia, prendendola per mano, le dice: «Talità kum, che significa: ‘Fanciulla, io ti dico, alzati’» (Mc 5,41). E la ragazza si alzò viva e fu restituita alla gioia dei suoi.
Gli antecedenti biblici
Le prime comunità cristiane arrivarono presto a riconoscere, in questa energia divina vivificante che sgorgava da Gesù e produceva tali effetti sorprendenti, la manifestazione dello Spirito di Dio che avevano imparato a conoscere dalla tradizione biblica. Solo che ora lo vedevano in una luce nuova e nella sua piena manifestazione.
Il termine «spirito» (ruah), con il quale tutta la Bibbia lo designa, proveniva originariamente dall’esperienza del popolo ebraico a contatto con la natura. Comportava diversi significati. Significava anzitutto il vento, da quello leggero alla bufera violenta, che dai contadini veniva ricondotto a Dio come creatore e conservatore di tutte le cose (Gen 1,2; 1 Re 18,45; Sal 33,6; ecc.); ma significava anche il soffio vitale degli esseri viventi, il respiro, la vita, e in quanto tale veniva considerato una proprietà di Dio (Gen 2,7). Trasferito dall’esperienza del mondo alla sfera divina, era inteso come potenza divina invisibile che tuttavia vivificava tutto (Sap 1,7; Sal 139,7), cioè l'intimità dell'uomo e la storia del popolo.
Gli studiosi della Bibbia fanno rilevare che il modo in cui il popolo dell’Antico Testamento intendeva lo Spirito di Dio andò maturando lentamente lungo la sua storia. Nei primi tempi, ai tempi dei Giudici, ossia appena iniziato il processo di assestamento nella terra della promessa, pensava che lo Spirito di Dio conferiva a quegli uomini e donne scelti una particolare forza fisica per la salvezza del popolo stesso (Gdc 13,25; 14,6.19; 15,14), forza che li rendeva atti alle imprese belliche con cui il popolo riconquistava la sua libertà dopo averla perduta (Gdc 3,10; 6,34; ecc.).
Più tardi i Profeti, per evitare il rischio di contaminazione con altre concezioni del profetismo presenti nei popoli che attorniavano Israele, spesso di natura prevalentemente magica, preferirono far riferimento piuttosto alla Parola di Dio anziché al suo Spirito. Con delle eccezioni, tuttavia. Si trovano infatti dei brani profetici in cui lo Spirito occupa il primo piano. Tra questi spicca un testo di Ezechiele, uno dei grandi profeti del tempo dell’esilio d’Israele in Babilonia. In essi egli vede un’enorme pianura interamente coperta di ossa inaridite, e una voce, quella di Dio, gli ordina: «Profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo e annunzia allo spirito: Dice il Signore Dio: ‘Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano’ « (Ez 37,9). L’effetto di queste parole è sorprendente: «Io profetizzai come mi aveva comandato e lo Spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi» (Ez 37,10). Il contesto permette di capire che si tratta espressamente della risurrezione del popolo esiliato alla speranza nel futuro promesso da Dio, ma è chiaro che lo Spirito viene pensato in esso come una straordinaria forza vivificante che fa uscire dalla morte per passare alla vita.
Infine, nell’ultimo periodo dell’Antico Testamento si cominciò a parlare soprattutto del futuro Messia come di colui che sarebbe stato il definitivo portatore dello Spirito (Is 61), e dei tempi messianici come di tempi dell’effusione universale dello Spirito (Gl 3,1-5).
Lo Spirito vivificante nelle comunità dei discepoli
I discepoli videro realizzate in Gesù le profezie messianiche (cf At 2,16-21), e perciò riconobbero in lui la presenza di quella forza divina vivificante che era stata all’opera nei secoli precedenti, e che in lui si manifestava in pienezza. Lo ritennero cioè pieno di Spirito Santo sin dal primo istante della sua concezione (Lc 1,35). Riconobbero quindi questa presenza dello Spirito vivificante in lui, ma anche, tramite lui, in loro stessi. Ciò risulta evidente soprattutto nel libro degli Atti degli Apostoli. Si dice in esso che appena i discepoli «furono pieni di Spirito Santo» (At 2,4), si lanciarono in mezzo alla gente facendo le stesse cose che aveva fatto Gesù. Anche da essi usciva una forza che guariva e risuscitava i morti.
Il racconto della guarigione dello storpio presso la porta del Tempio chiamata «Bella» ne è un esempio. Esso segue immediatamente l’esperienza della Pentecoste. A quel povero storpio, nel cui corpo si annidava la morte sin dalla nascita, Pietro rivolge la parola per dirgli: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!», e poi, «presolo per la mano destra, lo sollevò». Il testo dice che «di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e balzato in piedi camminava; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio» (At 3,6). Si tratta, come si vede, di un’autentica risurrezione, di un trionfo della vita sulla morte operata nel nome di Gesù, il Messia di Nazaret, presente nella forza dello Spirito.
Più avanti il libro continuerà raccontando i prodigi operati dallo stesso Pietro nei seguenti termini: «Portavano gli ammalati nelle piazze, ponendoli su lettucci e giacigli, perché, quando Pietro passava, anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti immondi e tutti venivano guariti» (At 5,15-16). Non risulta difficile cogliere in questi testi un parallelo con quanto i vangeli raccontano dell’operato di Gesù.
Le manifestazioni dello Spirito riempiono non solo il libro degli Atti, ma anche un po’ tutti gli scritti del Nuovo Testamento. Particolarmente le lettere paoline, nelle quali esso si rende presente donando a tutti e ognuno dei membri delle comunità ecclesiali i suoi doni «per la comune utilità» (1Cor 12,7). È la forza divina che muove tutto e tutti nella direzione della vita. Come dice Paolo, «a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza; a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far guarigioni per mezzo dell'unico Spirito; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di distinguere gli spiriti; a un altro le varietà delle lingue; a un altro infine l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose è l'unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole» (1 Cor 12,8-11).
Alla constatazione della presenza dello Spirito in ciascuno e nelle comunità segue anche l’esortazione ad assecondare la sua mozione, lasciandosi muovere dalla sua forza che spinge verso la vivificazione di tutti e di ognuno. Purtroppo, tuttavia, questa mozione dello Spirito può essere ostacolata impedendole di arrivare a ciò che aspira. Lo stesso Paolo ammonisce i cristiani a lasciarsi guidare da lui, e non invece da altre forze o tendenze. Ecco alcune delle sue parole: «Quelli infatti che vivono secondo la carne, pensano alle cose della carne; quelli invece che vivono secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito. Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace» (Rm 8,5-6). Per Paolo «carne» è sinonimo di debolezza, concretamente, di quella debolezza radicale dell’essere umano che è l’egoismo, il quale è sempre fonte di morte. Qualcosa di analogo si ritrova in due altre testi paolini. Nel primo si legge: «E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione» (Ef 4,30); nel secondo, con ancora maggior concisione: «Non spegnete lo Spirito» (1Tes 5,19).
Ma forse le parole più incoraggianti da questo punto di vista sono quelle della lettera ai cristiani di Roma, nelle quale l’Apostolo afferma enfaticamente che «l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5), e poi, con logica consequenzialità, aggiunge: «Tutti quelli […] che sono mossi dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio» (Rm 8,14). Lo Spirito divino che è stata riversato nel cuore trasforma l’uomo in un figlio di Dio e lo spinge ad operare «spiritualmente», e cioè a dare vita. Come dirà qualche secolo più tardi S. Gregorio di Nazianzo, «noi siamo stati battezzati per convertirci in una forza vivificante per tutti gli uomini».
PER IL LAVORO PERSONALE E DI GRUPPO
Dopo aver riletto con attenzione i racconti di Mc 5, 21-43 e di At 3,1-6, cerca di dare una tua risposta a queste domande:
Sono convinto che la forza vivificante di Gesù (il suo Spirito) continua ad agire attraverso di lui anche nei miei riguardi? Com’è la mia fede, a confronto di quella della donna emorroissa?
Fino a che punto lascio che lo Spirito operi vivificantemente anche attraverso di me nei confronti degli altri?
Preghiera
Come è impressionante, Gesù, vederti agire con la forza dello Spirito!
Sei come una centrale di energia
che espande la sua forza vivificante attorno a sé.
Ai tuoi giorni, dove tu arrivavi
la Morte fuggiva sconfitta.
Per il battesimo io ho ricevuto il tuo Spirito.
Fa’ che lo lasci agire in me e attraverso di me,
così che possa anch’io irradiare energia vivificante
attorno a me. Amen.
Capitolo 6
IN GESÙ DI NAZARET, LO SPIRITO È CONOSCENZA PENETRANTE DELLE PERSONE E DEGLI AVVENIMENTI
Le persone gli diventano trasparenti
Una delle impressioni che si ricavano dalla lettura dei vangeli è che Gesù, proprio perché era pieno di passione per la vita della gente, vedeva chiaro dentro a ciascuno, e riusciva a penetrare fino in fondo nella sua intimità, scoprendo ciò che si portava dentro. La presenza dello Spirito vivificante di Dio in lui lo dotava di una chiaroveggenza particolare, che gli permetteva di leggere anche tra le pieghe del cuore. Il vangelo di Giovanni conferma tale impressione, riecheggiando probabilmente una convinzione comune dei suoi discepoli: «Non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro, egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo» (Gv 2,25). D’altronde, già nell’Antico Testamento si diceva che «la sapienza è uno spirito amico degli uomini […]. Lo spirito del Signore riempie l'universo e, abbracciando ogni cosa, conosce ogni voce» (Sap 1,6-7). I biblisti ci dicono che la «voce» di cui parla il testo equivale alla parola, e questa a sua volta equivale al pensiero, e cioè quello che c’è di più recondito nell’essere umano.
Ma tale convinzione non era propria solo dei discepoli; anche i suoi avversari la condividevano, a giudicare dalle parole che gli rivolsero in occasione della discussione intavolata sul pagamento del tributo all’imperatore. Introducendo il tema essi gli dissero, in un tono che sa certo di adulazione ma che permette anche di cogliere l’impressione che causava in loro: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno; infatti non guardi in faccia agli uomini…» (Mc 12,14). Quel «non curarsi di nessuno» e quel «non guardare in faccia agli uomini» si ricollegano ad una qualità attribuita a Dio stesso (At 10,34; Rm 2,11; Ef 6,9), che verrà poi raccomandata anche ai cristiani delle prime comunità (Gc 2,1.9): quella di non prendere in considerazione le apparenze delle persone, ma di badare a ciò che esse sono nella loro vera realtà. Gli avversari di Gesù gli riconobbero tale qualità. Si erano accorti che egli non restava in superficie, non prendeva in considerazione i titoli di grandezza o di onore, lo status sociale, la fama, la scienza e nemmeno l’apparente giustizia delle persone, ma le trattava per ciò che erano nel profondo dei loro cuori.
C’è un episodio che conferma tutto ciò. È quello della chiamata dell’uomo ricco - giovane, secondo Matteo (Mt 19,20) - a seguirlo. L’evangelista Marco è l’unico a riportare un piccolo dettaglio che risulta molto significativo da questo punto di vista. Egli afferma che, una volta rivoltagli la proposta circa il modo di raggiungere la vita eterna mediante l’osservanza dei comandamenti, e ricevuta da lui la risposta circa il cammino fatto fino allora in quella direzione, Gesù, «fissatolo, lo amò e gli disse: ‘Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi’» (Mc 10,21). Lo sguardo di Gesù doveva essere molto penetrante e arrivare alle profondità di quel cuore, tanto da provocare il movimento di amore verso di lui di cui parla il testo. Servì anche a svelare la vera e reale disposizione dell’interpellato.
Luca è la fonte di un’informazione esclusiva nel racconto della passione di Gesù, che ha qualcosa a che fare con quanto veniamo dicendo. Egli narra che Pietro, che era riuscito a infilarsi nel cortile della casa del sommo sacerdote nella triste notte del processo improvvisato nei confronti di Gesù, per ben tre volte rinnegò codardamente il suo amico e maestro davanti a quelli che lo accusavano di appartenere al suo gruppo. E, dopo la sua triplice negazione, «il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: ‘Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte’. E, uscito, pianse amaramente» (Lc 22,61-62). Anche in questo caso lo sguardo di Gesù si spinse fino alle più recondite pieghe del cuore di Pietro, svelandogli la pietosa condizione in cui si trovava e aiutandolo a prenderne coscienza. L’amaro pianto del discepolo fu lo sbocco naturale di quello sguardo e del suo effetto in un uomo sensibile e generoso come era Pietro.
Ancora un episodio evangelico rivela questa capacità di Gesù di andare in profondità nelle persone. È quello dello scontro con i suoi avversari in occasione della guarigione dell’uomo della mano inaridita, raccontato con diversità di sfumature dai tre sinottici (Mt 12,10-13; Mc 3,1-6; Lc 6,6-11). È Marco colui che ne rileva maggiormente i dettagli. Egli scrive che, al silenzio con cui i suoi avversari risposero alla domanda che egli poneva loro circa la liceità di fare il bene o il male, di salvare una vita o toglierla in giorno di sabato, essi tacevano. Allora lui, «guardandoli tutt'intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse a quell'uomo: ‘Stendi la mano!’. La stese e la sua mano fu risanata» (Mc 3,5). Il testo permette di capire con chiarezza quale sia stata la causa di quelle due reazioni avute da Gesù - sdegno e tristezza -: egli vedeva dentro a quegli uomini che passavano per «giusti» davanti agli altri perché si preoccupavano di osservare con grande scrupolo la Legge, e invece non erano capaci di pensare che la vita di un uomo era più importante della Legge stessa. Egli vedeva «la sclerosi dei loro cuori», dice espressamente l’evangelista. Il suo amore appassionato per la vita lo portava ad avere quella chiarezza di sguardo che gli rendeva possibile mettere a nudo la vera condizione delle persone.
Mediante lo Spirito Gesù scruta gli avvenimenti
Tra le tante sfaccettature della ricca personalità di Gesù di Nazaret colte dai suoi discepoli, ma anche dalla gente comune, c’è quella della sua qualità profetica. Egli viene riconosciuto più di una volta come profeta, secondo le narrazioni evangeliche (Mt 21,11.45; Mc 11,32; Lc 7,16; 24,19; Gv 4,19; 9,17). E perfino si pensa che egli sia «il Profeta», e cioè quell’altro Mosè che, in adempimento dell’annunzio di Dt 18,15-19 (cf Dt 34,10-12), sarebbe venuto a riprodurre le sue gesta (Gv 6,14; 7,40).
Come è risaputo, il profeta biblico non è colui che si specializza nell’indovinare il futuro, e nemmeno semplicemente colui che parla nel nome di Dio, come sembrerebbe suggerire la stessa etimologia del termine. La peculiarità dei profeti dell’Antico Testamento la si coglie se li si confronta con altre figure di rilievo presenti in esso. Infatti, i profeti si distinguono tanto dai saggi quanto dagli scribi maestri della Legge. E la distinzione fondamentale consiste precisamente nel fatto che, mentre questi ultimi si occupano rispettivamente di insegnare i modi migliori di vivere saggiamente o di dare spiegazioni sulle esigenze della Legge, i profeti esercitano la loro funzione soprattutto in rapporto agli avvenimenti storici del popolo. Ciò che li caratterizza, infatti, è la preoccupazione di mettersi all’ascolto dei movimenti storici e dei mutamenti del loro tempo. Perciò, tutta la loro attuazione è segnata da una straordinaria mobilità e da una grande flessibilità che li porta ad adeguare costantemente i loro discorsi a ciò che sta avvenendo in mezzo al popolo. È lo Spirito di Dio, presente in essi, che li porta a realizzare tale servizio al popolo, aiutandolo in questo modo ad assecondare l’azione di Dio nel tempo (Ez 2,2-8; 3,14; 11,1; ecc.).
In questo contesto si capisce il senso che possono avere le parole rivolte da Gesù in una certa circostanza ai farisei e sadducei che non erano capaci di cogliere la presenza di Dio nell’attività che egli stava svolgendo in mezzo al popolo: «Quando si fa sera, voi dite: ‘Bel tempo’, perché il cielo rosseggia; e al mattino: ‘Oggi burrasca’, perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi?» (Mt 16,3). Come capi del popolo avrebbero dovuto essere guidati dallo Spirito profetico, e perciò avrebbero dovuto essere capaci di discernere il grande avvenimento costituito dalla sua presenza. Ma purtroppo non lo erano, e così anziché aiutare il popolo ad aprirsi all’intervento di salvezza di Dio in Gesù, gli creavano degli ostacoli. Non per niente Gesù ebbe a dire: «Chi mette degli inciampi anche a uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare» (Mt 18,6; Mc 9,42). E anche, in altra circostanza: «Perciò io vi dico: qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parlerà male del Figlio dell'uomo sarà perdonato; ma la bestemmia contro lo Spirito, non gli sarà perdonata né in questo secolo, né in quello futuro» (Mt 12,31-32; Mc 3,28-29; Lc 12,10). La bestemmia contro lo Spirito Santo, come spiegano gli esegeti, consisteva nel rifiutarsi di riconoscere e accogliere la manifestazione di Dio in Gesù, di scoprire la sua offerta di salvezza nella sua parola e nella sua azione attribuendole, anziché allo Spirito di Dio, a spiriti addirittura «immondi» (Mc 3,30).
A differenza di quegli uomini, Gesù dà chiari segni di possedere uno spiccato Spirito profetico che gli conferisce la capacità di interpretare gli avvenimenti del popolo alla luce di Dio. Anzitutto, il grande avvenimento dell’imminente arrivo del regno di Dio. Se si lancia nell’attività in mezzo alla gente, è precisamente perché ha letto «i segni dei tempi» ed è arrivato alla conclusione che, come dice il vangelo di Marco, «il regno di Dio è alle porte» (Mc 1,14-15). Ma, all’interno di questo discernimento globale, egli va anche scandagliando ciò che succede attorno a lui, cogliendovi la presenza o l’assenza del regno annunciato.
Qualche volta la percezione che ne ha è così forte e chiara, che lo fa prorompere in una preghiera di benedizione e ringraziamento a Dio, come quando dice: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te» (Mt 11,25-26). Si tratta della constatazione dell’accoglienza che la sua proposta sta avendo presso i piccoli e i poveri, un segno evidente della venuta del regno. Luca dice che questa preghiera egli la fece «esultando nello Spirito Santo» (Lc 10, 21).
Altre volte, invece, il discernimento profetico gli costò più fatica e sforzo. In particolare quello fatto in mezzo all’angoscia e al turbamento nei confronti della sua stessa morte. La travagliata preghiera nell’Orto degli Ulivi ne è una chiara testimonianza. Ma, come dirà la Lettera agli Ebrei, egli finì per scoprire il denso significato della sua morte grazie allo Spirito che lo guidava: «Cristo, […] con uno Spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio» (Eb 9,14).
Comunità profetiche, piene di Spirito Santo
Abbiamo già ricordato la convinzione delle prime comunità cristiane circa l’effusione pasquale dello Spirito. Esse erano profondamente certe del fatto che Gesù, una volta risorto, lo riversava sui suoi seguaci. E questo Spirito si convertì anche in loro in fonte di profezia.
Risulta molto illuminante, da questo punto di vista, il racconto lucano dei due discepoli di Emmaus (Lc 24,13-34). Gesù risorto aiuta due dei suoi seguaci, che nello stesso giorno della Pasqua si allontanano tristi e scoraggiati da Gerusalemme, ad andare a fondo nell’esame di «quanto era accaduto» (v.18) in quei giorni a Gerusalemme, e a scoprirvi il compimento delle profezie dell’Antico Testamento riguardanti il futuro messia, e quindi l’arrivo del regno promesso da Dio. Si potrebbe dire che essi diventarono così profeti dell’evento per eccellenza della storia. Gesù, comunicando loro il suo stesso Spirito, li fece chiaroveggenti come lui.
Di tale capacità profetica ci sono abbondanti testimonianze negli scritti del Nuovo Testamento, soprattutto negli Atti degli Apostoli. Tra tutte merita particolare attenzione quella riguardante la decisione presa circa l’ingresso di uomini e donne non giudei nella comunità dei credenti in Gesù risorto. Fu un avvenimento carico di conseguenze, perché aprì il cristianesimo alle dimensioni del mondo. Davanti alla sfida che esso significava, la comunità di Gerusalemme, e particolarmente i suoi capi, furono chiamati ad elaborare un molto attento ed impegnativo discernimento, nel quale il ruolo dello Spirito fu decisivo. Infatti, alla fine del processo che vide impegnata l’intera comunità, gli Apostoli inviarono ai fratelli non giudei di Antiochia una bellissima lettera in cui in sostanza si diceva: «Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie […]» (At 15,28). È che, come dirà più tardi S. Paolo scrivendo ai Corinzi, «a noi Dio ha rivelate [queste cose] per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio (1 Cor 2,10).
Il Concilio Vaticano II, rinnovando in profondità il modo di pensare la chiesa, mise in risalto in maniera del tutto particolare la vocazione profetica dell’intero popolo di Dio. Già nella Costituzione Lumen Gentium fece delle affermazioni molto rilevanti al riguardo (LG 12.35), ma fu soprattutto nella Costituzione Gaudium et Spes che prese in considerazione tale vocazione profetica. Al n.4 si afferma che la chiesa, per svolgere la sua missione di servizio all’umanità alla quale è chiamata, deve cercare di «scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo» e, con ancora maggior precisione, al n.11 asserisce che il popolo di Dio si deve sforzare «di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, i segni veri della presenza o del disegno di Dio». In questo testo addita anche la fonte dalla quale sgorga tale discernimento: «lo Spirito del Signore che riempie l’universo». È questo Spirito, lo stesso che muoveva Gesù e gli dava uno sguardo penetrante nei confronti della storia, quello che spinge i suoi discepoli nella stessa direzione. Solo così possono essere dei veri profeti in mezzo al mondo, e contribuire alla sua vivificazione secondo il disegno divino.
PER IL LAVORO PERSONALE E DI GRUPPO
La presenza dello Spirito nel suo cuore rendeva Gesù capace di leggere in profondità dentro agli altri. Ciò avveniva perché il suo era uno Spirito di amore fraterno che lo riempiva di una passione incontenibile per la vita. Confrontati con lui per vedere fino a che punto succede lo stesso con te.
Inoltre, lo stesso Spirito rendeva Gesù lucido nei confronti degli avvenimenti piccoli e grandi. Ti senti profeta come lui in questo senso? Sei capace di discernere in ciò che capita in te e attorno a te i veri segni del grande progetto di Dio?
Preghiera
Gesù, dammi il tuo Spirito.
Fa’, te lo chiedo fiduciosamente,
che riempia totalmente il mio cuore,
come riempiva il tuo,
di quella irresistibile passione per la vita,
che dia lucidità ai miei occhi
e li renda penetranti come i tuoi.
Allora potrò essere, alla tua scuola,
un profeta che illumina il cammino
verso la realizzazione del piano di Dio
per la felicità di tutti. Amen.
Capitolo 7
IN GESÙ DI NAZARET, LO SPIRITO È CORAGGIO E TENACIA
Non c’è difficoltà che lo faccia indietreggiare
Che Gesù di Nazaret appaia nei vangeli come un uomo pieno di determinazione e di coraggio è un dato incontrovertibile. Sin dall’inizio della sua attività egli causa una forte impressione globale di uomo deciso e per niente pauroso. Lo si vede come uno che non indietreggia davanti alle difficoltà né retrocede in presenza degli ostacoli che si frappongono tra ciò che persegue e la sua realizzazione. Sembra ispirarsi a questo suo ritratto ciò che dice uno scritto del Nuovo Testamento indirizzato a chi presiede una comunità dei primi tempi della chiesa: «Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza» (1 Tim 1,7). È quindi lo Spirito presente in Gesù che produce questo effetto di eliminare in lui ogni timidezza e di riempirlo di forza e di coraggio, dandogli una costanza imbattibile.
Alcuni dati dei vangeli concretizzano tale impressione. Uno di essi è il racconto delle tre tentazioni da lui subite durante i quaranta giorni passati nel deserto, prima di lanciarsi all’attività per il regno di Dio (Mt 4,1-11; Mc 1,12-13; Lc 4,1-13). La narrazione è ovviamente una schematizzazione operata dagli evangelisti dei diversi momenti in cui egli affrontò delle tentazioni, ma certamente ha un riscontro sostanziale nell’esperienza da lui vissuta. Ciò che vi si coglie è il fatto che Gesù dovette affrontare e superare più di una volta l’attrazione verso certi modi di portare avanti la sua attività messianica che non coincidevano con quanto pensava Dio, come egli stesso dirà posteriormente in un suo dialogo con Simon Pietro (Mt 16,23; Mc 8,33). In concreto, un modo che faceva leva più sulla forza, il potere e il prestigio che sul servizio generoso e sacrificato (cf Mt 20,28; Mc 10,45; Gv 13,14). Ora, come fanno notare gli stessi evangelisti, la fonte dalla quale sgorgava la forza per resistere con grande determinazione a tali attrattive era lo Spirito che, stando alle loro parole, «lo condusse nel deserto per essere tentato da satana» (Mt 4,1; cf Lc 4,1). Presente in lui lungo tutta la sua vicenda, lo sorresse costantemente e gli diede quella tenacia che dimostrò di avere fino alla fine. Tra l’altro, lo aiutò ad appoggiarsi sempre sulla Parola di Dio trasmessa dalla Bibbia, nella quale trovò la luce per superare il sottile insinuarsi delle tenebre. Nel racconto, infatti, alla triplice proposta di satana egli risponde dicendo: «Sta scritto…».
Un secondo dato fornito dai vangeli è quello riguardante la sua reazione davanti alle persecuzioni e minacce che sollevava il suo modo di comportarsi. Uno dei motivi che le scatenarono fu il fatto di operare delle guarigioni di sabato. Come vedremo in seguito, ciò faceva parte del suo grande spirito di libertà nei confronti della Legge. La sua appassionata preoccupazione per la vita in pienezza delle persone lo portava a non badare a certe prescrizioni legali, almeno secondo le interpretazioni che ne venivano fatte da alcuni rabbini. E ciò scatenava le loro reazioni contro di lui. Uno dei tanti casi ricordato dai vangeli è quello della guarigione in sabato dell’uomo che da trentott’anni giaceva paralizzato vicino alla piscina di Bethesda, e attendeva che qualcuno gli desse una mano per entrare nelle acque quando queste si agitavano poiché, secondo la credenza popolare, era un angelo chi le muoveva e producevano delle miracolose guarigioni (Gv 5,1-5). Gesù gli si avvicinò e lo guarì. Ma, come dice Giovanni, «per questo i Giudei cominciarono a perseguitare Gesù, perché faceva tali cose di Sabato» (Gv 5,16). Egli però non si ritrasse né dimostrò di avere paura davanti alle loro reazioni. Al contrario, rispose loro con piena sicurezza e determinazione: «Il Padre mio opera sempre e anch'io opero» (Gv 5,16-17).
Oltre ai «giudei», come li chiama il quarto evangelista, c’era qualcun altro che vigilava il suo operato e non ne era soddisfatto: il re Erode. Governatore della Galilea, cliente dei romani che lo sostenevano, egli temeva ogni manifestazione che avesse il sentore di messianismo, perché poteva originare della reazioni popolari e con ciò l’intervento repressivo degli rappresentanti imperiali. Ai suoi orecchi arrivarono certamente notizie circa l’attività e la fama di Gesù di Nazaret. Luca dice che ad un certo punto «si avvicinarono alcuni farisei a dire a Gesù: ‘Parti e vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere’». La sua risposta fu netta e tagliente: «Andate a dire a quella volpe: ‘Ecco, io scaccio i demoni e compio guarigioni oggi e domani; e il terzo giorno avrò finito’» (Lc 133,31).
Più tardi, «mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse decisamente verso Gerusalemme» (Lc 9,51). L’avverbio usato dall’evangelista Luca è molto significativo. Infatti, come racconta a sua volta Giovanni, mentre il cerchio dei suoi oppositori si stringeva sempre di più attorno a lui, egli decise di tornare nella Giudea, dove il rischio era più incalzante perché lì si trovavano i capi religiosi e politici che lo osteggiavano. Non appena gli arrivò la notizia della morte del suo amico Lazzaro a Betania, disse ai suoi discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea»; al che essi reagirono obiettando: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». La risposta di Gesù non si fece attendere, ed è degna del coraggio da lui sempre dimostrato: «Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo» (Gv 11,7-9). E tornò nella Giudea, dove strappò dal sepolcro Lazzaro, scatenando la reazione delle autorità che lo portò alla croce.
Gesù inculca il coraggio ai suoi seguaci
Oltre a vivere coraggiosamente, Gesù cercò di infondere lo stesso coraggio in coloro che lo seguivano. Le parole da lui dette in questo senso sono numerose nei vangeli. Ne scegliamo solo alcune, a modo di esempio. In esse si vede come egli volesse contagiare il suo Spirito per niente pauroso, agli altri.
La prima s’inquadra nell’episodio della tempesta che mise i discepoli in pericolo di annegare nel lago di Galilea, e con loro lui stesso che si trovava nella barca. La narrazione ha un carattere altamente simbolico, ma ha anche alla base un fatto storico. Ad ogni modo, offrì agli evangelisti l'opportunità di trasmettere una frase molto importante di Gesù. Dicono infatti i racconti che, mentre essi erano in piena navigazione, si sollevò un gran vento che gettava le onde nella barca, tanto che ormai ne era piena. Intanto Gesù se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t'importa che moriamo?». Egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? (Mc 4,37-40; Mt 8,24-26).
Insieme a questa esortazione, che nel contesto suona a rimprovero, ce n’è una seconda pronunciata in un’altra occasione, che ha più dell’incitamento. Egli disse infatti ai suoi discepoli nel momento di inviarli ad annunziare il vangelo, attività nella quale avrebbero trovato mille difficoltà e pericoli: «Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima […]. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro ne tenga conto. Non abbiate dunque timore: voi valete più di molti passeri!» (Mt 10,28.31). Il testo mette bene in evidenza il motivo radicale di questo coraggio che supera la paura: è la fiducia in Dio che, quale Padre buono, ha cura di tutti, anche di quegli uccellini che non contano nulla quali sono i passeri. La fonte ultima dalla quale promana tale fiducia è quindi lo Spirito di figliolanza nei suoi confronti.
Più tardi, nell’ultima cena fatta con i suoi, Gesù ci tenne a ribadire questa raccomandazione. Nell’atmosfera d’intimità in cui ebbe luogo quell’incontro amicale, egli disse ai suoi commensali quasi a modo di testamento: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore» (Gv 14,27).
Un coraggio che vince la paura
Non sarebbe completo il quadro che stiamo dando se non prendessimo in considerazione un dato che, con grande realismo e notevole oggettività, hanno trasmesso i vangeli: questo Gesù che si presenta ordinariamente così determinato e coraggioso, ebbe anche a combattere personalmente con la paura. E con una paura che arrivò ai livelli più intensi che si possano raggiungere umanamente parlando.
Avvenne negli ultimi giorni della sua vita, e precisamente nel momento di affrontare la morte. Quando ormai la sua chiaroveggenza gli faceva prevedere l’imminente e tragica fine della sua attività in favore del regno di Dio, egli si sentì brutalmente assalito dalla paura. L’evangelista Marco, con termini che non nascondono la realtà di quanto è avvenuto, dice che, dopo la cena fatta con i discepoli, egli, raggiunto l’Orto degli Ulivi dove era solito andare la notte per pregare, «prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e cominciò a sentire paura e angoscia mortali» (Mc 14,33). E Luca aggiunge che la sua angoscia era tale, che «il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra» (Lc 22,44). Fu necessario il ricorso quasi disperato al suo spirito filiale nei confronti di Dio - è qui che lo chiamò «Abbà», secondo Mc 14,36 - per emergere dal baratro in cui l’aveva gettato la paura. E ne emerse. Ed ebbe la forza di resistere fino alla fine, morendo in un totale atto di abbandono fiducioso in Dio (cf Lc 24.46).
I discepoli, eredi del coraggio di Gesù
I racconti evangelici non presentano i discepoli di Gesù come particolarmente coraggiosi. Anzi, come abbiamo visto, più di una volta fanno fare loro la figura dei paurosi (cf Mt 8,25-26; 14,26; 26,56; Mc 4,40; 14,50; Lc 9,45; Gv 6,19). Qualche rara eccezione (Mt 26,51; Gv 11,16) conferma l’impressione generale.
Gesù li trova anche così, pieni di paura, dopo la sua risurrezione (Gv 20,19). Ma, comunicando loro il suo Spirito, li trasforma in uomini pieni di coraggio. Dice infatti Giovanni che la sera dello stesso giorno della Pasqua, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: ‘Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi’. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ‘Ricevete lo Spirito Santo […]’ (Gv 20,19.22).
Nel libro degli Atti degli Apostoli una delle caratteristiche più rilevanti nei seguaci di Gesù risorto, insieme alla gioia che li inonda, è quella del coraggio e della determinazione con cui affrontano le difficoltà che vanno sorgendo nel cammino del loro impegno per l’annuncio della Buona Novella. E ciò, precisamente, come conseguenza della venuta a loro dello Spirito nel giorno della Pentecoste e in diverse altre occasioni. Sembrano realmente trasformati. Essi, che prima si rinchiudevano «per paura ai Giudei» (Gv 20, 19), non temono ora di sfidarli apertamente anche col rischio della loro libertà e della stessa loro vita, suscitando anche il loro stupore (At 4,13.31).
Paolo spicca particolarmente per questo coraggio (At 9,27.28; 13,46; 14,3; ecc). E non solo lo vive, ma anche lo inculca ai membri della sue comunità. Tra le sue esortazioni in questa direzione merita particolare attenzione quella della Lettera ai Romani , già ricordata precedentemente, in cui si appella allo Spirito che abita nei loro cuori per invitarli a vivere da coraggiosi: «Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: ‘Abbà, Padre!’» (Rm 8,15). Certo, il testo si riferisce espressamente al rapporto con Dio, nel quale la condizione filiale deve prendere il sopravvento su ogni forma di paura, ma indubbiamente si può estendere più in là di tale ambito, fino ad abbracciare l’intera esistenza. È quello che si legge nel bellissimo testo della Prima Lettera di Giovanni: «Nell'amore non c'è timore, al contrario l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore» (1 Gv 4,18).
I martiri cristiani di tutti i tempi - forse ancora più chiaramente i più giovani - sono una luminosa dimostrazione di come lo Spirito di Gesù sia fonte di forza e di coraggio per superare gli ostacoli che si oppongono alla coerenza della fede. Si può davvero dire che essi, come lui, «non hanno ricevuto uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza» (1Tim 1,7). Anch’essi, come lui, hanno avuto quella costanza che li ha portati al conseguimento della grande Promessa (cf Eb 10,36).
PER IL LAVORO PERSONALE E DI GRUPPO
Può darsi che, confrontandoti con Gesù, ti ritrovi incostante e anche pusillanime. Hai ceduto tante volte davanti alle difficoltà! Forse ti hanno bloccato i giudizi leggeri degli altri, le opposizioni al tuo modo di fare, il desiderio di fare bella figura… Hai mollato presto e hai lasciato cadere le braccia. Pensa a come invece la presenza dello Spirito può darti la capacità di resistere davanti a tutti e a tutto, e anche la forza di ricominciare sempre da capo.
Preghiera
Spesso non sono un portento di coraggio, Gesù.
Mille cose mi fanno tremare
e mi portano a sottrarmi a ciò che ho intravisto
come buono e positivo.
Vorrei avere più coraggio e più costanza,
vorrei essere un po’ più «santamente cocciuto» come te
e come Dio, tuo e mio Padre.
Se tu mi dai il tuo Spirito,
questo piccolo grande miracolo può avvenire in me.
Avrò anch’io la «divina testardaggine» dell’amore,
e l’amore caccerà la paura dal mio cuore.
Amen.
Capitolo 8
IN GESÙ DI NAZARET, LO SPIRITO È SORGENTE VIVA DI PREGHIERA
Una atmosfera interiore
Anteriormente, parlando dello Spirito di figliolanza di Gesù, abbiamo accennato di passaggio alla sua preghiera. Ora ci soffermiamo più espressamente sul tema.
Come ogni pio ebreo dei suoi tempi, Gesù ha certamente pregato in privato e in pubblico. Infatti, gli ebrei pregavano comunitariamente, in particolare quando si radunavano il sabato nella sinagoga per ascoltare la lettura della Scrittura e il suo commento, o quando partecipavano alle solenni celebrazioni nel tempio, o ancora quando compivano dei riti familiari come nel caso della cena pasquale. Dai testi evangelici (Lc 4,16; Mt 26,17-18; ecc.) si desume che Gesù vi partecipò anche durante il tempo della sua attività pubblica, e che quindi visse con il resto della gente questi intensi momenti di preghiera. Possiamo immaginare con quanto slancio di spirito l’abbia fatto, data la sua profonda convinzione della vicinanza di Dio.
Ma gli ebrei erano abituati a pregare anche personalmente diverse volte al giorno, dal primo mattino fino al momento di coricarsi, seminando la giornata di benedizioni e di ringraziamenti a Dio per averli creati, per aver fatto tutte le cose per il loro bene, per aver scelto il loro popolo come sua proprietà peculiare, per essere venuto in suo soccorso nei momenti difficili, a cominciare da quello della liberazione dalla schiavitù in Egitto… Non mancavano nelle loro preghiere le suppliche per ottenere aiuto nelle più svariate circostanze della vita, e anche le richieste di perdono per le infedeltà all’alleanza espresse nella violazione della Legge da Lui data. Basta leggere certi salmi per averne degli esempi meravigliosi. Come quello attribuito al re Davide (Sal 50) nel momento in cui prese coscienza, tramite la parola del profeta Natan, del suo grave peccato d’ingiustizia (2 Sam 12,1-13). È tutto un intreccio di pentimento, di suppliche, di benedizioni al Dio che scandaglia i cuori e che è sempre disposto a perdonare chi si pente. Possiamo pensare con ragione che Gesù abbia imparato questi diversi modi di pregare in grembo alla sua famiglia e, particolarmente dall’esempio di Giuseppe, che il vangelo qualifica «giusto» (Mt 1,19) e quindi uomo veramente credente. Doveva essere davvero un uomo pieno di spirito di preghiera.
Più di una volta gli evangelisti, e particolarmente Luca, danno delle informazioni sulla preghiera personale di Gesù (Mc 1,35; Lc 3,21; 6,12; 9,29; 11,1). Di solito senza dire qual era il suo contenuto, tranne in due casi: quello della gioiosa benedizione uscita dal profondo del suo cuore nel costatare l’accoglienza del suo annuncio da parte dei piccoli e dei semplici (Mt 11,25-26; Lc 10,21), e quello della travagliata notte nell’Orto del Getsemani (Mt 26, 39-44; Mc 14,35-39; Lc 22,41-42).
È molto significativa la prima preghiera, perché mette molto bene in risalto il rapporto della preghiera di Gesù con lo Spirito Santo. Luca, a differenza di Matteo, la introduce infatti con queste parole: «In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito» (Lc 10,21). Lo Spirito è quindi come un’atmosfera interiore nella quale si generano quella gioia e quella esultanza che egli esprime nel grido di benedizione rivolto a Colui che l’ha inviato ad annunziare la Buona Novella ai piccoli.
Nel racconto della dolorosa preghiera fatta al Getsemani lo Spirito non viene menzionato, ma lo si coglie tra le righe. È presente come atteggiamento filiale verso Colui che, come dice la Lettera agli Ebrei, «poteva liberarlo dalla morte» (Eb 5,7). Lo Spirito di figliolanza che lo riempie lo muove in quel frangente a «offrire preghiere e suppliche con forti grida e lacrime» a suo «Abbà». Si tratta di un’effusione filiale che, in mezzo all’angoscia più profonda, lo porta a cercare in Lui rifugio e forza. Le tenebre avvolgono il suo cuore, ma egli lotta fino a sudare sangue (Lc 22,44) per trovare la luce, nella convinzione che il suo Padre non lo abbandona. «Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore?», recitava il salmista nell’Antico Testamento (Sal 27,1): non è improbabile che Gesù l’abbia ricordato in quei momenti terribili.
Non si trovano nei vangeli dei dati che portino ad affermare che Gesù abbia rivolto delle preghiere allo Spirito. Egli prega sempre il Padre. Lo Spirito è invece come l’atmosfera nella quale la sua preghiera si genera e si svolge, come la sorgente viva dalla quale sgorga e zampilla.
Alla scuola di preghiera di Gesù
Nel vangelo di Luca si legge che «un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: ‘Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli’. Ed egli disse loro: ‘Quando pregate, dite: Padre […]» (Lc 11,1-2). Doveva essere molto colpito dal modo in cui egli pregava e anche della novità di tale modo perché gli facesse quella richiesta. La sua era una maniera di rivolgersi a Dio del tutto particolare, precisamente perché aveva un modo molto particolare di intendere Dio stesso. Con un Dio al quale ci si rivolge chiamandolo «Abba», non si può avere se non un determinato tipo di rapporto.
E così, i primi discepoli impararono da Gesù a pregare. Tra l’altro, ci tramandarono la bellissima preghiera del «Padre nostro», che i cristiani di tutti i secoli hanno continuato a recitare. È interessante il fatto che, uno dei modi d’invitare i membri della comunità liturgica a recitarla durante la celebrazione dell’Eucaristia da parte del presidente sia il seguente: «Il Signore ci ha donato il suo Spirito; con la fiducia e la libertà dei figli diciamo […]». L’appellarsi allo Spirito del Signore, ossia di Gesù vivo e risorto, è un riconoscere che solo mossi da esso la preghiera può essere autentica. Il suo è uno Spirito di fiducia e di libertà, precisamente perché è uno Spirito di figliolanza, quello con cui egli visse tutta la sua vita.
Oltre ad insegnare a pregare con questo Spirito, Gesù insegnò anche a chiederlo al Padre. Non può passare inavvertita, in questo contesto, la peculiarità con cui Luca tramanda le sue parole riguardanti la preghiera di supplica. Dopo aver ricordato la sua esortazione a farla con fiducia e insistenza, egli riporta queste sue parole: «Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!» (Lc 11,11-13). Le «cose buone» che il Padre celeste dà a chi gliele chiede con fiducia secondo il vangelo di Matteo (Mt 7,11), in Luca sono state sostituite dallo «Spirito Santo». È questo Spirito che occorre chiedere a Dio, perché lo Spirito è la fonte di ogni altro bene.
I cristiani delle prime comunità recepirono questi insegnamenti di Gesù, e li misero in pratica, come si vede nel libro degli Atti degli Apostoli. Essi pregavano assiduamente (At 1,14; 2,42; 3,1; 4,24-30; 6,4; 11,4; 12,5; ecc.). È interessante rilevare che, secondo quella narrazione, in qualche occasione dopo la preghiera fervente della comunità si ebbe un rinnovamento della Pentecoste con la venuta vistosa dello Spirito su di essa. Così, per esempio, in At 4,31 dove si legge: «Quand'ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza».
I gemiti dello Spirito
Gli inviti fatti da Paolo ai membri delle diverse comunità a pregare sono numerosi. Si trovano quasi ad ogni passo nelle sue lettere (Rom 12,12; 15,30; 1 Cor 7,5; Ef 6,18; Col 4,2; 1 Ts 5,17, ecc.). In qualche lettera l’invito è espressamente quello di pregare «nello Spirito» (Fl 4,6).
Uno dei testi più ricchi in questo senso è quello della Lettera ai Romani nel quale l’Apostolo, dopo aver parlato delle «doglie del parto» a cui è soggetta l’intera creazione, che è in attesa della liberazione dalla vanità alla quale è stata sottomessa, sostiene che anche noi gemiamo interiormente aspettando la piena adozione a figli di Dio, e perciò anche la conseguente liberazione del nostro corpo da tutto ciò che lo opprime. Poi aggiunge che «lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili» (Rm 8,26). Così, lo Spirito filiale che è in noi, e che ci fa gridare come Gesù: «Abbà» (Rm 8,15), si converte nel nostro intimo in fonte di preghiera. La sua stessa presenza nei cuori dei credenti è come una supplica e un gemito, perché è soltanto una caparra che aspira ad essere presenza in pienezza, come quella che si dà in Gesù Cristo risuscitato, il quale è diventato «Spirito datore di vita» (1 Cor 15,45). Paolo aggiunge che «colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio» (Rm 8,27). Il Padre, che vede nel segreto dei cuori (Mt 6,4.6.18), percepisce i gemiti che salgono da essi come aspirazione alla condizione filiale definitiva. E si capisce che non è un vedere e un udire indifferente, ma pieno di efficace sollecitudine, come quella che Egli manifestò quando, come racconta il libro dell’Esodo, apparve a Mosè nel roveto ardente e gli disse che aveva «osservato la miseria del suo popolo in Egitto» e aveva «udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti», ed era «sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da quel paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele» (Es 3,7-8).
PER IL LAVORO PERSONALE E DI GRUPPO
Rileggi Lc 11,1-2. Immagina di essere tu quel discepolo che, impressionato dal modo di pregare di Gesù, gli chiede di insegnargli a pregare come pregava lui. Lasciati impressionare dalla sua forma di pregare, così intensa, così impregnata di intimità e di familiarità con il Padre. E pensa che quell’atmosfera interiore nella quale si muove la sua preghiera, è lo Spirito, quello Spirito di figliolanza che riempiva il suo cuore.
Poi, con calma, cercando di sentire la soave presenza dello Spirito filiale di Gesù in te, di’ lentamente, assaporando ogni parola, la preghiera che egli ci insegnò a dire: Padre nostro…
Questa prospettiva individuale della preghiera «nello Spirito» si apre ad una sua prospettiva universale nell’ultimo libro del Nuovo Testamento, l’Apocalisse, che chiude la visione della travagliata storia di Dio con gli uomini precisamente con queste parole: «Lo Spirito e la sposa dicono: Vieni!» (Ap 22,17). L’intera comunità dei discepoli di Gesù - la sposa - prega in sintonia con lo Spirito perché arrivi finalmente il giorno della sua venuta, e cioè il giorno del pieno adempimento di quanto egli stesso proclamò durante la sua vita: il regno di Dio apportatore della grande e definitiva realtà del cielo nuovo e della terra nuova da lui promessa (Ap 21,1).
Capitolo 9
IN GESÙ DI NAZARET, LO SPIRITO È PERDONO DEI PECCATI
Una accoglienza sconvolgente
L’abbiamo già accennato in precedenza: quelli che erano considerati ufficialmente peccatori in Israele, lo fossero o no personalmente, erano molti ai tempi di Gesù. I rabbini avevano perfino elaborato delle liste nelle quali includevano svariate categorie di persone: pubblicani e prostitute, ciechi, paralitici, sordi, pastori, figli naturali... A questi si aggiungevano tutti quelli che, sia per ignoranza sia per negligenza, violavano la santa Legge di Dio data attraverso Mosè. Molti di loro, e particolarmente i più emarginati tra essi, erano considerati come il rifiuto del popolo, come maledetti da Dio (cf Gv 7,49) ed esclusi dalla partecipazione al suo regno promesso, e finivano per considerarsi tali. Qualche rabbino attribuiva ad essi il ritardo nella venuta del regno di Dio. Una condizione socio-religiosa che più di una volta si accompagnava anche a penose malattie psichiche e perfino corporali. Non è da escludere, secondo quanto pensano alcuni studiosi dei vangeli, che le tante infermità diffuse tra la gente semplice del popolo - paralisi, cecità, sordità... - fossero in più di un caso conseguenze di tale situazione. Certo, essi non avevano pace e serenità nei loro cuori; anzi, non di rado il peso delle loro colpe li soffocava interiormente.
Gesù, che in tutta la sua attività era mosso dallo Spirito di Dio, assunse un atteggiamento ed ebbe una condotta nei loro confronti completamente contrari a quelli di coloro che si ritenevano giusti e a posto davanti a Dio. Proprio perché lo Spirito che lo muoveva era uno Spirito «amico dell’uomo» (Sap 7,23) e si manifestava come passione per la vita di tutti (Gv 10,10), egli non poteva passare indifferente accanto a coloro che si sentivano male. E tanto meno poteva condannarli all’esclusione. L’evangelista Luca, introducendo quelle tre gemme letterarie che sono le cosiddette «parabole della misericordia», antepone alla loro narrazione un dato di grande importanza per capirne il senso: «Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: ‘Costui riceve i peccatori e mangia con loro’. Allora egli disse loro questa parabola […]» (Lc 15,1-3). Le parabole narrate - quelle della pecorella smarrita, della moneta perduta e del figlio prodigo - sono quindi un modo di giustificare il suo modo di agire, censurato dai suoi avversari.
E il suo modo di agire era veramente sconvolgente e anche urtante per la sensibilità diffusa. Nessun giusto si sarebbe permesso mai di sedere a tavola con un peccatore. Significava fare comunione con lui, e quindi condividere in certo modo la sua condizione. Era contrarre la sua stessa impurità. Già il primo salmo della Bibbia enunciava tassativamente: «Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti» (Sal 1,1). Il parallelismo tipico della poesia ebraica permette di capire che peccatori e stolti sono la stessa cosa, e che sedersi in loro compagnia non è in nessun modo onorevole. E l’autore del Sal 141 faceva quest’ardente supplica a Dio: «Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male e compia azioni inique con i peccatori: che io non gusti i loro cibi deliziosi» (v.4). A sua volta, quello del Sal 139 esprimeva, quasi come con un sospiro, questo profondo desiderio: «Se Dio sopprimesse i peccatori!» (v.19).
Gesù, invece, non solo siede a mensa con loro, ma li invita egli stesso a partecipare della sua mensa. La frase che esprime l’accusa dei suoi avversari - «riceve i peccatori» - lascerebbe capire, almeno secondo alcuni studiosi, che egli organizzava dei piccoli banchetti nella casa dove di solito abitava, quella di Pietro e Andrea a Cafarnao, convertita in centro delle sue attività (Mc 1,29.33; Mt 8,14; Lc 4,38), e ad essi invitava coloro che gli scribi e i farisei ritenevano degni di esclusione e di disprezzo. Era come dire ai peccatori che non era vero che Dio non voleva loro bene, che non si dovevano sentire esclusi dal regno, che la tenera sollecitudine del Padre, come quella del pastore che lascia le novantanove pecore nell’ovile per andare alla ricerca dell’unica che se n’era andata per conto suo (Lc 15,4-7), li avvolgeva interamente, e che Egli li attendeva con immenso amore, come il padre di quel figlio che se ne era andato da casa sbattendogli la porta in faccia (Lc 15,21-24), e con grandissima gioia, come la donna che ritrovava la sua moneta smarrita (Lc 15,8-10).
Ci sono due episodi evangelici che fanno toccare con mano con quale Spirito Gesù accoglieva i peccatori. Nei due casi si tratta, a dire il vero, di peccatrici. Il primo è quello narrato dal vangelo di Giovanni nel quale una donna, sorpresa in flagrante adulterio e quindi meritevole della pena di morte per lapidazione secondo la Legge (Lv 20,10; Dt 22,22-24), viene trascinata ai suoi piedi affinché egli decida sulla sua sorte. Al di là della avvedutezza con cui egli risolve la questione, mettendo in crisi gli stessi che la denunciano (Gv 8,7), è impressionante la finezza e il tatto con cui affronta la sua situazione: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?», le domanda vedendola tremare, con la testa china, dopo che i suoi accusatori se ne sono andati uno dietro l’altro, a cominciare dai più anziani. Ed essa risponde: «Nessuno, Signore». E Gesù: «Neanch'io ti condanno; va’ e d'ora in poi non peccare più» (Gv 8, 10-11).
L’altro è quello raccontato da Luca e riguarda anche una donna, questa volta una pubblica peccatrice, e quindi una prostituta. Essa, che stando alle condizioni stabilite dalla Legge per la purificazione dai peccati avrebbe trovato quasi impossibile raggiungerla, data la sua situazione, concepisce un piano socialmente inaccettabile per la mentalità dei giudei: avvicinarsi a Gesù mentre egli era adagiato a mensa in casa di Simone il fariseo (Lc 7,36.40), versare sui suoi piedi le lacrime amare del pentimento, asciugarglieli con i suoi capelli, e cospargerglieli con l’olio profumato. Davanti al suo operato, chiunque avrebbe avuto la reazione spontanea che ebbe l’ospite: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che tocca i suoi piedi: è una peccatrice!» (Lc 7,39). Lasciarsi toccare da una peccatrice significava contrarre la sua impurità legale, ed essere obbligato al complesso processo di purificazione prescritto nei libri sacri. Un profeta, un santo di Dio, non avrebbe dovuto mai permettere qualcosa del genere. Ma Gesù lo permise. Non si curò per niente di ciò che quel contatto inopportuno produceva legalmente in lui, ma s’interessò unicamente della condizione miserevole della donna. E, dopo un dialogo con il suo ospite, mirato a fargli prendere coscienza della reale situazione delle cose, rivolgendosi alla donna le disse: «Ti sono rimessi i tuoi peccati» (Lc 7,49). Il passivo sta ad indicare il soggetto che li rimetteva, e cioè Dio stesso. Egli si prese la responsabilità di dichiarare alla donna, nel nome di Dio, che i suoi innumerevoli peccati erano stati cancellati - questo significa in concreto «remissione» - perché aveva molto amato. Tolse, quindi, dalla sua coscienza, quel peso enorme che la schiacciava e la soffocava, e le permise di respirare. Si potrebbe dire con ragione che la risuscitò. E poi, passando al di sopra dello sbigottimento dei commensali, completò la sua opera dicendole: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!» (Lc 7,50). Ormai essa aveva riacquistato la sua dignità davanti a se stessa e davanti a tutto il mondo: era un'altra persona, con un futuro davanti a sé da vivere con gioia e con pace.
Fu questo modo di comportarsi di Gesù che gli guadagnò la fama di «amico dei pubblicani e dei peccatori» (Lc 7,34), una fama che egli non si preoccupò di dissipare, ma che viceversa continuò a fomentare con la sua condotta.
Lo Spirito per la remissione dei peccati
La scena già altre volte ricordata dell’apparizione di Gesù Risorto la sera della Pasqua, mette davanti agli occhi la donazione dello Spirito da parte sua ai discepoli collegandola con la remissione dei peccati. «Gesù disse loro: ‘Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi’. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ‘Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi» (Gv 20,21-23). In questo modo l’intera missione di Gesù stesso e dei suoi discepoli è qui pensata, come anche nel vangelo di Luca (cf Lc 24,46-49) e nel racconto della Cena nel vangelo di Matteo (Mt 26,28), in chiave di remissione dei peccati, ed è collegata alla presenza dello Spirito in loro. Non è difficile capire ciò se si pensa che, in realtà, per la Bibbia è peccato tutto ciò che produce morte, principalmente se dipende dalla libertà degli uomini. Per questo la violazione della Legge è peccato: perché la Legge è illuminazione della strada della vita, e camminare al di fuori di tale strada equivale a camminare verso la morte. Rimettere i peccati o perdonarli significa, quindi, eliminare dal cuore degli uomini, ma anche dai loro rapporti reciproci e perfino dalle strutture in cui tali rapporti si cristallizzano, quanto si oppone alla vita. Così intesa, la remissione dei peccati rimanda necessariamente allo Spirito, che è la forza vivificante e risuscitante di Dio all’opera nel mondo. Esso si è manifestato in Gesù, nella sua attività concreta, ma si manifesta anche nell’attività dei suoi discepoli.
Chiunque quindi rimetti i peccati, ossia rimuove la presenza della morte dai cuori, dai rapporti, dalle istituzioni è mosso da questo Spirito, lo sappia o no. Ed è proprio questo ciò che fa la comunità ecclesiale quando celebra il sacramento della riconciliazione: celebra la remissione dei peccati, attribuendola, come dice la stessa formula utilizzata, allo Spirito.
PER IL LAVORO PERSONALE E DI GRUPPO
Rileggi la parabola del figliol prodigo (Lc 15,11-24), oppure il racconto della peccatrice accolta e perdonata da Gesù a casa del fariseo (Lc 7,36-50), cercando di immedesimarti con il primo o con la seconda.
Pensa a come vivi il sacramento della riconciliazione: se lo frequenti, se puoi fare qualcosa perché abbia un senso più evangelico per te, se cogli in esso l’azione dello Spirito che ti strappa dalla morte per riportarti alla vita …
Preghiera
Non mi è tanto difficile, Dio e Padre mio,
riconoscermi nel figliol prodigo della parabola di Gesù,
o nella donna da lui accolta e perdonata durante il banchetto.
Non stancarti mai di aprire le braccia
(non saresti Tu!)
per accogliermi sempre di nuovo quando mi allontano da te,
magari sbattendoti la porta in faccia.
Lo Spirito con cui rifai tutte le cose,
agisca in me per sradicare dal mio cuore i miei peccati
e riportarmi sempre di nuovo alla tua casa.
Amen.
Capitolo 10
IN GESÙ DI NAZARET, LO SPIRITO È LIBERTÀ DAVANTI A TUTTO E A TUTTI
Gesù, libero perché figlio
Una delle conseguenze più vistose della presenza dello Spirito di Dio in Gesù è quella della sua sovrana libertà. Non c’è vincolo che riesca a tenerlo legato quando si tratta di raggiungere l’obiettivo centrale della sua vita, la venuta del regno di Dio, suo Padre, concretizzata nella vita più piena dei suoi fratelli e sorelle. Né le più sacre tradizioni del suo popolo, né le prescrizioni legali, né il parere delle autorità religiose o politiche, né le minacce dei suoi avversari, né il prestigio o la fama, né la stessa morte riescono a fermarlo.
Colpisce, anzitutto, l’atteggiamento di libertà che lo Spirito crea in lui verso la sua famiglia allargata. I vangeli, che d’altronde non abbondano in dati su questo punto, lo presentano in un rapporto piuttosto critico verso di essa. Conoscendo la sensibilità propria dell’epoca, segnata da una forte coesione del clan familiare, si spiegano episodi come quelli narrati in Mc 3,21; 3,31 e Mt 12,46-50, nei quali si racconta la venuta dei suoi parenti a prenderlo per riportarlo a casa sua. Tali racconti permettono di intravedere, da una parte, la preoccupazione che la sua attività fuori del comune suscitava nei suoi - arrivarono a temere che avesse perso la testa! -, e dall’altra, la sua reazione personale nei confronti della pretesa, da essi avanzata, di opporsi alla sua dedizione a ciò cui aveva deciso di dedicare tutte le sue energie. Davanti a quello che costituiva la ragion d’essere della sua vita, tutto il resto, anche gli stretti vincoli creati dalla comunità di sangue, passa in secondo piano. Egli non si sente per nulla legato da tali vincoli. C’è di più: invita anche i suoi seguaci a liberarsene (Lc 14,26).
Ma anche nei riguardi della sua famiglia più stretta, e perfino nei confronti della sua stessa madre, lo Spirito lo rende libero. Nell’episodio di Lc 2,42-50 si colgono già nell’adolescente Gesù i primi sintomi di detta libertà: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» (v.49), risponde al rimprovero dalla madre. Un atteggiamento analogo si coglie nelle parole che rivolge a quella donna che, piena di entusiasmo nell’ascoltare le sue parole, prorompe in esclamazioni e lodi verso sua madre per il fatto di averlo generato e nutrito: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!» (Lc 11,28), replica lui. Naturalmente non si può dedurre da questo testo che egli non abbia voluto bene a sua madre, il che non sarebbe certo degno di un figlio; ciò che l’evangelista vuole mettere in risalto è piuttosto il nuovo tipo di rapporti che egli privilegia: non quelli che si radicano nella carne e nel sangue, i quali sono ordinariamente i più profondi e stretti, bensì quelli che nascono dal condividere la grande speranza del regno da lui annunciato. È questo ciò che genera la libertà sua, e di quelli che lo seguono, nei confronti di qualunque altro tipo di rapporti.
Impressiona, inoltre, la libertà che lo Spirito, con cui agisce, gli permette di avere nei confronti delle leggi del suo popolo. Soprattutto di quelle riguardanti la purità rituale e il riposo sabbatico, ambedue di riconosciuta importanza e di molteplici implicazioni. Della prima egli propugna un deciso superamento perché la considera accentuatamente formale e perfino ingiusta (Mc 7,1-23). E anche se in determinate circostanze la rispetta, non la prende invece per nulla in considerazione quando è in gioco la vita delle persone. Numerosi episodi evangelici lo confermano: tocca con la sua mano un lebbroso (Mc 1,41; cf Lv 11, 45-46; 22,4-6); non fa attenzione al gesto dell’emorroissa che tocca il lembo del suo vestito (Mc 5,25-34; cf Lv 15,25-27); prende per mano una ragazza morta per ridarle la vita (Mc 5,41; cf Lv 22,4); permette ad una peccatrice pubblica di lavargli i piedi con le sue lacrime e di asciugarglieli con i suoi capelli (Lc 7,37-38); siede a mensa con i peccatori (Mc 2,15; Lc 15,1)… Uno solo di questi gesti sarebbe stato sufficiente per considerarlo un fuori legge.
Della prima legge, quella del riposo sabbatico, Gesù accoglie e fa sua l’intenzionalità profonda. Perciò la osserva fintanto che il suo adempimento non entra in conflitto con la finalità liberatrice e vivificante di cui è portatrice: «Il sabato è per l’uomo, e non l’uomo per il sabato», dichiara egli solennemente (Mc 2,27). L’episodio narrato da Marco sulla guarigione in sabato di un uomo che aveva la mano inaridita è, nella sua estrema concisione, uno dei più eloquenti da questo punto di vista (Mc 3,1-6). L’indignazione e la tristezza che egli sperimenta davanti alla durezza di cuore degli uomini della Legge sono spiegabili, soprattutto se si tiene conto del suo modo di pensare e di comportarsi al riguardo, come attestano tante narrazioni evangeliche. Egli, l’uomo della libertà, soffre per la schiavitù di coloro che lo assediano.
Un altro aspetto della sovrana libertà di Gesù è quello che riguarda il suo atteggiamento davanti al potere. A quello politico (Gv 18,33-38; Lc 13,31-32), ma soprattutto a quello religioso, che nel suo popolo era molto sentito. Con una parte della classe sacerdotale egli, che sociologicamente era un laico (Eb 7,14), sembra aver avuto un rapporto, in più di un momento, piuttosto teso. Non può passare inavvertito il ruolo negativo che le fa svolgere nella parabola del Buon Samaritano (Lc 10,30-32). Ma, soprattutto, egli assume un atteggiamento fortemente critico verso i sacerdoti che avevano in mano la gestione del Tempio. L’episodio della purificazione del medesimo, narrato dai quattro evangelisti, lo conferma chiaramente (Mt 21,12-13; Mc 11,15-17; Lc 19,45-46; Gv 2,13-16). In nessun modo egli si sente vincolato dalla loro autorità, anzi, non dubita di ribellarsi apertamente ad essa e impugnarla.
Più notabile ancora è la libertà con cui agisce nei confronti dell’autorità degli scribi. Erano essi a tenere in mano la chiave dell’interpretazione della Legge in Israele, una chiave che acquistavano dopo lunghi anni di preparazione e dopo il riconoscimento pubblico della medesima. Ciò li poneva in situazione di privilegio davanti al popolo, il quale li rispettava conferendo loro dei titoli onorifici e cedendo loro i primi posti nelle riunioni pubbliche (Mt 23,6-7). La soluzione dei problemi suscitati dall’osservanza della Legge era di loro esclusiva competenza, e la loro autorità era indiscussa. Ma Gesù non si sente legato da questa loro autorità; anzi, in più di un’occasione, contrappone il suo modo di pensare al loro. Lo si può vedere particolarmente nelle diverse prese di posizione personali espresse nel discorso della montagna. Si colgono specialmente nelle parole «avete sentito che vi fu detto… ma io vi dico…» (Mt 5,21-22.27-28.31-36.38-39.43-44). La stessa gente percepiva la libertà con cui si muoveva, riconoscendo che parlava «con autorità, e non come gli scribi» (Mt 7,28-28; Mc 1,21-22.27).
È degno di essere tenuto anche in conto, in questo contesto, l’atteggiamento che egli assume davanti al movimento di quei ribelli che si proponevano di scuotere dalle spalle del popolo santo di Dio il giogo del dominio romano. Concretamente, volevano impadronirsi del potere politico con la violenza, per restituire ad Israele la sua dignità di popolo libero e sovrano. Pur condividendo l’idea della libertà del suo popolo, che formava certamente parte della sua visione sul regno messianico, Gesù non appoggiò tale progetto. Ne è una testimonianza esplicita la narrazione di Giovanni in occasione della moltiplicazione dei pani: davanti all’attesa della gente che voleva farlo re, egli risponde con la fuga (Gv 6,15). Anche davanti al potere politico lo Spirito lo rende libero.
Così come lo rende pure libero nei confronti del prestigio. Ai giorni suoi il prestigio fondato sulla purezza del sangue, sullo status acquisito, sulle ricchezze, o sulla virtù, era un valore sommamente apprezzato. E la preoccupazione per esso rendeva schiavi molti: vivevano di esso e per esso. Gesù, al contrario, non ne tiene per niente conto: si dimostra sovranamente libero nei suoi confronti. Così, ad esempio, non ha difficoltà ad avere contatti con persone non molto raccomandabili: accoglie i peccatori, si intrattiene con loro e, come abbiamo visto, perfino siede a mensa con essi (Lc 19,2-7; 15,1-2); si mescola costantemente con le folle ignoranti e senza status (Gv 7,49) e, andando chiaramente contro corrente, ammette nel gruppo dei suoi discepoli anche delle donne (Lc 8,2-3;10,39). I suoi stessi avversari gli riconoscono questa sua libertà: «Maestro, sappiamo che… non guardi alle condizioni delle persone» (Mt 22,16).
È chiaro che l’estrema libertà di Gesù davanti a tutto e a tutti non è espressione di un libertinaggio che ricopra la sua comodità o il suo egoismo. Di fatto, ordinariamente egli rispetta le leggi e le strutture del suo popolo. La sua libertà è frutto della sua passione per il regno di Dio, che lo porta a relativizzare tutto il resto. Si vede chiaro che non le considera mai come fini, ma sempre come mezzi da utilizzare nella misura in cui contribuiscono al conseguimento del suo fine. Proprio perché si sa figlio, e non schiavo o estraneo, egli agisce sempre con piena libertà. Risulta illuminante, al riguardo, il dialogo che egli intrattiene con Simon Pietro sull’imposta da pagare al Tempio: «Che cosa ti pare, Simone? I re di questa terra da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli altri? Rispose Pietro: Dagli estranei. E Gesù: Quindi i figli sono esenti. Ma perché non si scandalizzino, va’ al mare, getta l'amo e il primo pesce che viene, prendilo, aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala a loro per me e per te» (Mt 17,25-27).
«Cristo ci ha liberato perché restassimo liberi» (Gal 5,1)
Nel vangelo di Giovanni c’è una frase carica di significato: «Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero» (Gv 8,26). Riflette una profonda convinzione che avevano i primi suoi discepoli: Gesù, l’uomo libero per eccellenza grazie alla sua figliolanza nei riguardi di Dio, era per loro fonte di libertà.
S. Paolo fu uno dei più strenui assertori di questa - «libertà dei figli di Dio» - che deve contraddistinguere coloro che vogliono seguire Gesù Cristo. Proprio perché la sua era stata una forte esperienza di liberazione dalla schiavitù della Legge (cf Fl 3,4-9), egli lottò tutta la vita appassionatamente perché coloro che si convertivano alla fede in Gesù Cristo potessero essere davvero liberi. Nelle sue lettere questo tema ritorna più di una volta con insistenza. In maniera molto sintetica enuncia il suo pensiero nella seconda lettera scritta ai Corinzi, vincolandolo espressamente allo Spirito: «Il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà» (2 Cor 3,17). Ma poi anche nella lettera ai Galati e in quella ai Romani il tema occupa uno spazio considerevole. Merita particolare attenzione la prima, nella quale, verso la fine l’Apostolo, che ha portato avanti un ragionamento serrato in favore della libertà dei suoi destinatari proprio perché lo Spirito li ha resi figli di Dio, conclude dicendo loro: «Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi!», e aggiunge ancora un’accorata esortazione: «State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù» (Gal 5,1). Sono parole che suonano come un proclama.
Facendosi eco di esse, il concilio Vaticano II dirà nel nostro secolo che condizione fondamentale del popolo messianico della Nuova Alleanza è «la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio» (Lumen Gentium 9b). Volle dire, quindi, che la chiesa di Gesù Cristo dovrebbe essere come lo spazio della vera libertà, nella quale ognuno dei suoi membri dovrebbe sentirsi a suo agio, senza costrizione di nessun tipo, vincolato solo dai lacci dell’amore fraterno. Già S. Tommaso d’Aquino, commentando le affermazioni paoline diceva che, in realtà, avendo nel cuore la legge nuova dello Spirito, che è l’amore, il cristiano non avrebbe bisogno di nessuna legge scritta. Se ne ha bisogno è soltanto perché non è ancora tanto trasparente alla presenza dello Spirito in lui.
Così come per Gesù, anche per i suoi discepoli la libertà non è quindi sinonimo di libertinaggio o di capriccio, ma è invece risultato dell’azione esigente dell’amore fraterno che lo Spirito infonde nei loro cuori. Paolo, nella stessa lettera ai Galati, fa quest’avvertenza ai suoi lettori: «Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri […]. Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne; la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne» (Gal 5,13.16-17).
PER IL LAVORO PERSONALE E DI GRUPPO
Lasciati impressionare dalla sovrana libertà che lo Spirito filiale suscita in Gesù, rileggendo alcuni racconti del vangelo come quelli riportati in Mc 3,21; 3,31 e Mt 12,46-50.
Rifletti sulle tue tante schiavitù: alle cose che possiedi, alla tua immagine, ai tuoi capricci, ai desideri che s’impadroniscono del tuo cuore, alla moda, al parere degli altri…
Preghiera
Ho bisogno del tuo Spirito, Gesù!
Solo se tu me lo doni
io potrò aprirmi una strada verso la libertà.
Troppe cose mi dominano
e mi rendono schiavo.
Vorrei che si avverasse in me la parola di Paolo:
«Cristo ci ha liberato perché restassimo liberi».
Ripeti in me questo prodigio:
spezza i vincoli che mi incatenano
e rendimi come te, libero da tutti e da tutto, nell’amore. Amen.
Capitolo 11
LO SPIRITO È LA POTENZA DIVINA CON CUI IL PADRE RISUSCITA GESÙ
Due tappe nell’esistenza di Gesù
Nel saluto iniziale della lettera ai cristiani di Roma, Paolo fa un riferimento a Gesù Cristo, del quale si dichiara servo e apostolo, affermando che egli è «nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, [e fu] costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti» (Rm 1,3-4). Mediante tali parole esprime a modo suo una profonda convinzione dei primi credenti: se Gesù, dopo aver sofferto la morte ignominiosa sulla croce, è ora vivo nella gloria, è perché Dio ha voluto strapparlo dal potere della morte mediante la forza vivificante dello Spirito al momento della risurrezione.
Come si coglie nei diversi scritti del Nuovo Testamento, la risurrezione fu un avvenimento denso di significato, le cui implicazioni si allargarono a modo di cerchi concentrici in forma incontenibile. Esso interessò anzitutto Gesù in persona, ma poi anche la comunità dei suoi discepoli e, attraverso loro, l’intera umanità e perfino la storia umana e il cosmo nella loro integralità. Tutte queste istanze ebbero a vedere con l’azione dello Spirito. Qui c’interessano le due prime, e cioè quelle riguardanti la persona di Gesù di Nazaret e la comunità dei credenti in lui. Delle altre ne parleremo in seguito.
Anzitutto, quindi, l’avvenimento pasquale fa riferimento a Gesù stesso. Egli, come ricordava Paolo nel saluto ai Romani, visse una prima tappa «secondo la carne». È quella anteriore alla Pasqua. Gesù la visse all’insegna della debolezza, perché era marcato, come ogni altro essere umano, dalla condizione concreta in cui si svolge l’esistenza umana in questo mondo: limiti, difficoltà, tentazioni, malattie e, soprattutto, morte. È questo ciò che intende dire Paolo affermando che visse «secondo la carne».
Nella lettera ai Filippesi lo stesso Apostolo afferma che Gesù, «pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, svuotò se stesso…» (Fl 2,6-8). E nella lettera agli Ebrei si dice di lui che si fece «in tutto simile ai fratelli» (Eb 2,17), e che fu «provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato» (Eb 4,15). Basta leggere senza pregiudizi i vangeli per avere una chiara conferma di tutto ciò. Essi, per fortuna, non fanno di Gesù un superuomo, ma lo dipingono nella sua vera umanità, senza nascondere nulla. Neppure i momenti terribili di angoscia passati in prossimità della morte prevedibile (Mt 26,37; Mc 14,33; Lc 22,44).
Gesù però visse questa tappa in maniera intensamente filiale, perché lo Spirito di Dio era in lui e lo muoveva costantemente in tale direzione. Era figlio di Dio, senz’altro, ma ancora in qualche modo lontano dal Padre (Gv 16,28). Si potrebbe dire che era figlio in fase di apprendistato del suo rapporto filiale con il Padre, secondo quello che, con un linguaggio alquanto audace, dice l’autore della lettera agli Ebrei (Eb 5,8). Eppure, già allora, come abbiamo rilevato in più di un’occasione, la forza vivificante dello Spirito di cui era portatore, si sprigionava da lui verso gli altri diffondendo vita attorno a sé (Mc 5,30; Lc 6,19). Egli era già allora, nonostante i limiti cui andava soggetto, una sorgente di risurrezione perché per mezzo suo Dio strappava dalla paralisi gli storpi, dall’oscurità i ciechi, dall’esclusione i lebbrosi, dall’emarginazione i peccatori, dalla discriminazione le donne, dalla bara il figlio della vedova di Nain…
Ma, secondo la grande e gioiosa professione di fede che riempie tutte le pagine del Nuovo Testamento, mediante la risurrezione Gesù di Nazaret fu costituito «Figlio di Dio con potenza» (Rm 1,4). Iniziò cioè l’altra tappa della sua esistenza, quella definitiva. E il passaggio ad essa fu opera del Padre, per mezzo della potenza vivificante dello Spirito. Dice Paolo nella stessa lettera ai Romani: «Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi» (Rm 8,11). L’abbiamo rilevato precedentemente: attraverso tutta la storia di Dio con gli uomini, particolarmente quella in cui accompagnò il popolo d’Israele, lo Spirito era stato sperimentato come la potenza divina che faceva passare dal caos al cosmo (Gn 1,2), dal non-essere-popolo all’esserlo (Es 14,21), dalla nuova schiavitù alla libertà (Gdc passim), dalla morte alla vita (Ez 37,4-10); ora, nella culminazione pasquale della storia, lo Spirito è percepito come colui per mezzo del quale Dio strappa dal sepolcro Gesù, e lo fa entrare nella pienezza della vita (cf At 2,24.32; 3,15.26; 4,10; 5,30; 10,40; 13,30.33.34.37; 17,31; ecc.). Grazie alla sua azione Gesù diventa «il Vivente», colui che è «vivo per sempre e ha potere sopra la morte e sopra gli inferi» (Ap 1,18), e con il quale «la morte non ha più niente a che fare» (Rm 6,9). Ancora di più: egli diventa «Spirito datore di vita» (1 Cor 15,45), come attesta il vangelo di Giovanni nella scena della stessa sera del giorno di Pasqua (Gv 20,19.23).
Mediante lo Spirito, continua la risurrezione
Ciò che il Padre fece in Gesù di Nazaret mediante la sua Potenza vivificante, continua a farlo anche in coloro che credono in lui: Egli li risuscita dalla morte. Parliamo, naturalmente, di risurrezione come trionfo della vita sulla morte in due sensi complementari: uno, secondo cui tale trionfo è ancora parziale e provvisorio, e un altro secondo cui esso è pieno e definitivo.
La morte, come negazione della vita, è una realtà largamente presente nel mondo. E si manifesta in svariatissime forme. Da quella più estrema, e cioè la fine dell’esistenza in questo mondo, a quelle meno estreme ma non meno reali quali sono la privazione del necessario per vivere con dignità, la mancanza di rapporti vivificanti con gli altri, l’emarginazione sociale, politica, culturale o religiosa, la perdita del senso della vita, la rottura del rapporto di comunione con Dio, e tante altre. Gesù ci fece sapere che Dio, essendo «amante della vita» (Sap 11,26), è nemico della morte, e quindi della sofferenza, dell’esclusione, dell’umiliazione. Perciò egli si diede tanto da fare per combatterle e farle scomparire dai corpi, dai cuori, dagli atteggiamenti, dai rapporti tra le persone e i gruppi, dalle strutture in cui tali rapporti si cristallizzavano. Egli, infatti, trovò la ragione d’essere della sua attività in uno scopo molto realistico: che gli uomini e le donne «avessero la vita, e l’avessero in abbondanza» (Gv 10,10).
Ciò che Dio faceva allora mediante Gesù e la potenza vivificante dello Spirito che lo riempiva, continua a farlo oggi. Egli continua cioè a risuscitare i morti anzitutto rendendo possibile una nuova forma di vita. Nuova forma che si modella sugli orientamenti di Gesù e supera le forme contrarie alla sua proposta. Concretamente, che elimina quelle che Paolo chiama le «opere della corpo» (Rm 8,13), nel senso negativo del termine, perché fanno parte della vita «nella carne», la quale produce «i frutti della morte» (Rm 7,5; 8,6). Dove, per capirne bene il senso, «carne» si dovrebbe tradurre per «egoismo», ossia per ripiegamento su se stessi e ricerca dei propri interessi con il conseguente disinteresse nei confronti dei bisogni altrui.
Lo Spirito, che è l’amore di Dio riversato nei cuori (Rm 5,5), spinge nella direzione opposta all’egoismo. Ne è una chiara conferma la narrazione del libro degli Atti degli Apostoli nel quale, dopo aver raccontato la venuta dello Spirito sui primi discepoli radunati a Gerusalemme insieme a Maria, la madre di Gesù (At 2,1-13), l’Autore descrive a grandi tratti la nuova vita scaturita da quella venuta: «Erano un cuor solo e un’anima sola, e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune» (At 4,32). Comunione delle persone, anzitutto, ma anche, e di conseguenza, comunione delle cose per il superamento di ogni forma di privazione, sinonimo di morte.
Ma Dio continua a risuscitare i morti anche attraverso l’azione di tutti quelli che, consciamente o no, cercano di debellare la morte nelle mille forme in cui essa si rende presente nel mondo. Lo fa certo attraverso l’azione dei discepoli di Gesù, i quali sanno che chi li muove è in realtà il suo stesso Spirito, ma la fa anche attraverso coloro che non lo sanno. Anche nei cuori di quest’ultimi, infatti, agisce lo Spirito producendo in essi quell’amore agli altri che è la grande novità da lui introdotta nel mondo (cf GS 22d-e).
Queste risurrezioni parziali e provvisorie preparano la grande e definitiva vittoria finale sulla morte, quella preannunciata tra gli altri dall’ultimo libro del Nuovo Testamento, l’Apocalisse, il quale descrivendo la fine della storia profetizza: «Non ci sarà più la morte» (Ap 21,4). Come abbiamo ricordato sopra, nella lettera ai Romani Paolo scrive: «Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi» (Rm 8,11). Egli pensa all’esito definitivo dell’esistenza, e lo pensa come la vittoria piena e definitiva in ognuno e in tutti della vita sulla morte: Dio realizzerà in essi, mediante la potenza del suo Spirito, ciò che fece in Gesù nella Pasqua. Allora Egli, il Dio della Vita, sarà davvero «tutto in tutti» (1 Cor 11,28), perché tutti saranno, come Lui, pienamente viventi.
PER IL LAVORO PERSONALE E DI GRUPPO
Seguendo il cammino di fede del popolo dell’Antico Testamento, i vangeli pensano allo Spirito Santo come la Forza divina che genera la vita e che, di conseguenza, sconfigge la morte. In Gesù principalmente, con la risurrezione, ma anche negli altri e perfino nel cosmo. Anche tu sei bisognoso di risurrezione. Ci sono molte cose morte dentro di te che invocano lo Spirito perché dia loro la vita. Cerca di identificarle, e poi invoca su di esse la venuta dello Spirito, come fece il profeta Ezechiele (Ez 37,9-10).
Preghiera
O Dio,
con la Potenza vivificante dello Spirito
hai strappato Gesù dalla morte
e l’hai portato alla pienezza della vita.
Ora egli è «Spirito vivificante».
Opera anche in me il prodigio della risurrezione;
vivifica in me ciò che è morto,
riempimi di vita nuova,
e fa' di me uno strumento della tua azione risuscitante.
Amen!
Capitolo 12
MEDIANTE LO SPIRITO. GESÙ RISORTO PORTA A COMPIMENTO LA STORIA
In un bel salmo dell’Antico Testamento si dice che, mediante il suo spirito, Dio «rinnova la faccia della terra» (Sal 104,30). Nella tradizione ecclesiale questo spirito è stato identificato con lo Spirito Santo, al quale viene attribuito il rinnovamento della terra nella preghiera in cui si chiede a Dio il suo invio. Per «terra» s’intende qui l’intera creazione chiamata all’esistenza dall’amore di Dio. La frase del salmo sembrerebbe anticipare in maniera estremamente condensata ciò che fece Gesù di Nazaret durante la sua attività in ordine al regno di Dio, e ciò che poi Dio fece in lui stesso nella Pasqua.
L’agire di Gesù in ordine ad una «terra rinnovata»
Anzitutto, durante la sua attività per il regno, Gesù, guidato e sostenuto costantemente dallo Spirito che lo sospingeva dal di dentro, lavorò con passione per «rinnovare la faccia della terra», ossia per restituire la creazione alla bellezza e alla dignità che le spettano secondo il disegno di Dio (Gn 1,4.10.12.18.21.25.31). Soprattutto quella porzione della creazione che, stando alle prime pagine della Bibbia, ne è il centro e il culmine: l’essere umano. Lo trovò spesso deturpato, con il volto abbattuto e avvilito, come Adamo ed Eva dopo aver mangiato la frutta (Gn 3,8-19), o come Caino dopo la sua terribile azione fratricida (Gn 4,6). Quell’essere umano chiamato ad essere immagine e somiglianza del Dio Vivente (Gn 1,27-28), gli appariva davanti più di una volta come un rudere, vittima di una deplorevole devastazione. E con lui, anche la natura. S. Paolo afferma che essa è «sottoposta alla vanità» (Rm 8,20), il che secondo la Bibbia significa che non raggiunge lo scopo per il quale è chiamata all’esistenza.
Gesù trovò più di una volta uomini e donne in queste condizioni sulla sua strada. E rinnovò davvero la loro faccia, cambiando radicalmente la loro situazione miserevole. Bastano pochi casi emblematici per illustrarlo. Uno è quello, già anteriormente ricordato, del suo commovente incontro con il lebbroso che gli chiese fiduciosamente di guarirlo (Mc 1,40). Si trattava di un essere umano profondamente deturpato nel suo aspetto corporale, ma anche in quello sociale, dal momento che doveva isolarsi allontanandosi dal rapporto con gli altri, perfino con i più cari, e soprattutto dal punto di vista religioso, poiché veniva considerato oggetto di un castigo divino. La reazione che lo Spirito suscitò in Gesù fu quella di una profonda commozione - «toccato nelle sue viscere», dice il vangelo - e, allo stesso tempo, di un’efficace volontà di trasformazione: «Stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, guarisci!». E l’inaudito avvenne: l’uomo fu restituito alla sua integrità corporale: «Subito la lebbra scomparve ed egli guarì» (Mc 1,42). Di conseguenza, fu anche in qualche modo risanato in tutti gli altri aspetti della sua vita che erano coinvolti dalla sua terribile situazione. Davvero, in questo caso, attraverso l’intervento di Gesù «fu rinnovata la faccia della terra».
Un altro caso è quello dell’uomo posseduto da una legione di «spiriti immondi», con il quale Gesù s’imbatté nella zona dei Geraseni (Mc 5,1-17). C’erano dentro a quell’infelice delle forze tremende, totalmente incontrollate, che lo riducevano in uno stato di autentica pazzia. La descrizione che ne fa il vangelo di Marco è realmente patetica: abitava tra le tombe, cioè nel regno della morte e di conseguenza nella massima impurità rituale, si feriva costantemente percuotendosi con pietre, e nessuno riusciva a domarlo perché egli rendeva inefficace ogni tentativo di ricuperarlo alla serena convivenza con gli altri. Un uomo, quindi, in uno stato palesemente rovinoso, in cui la dignità umana si trovava estremamente ferita e menomata. Anche davanti a lui Gesù reagì e, con la serena maestà della sua parola, riuscì a restituirgli la dignità, liberandolo da quelle forze nocive che si portava dentro: così lo incorporò nella normale convivenza con gli altri. Il racconto si chiude, infatti, con la descrizione della nuova situazione provocata dal suo intervento: «[I mandriani] giunti che furono da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione» (Mc 5,15). Gesù stesso, secondo le testimonianze evangeliche, attribuì questo e altri simili suoi interventi alla forza dello Spirito presente in lui: «Se io scaccio i demòni con il dito di Dio, è dunque giunto a voi il regno di Dio». Il «dito di Dio» era una metafora utilizzata ai suoi tempi per riferirsi allo Spirito Santo.
Ancora un caso, scelto tra tanti, illustra quest’impegno di Gesù per rinnovare l’umanità devastata e portarla ad una condizione degna della sua vocazione: è quello di Zaccheo (Lc 19,1-10). Apparentemente egli stava bene. Era ricco, anzi, molto ricco, poiché, essendo capo dei pubblicani, aveva approfittato il suo mestiere per ricavare grossi proventi, non sempre leciti come si desume dalla narrazione evangelica. Possedeva una bella casa e, molto probabilmente, una famiglia gratificante. Ma il suo cuore era guasto. Egli infatti aveva frodato la gente per soddisfare i suoi interessi. Probabilmente aveva sfruttato i poveri, poiché erano i più indifesi, data la loro ignoranza delle esigenze della Legge anche in materia di tasse. Due ordini di rapporti erano manifestamente sconvolti in lui, quello con il denaro, che egli aveva trasformato in un idolo al quale soggiaceva servilmente (Mt 6,24), e quello con gli altri uomini, soprattutto con i poveri, che aveva convertito in oggetto di sfruttamento. Di conseguenza, anche il suo rapporto con Dio restava stravolto, dal momento che non faceva ciò che Egli richiedeva. L’incontro con Gesù lo trasformò radicalmente. Infatti, alla fine del pranzo, dopo aver dialogato con il suo gradito ospite, egli, alzatosi in piedi, disse con grande determinazione: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto» (Lc 19,8). D’un colpo tutti i suoi rapporti fondamentali si trasformarono: con i poveri, con il denaro, con Dio stesso. Si spiega così che Gesù abbia detto, dando pubblica conferma all’avvenuto: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa» (Lc 19,9). Ancora una volta egli aveva «cambiato la faccia della terra», trasformando il cuore di un uomo e restituendolo all’autenticità della sua dignità umana.
In Gesù risorto, «i cieli nuovi e la terra nuova»
Anche Gesù fu, in certo senso, una «terra sfigurata», perché anche lui partecipò della condizione umana, essendo divenuto «in tutto simile ai fratelli, escluso il peccato» (Eb 2,17; 4,15). Nel quarto Canto del Servo del libro d’Isaia, che i discepoli videro realizzato in lui soprattutto nel momento della sua passione, il futuro Servo di Dio veniva descritto in questi termini: «Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui diletto. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima» (Is 53,2-3). Fu precisamente ciò che avvenne alla fine della sua vicenda, quando fu imprigionato, processato, flagellato, condannato a morte e sottoposto al più ignominioso dei supplizi, la croce (Mt 27,27-50 e par.).
Ma il Padre, mediante lo Spirito, intervenne con la sua potenza vivificante per rinnovarlo radicalmente. Veramente in lui «si rinnovò la faccia della terra». Egli venne invaso dalla vita in pienezza, e ogni limite scomparve. La presenza dello Spirito lo rese davvero nuovo. Egli, come dice Paolo, divenne «l’uomo della fine» (1 Cor 15,45), ossia l’uomo pienamente realizzato secondo il progetto di Dio, il compimento di quello che avevano tratteggiato le prime pagine della Bibbia narrando in maniera altamente poetica la creazione dell’uomo (Gn 1,26-27; 2,7.18-23), e cioè un essere in totale comunione con Dio e con gli altri, e in perfetta armonia con la natura. Gesù risorto è interamente nuovo perché è figlio in pienezza di Dio (Rm 1,4), fratello in pienezza degli uomini (Gv 15,13), signore in pienezza del creato (Col 1,17). E con lui lo Spirito rese germinalmente nuova l’intera umanità e la creazione tutta. Nella sua persona ormai glorificata, sono arrivati «i cieli nuovi e la terra nuova» di cui parlano i testi del Nuovo Testamento (2 Pt 3,13; Ap 21,1).
L’annuncio di una grande vittoria dello Spirito
Eppure, l’esperienza attesta palesemente che la terra continua a dare segni di una grande degradazione: gli esseri umani, anzitutto, ma anche la natura che li attornia e in mezzo alla quale essi vivono. Esistono ancora nel mondo delle condizioni di vita estremamente negative a livello collettivo e a livello individuale: guerre fratricide, ingiustizie e sopraffazioni, emarginazioni antiche e nuove nel nome della razza, della religione, dell’ideologia, del sesso, fame di milioni di persone, prevaricazioni sui più deboli, violenze di tutti i tipi, malattie corporali e psichiche, senso diffuso di solitudine e di perdita del senso della vita, falsi modi di rapportarsi con Dio, contaminazione dell’aria e dell’acqua, devastazione delle foreste… Sembrerebbe regnare più la morte che la vita in questa terra fatta dall’amore di Dio per gli uomini. Come diceva già ai suoi tempi S. Paolo, «la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto», e «attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio; essa infatti è stata sottomessa alla caducità non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,19.22). Lo stesso Apostolo afferma che è lo Spirito, posseduto come primizia, che mantiene vivo il desiderio della liberazione dell’uomo e dell’intera creazione dalla caducità e dalla disperazione.
Il concilio Vaticano II ha ripreso questa linea di riflessione e l’ha portata avanti con grande coerenza. Esso affermò, nella costituzione Gaudium et Spes, che lo Spirito è attivamente presente nell’evoluzione della storia umana (n. 26). Ancora di più, concludendo il capitolo dedicato all’attività umana nel mondo, aggiunse che Gesù Cristo, costituito Signore mediante la risurrezione, opera nel cuore degli uomini con la potenza del suo Spirito, non solo suscitando il desiderio del mondo futuro, ma anche ispirando, purificando e fortificando quei generosi sforzi con cui la famiglia umana cerca di render più umana la propria vita e di ordinare a questo fine tutta la terra (GS 38a). Come a dire che tutto ciò che viene fatto dagli uomini, siano essi credenti o no, in ordine a fare più umana l’umanità, ha la sua fonte ultima nello Spirito. O ancora, che lo Spirito Santo che promana dal Cristo risorto verso gli uomini è la forza umanizzante della storia; è la fonte che nutre, purifica e rafforza ogni sforzo fatto in quella direzione; è Colui che, quale potenza divina, aiuta gli esseri umani a diventare umani, sempre più veramente umani.
L’ultimo libro del Nuovo Testamento, l’Apocalisse, è un grande grido di speranza in mezzo alle difficoltà laceranti di cui è piena la storia: nonostante tutto e al di là di quel che può apparire agli occhi umani, Dio è all’opera nel mondo, e per mezzo di Gesù risorto, l’Agnello immolato che ha nelle sue mani il senso della storia (Ap 5,7), e per mezzo dello Spirito che con la Sposa invoca la venuta dello Sposo (Ap 22,17), la porta irresistibilmente verso la sua pienezza. Alla fine dei tempi Egli avrà interamente «rinnovato la faccia della terra», poiché allora, adempiendo le antiche profezie, «non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate». Colui che siede sul trono dirà allora: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,4-5).
PER IL LAVORO PERSONALE E DI GRUPPO
Ripassa nella tua mente gli aspetti della «terra» che hanno bisogno di trasformazione: della terra che sei tu stesso nella tua corporalità, nella tua psiche, nei tuoi rapporti con gli altri, con Dio, con le cose, con te stesso; della terra che è l’umanità nella sua convivenza collettiva, nel suo rapporto con la natura…
Pensa a quanto bisogno c’è d’invocare lo Spirito affinché «rinnovi la faccia della terra».
Preghiera
«Manda il tuo Spirito e tutto sarà creato,
e rinnoverai la faccia della terra».
O Dio, amico della vita,
creatore del mondo e dell’umanità,
riversa il tuo Spirito nel cuore di ogni essere umano,
perché tutto ciò che è malato venga guarito,
tutto ciò che storto venga raddrizzato,
tutto ciò che è vecchio venga rinnovato,
tutto ciò che è inquinato venga mondato,
tutto ciò che è morto venga vivificato.
Amen!
Capitolo 13
IN DIO, LO SPIRITO È DA SEMPRE IL PRINCIPIO DIVINO DELLA SOLIDARIETÀ APERTA
Un cammino verso la profondità ultima della storia
Finora abbiamo percorso il cammino che da Gesù di Nazaret porta alla scoperta dello suo Spirito, che è anche quello di Dio, il Padre (1 Cor 2,11-14.16; 6,11; Rom 3,16; Fil 3,3; ecc.). L’abbiamo colto nei suoi modi di essere e di operare, negli atteggiamenti più intimi da lui manifestati durante la sua attività appassionata per il regno di Dio, e nei suoi interventi verso gli altri attraverso questa sua attività. Lo Spirito ci è apparso poi come la Potenza con cui Dio l’ha strappato della morte nella risurrezione e mediante la quale egli stesso, una volta risuscitato, porta avanti insieme al Padre la storia umana fino al suo compimento.
Scandagliando in profondità tale manifestazione storica dello Spirito, la fede cristiana è arrivata a intravedere, nella misura in cui ciò è possibile, la sua identità da sempre. È stata proprio la professione di fede nello Spirito come «Signore che dà la vita» e come Colui che, «insieme con il Padre e con il Figlio è adorato e glorificato», come dice il Credo niceno-costantinopolitano che viene recitato nella celebrazione dell’Eucaristia, ciò che ha conferito al cristianesimo la sua impronta trinitaria definitiva, per la quale si distingue da ogni altra fede. Anche da quella nel cui seno è nata, la fede ebraica. Tale professione è venuta alla luce nei primi secoli, facendo propria una formulazione dogmatica elaborata dietro la spinta delle eresie, e arrivando ad acquistare rango di simbolo della fede. Così, lo Spirito cominciò ad essere confessato esplicitamente dai cristiani come «la Terza Persona della Trinità», da sempre uguale al Padre e al Figlio pur avendo una sua propria originalità nei loro confronti
.
Quale identità per la «Terza Persona»?
Si sono dette molte cose sull’identità propria dello Spirito in seno al Mistero ineffabile della Trinità. Forse una delle più belle è quella che l’ha identificato come l’Amore personale tra l’Eterno Amante, il Padre, e l’Eterno Amato, il Figlio. Oppure quell’altra che l’ha pensato come il vincolo di comunione che unisce tutti e due, il Padre e il Figlio, sin dall’eternità, in un’unità senza limiti.
Queste maniere di pensare la sua «personalità» hanno nutrito la fede e la devozione di tanti cristiani e cristiane attraverso i secoli, fomentando in essi stupende avventure mistiche. Anche nel nostro secolo una giovane carmelitana vissuta per pochi anni in un convento, la Beata Elisabetta della Trinità, scrisse delle cose ammirevoli in questo senso. Ma prima di lei fecero altrettanto S. Giovanni della Croce, S. Bernardo, e molti altri che trovarono in detto modo di vedere lo Spirito nell’eterna intimità di Dio una fonte inesauribile di ispirazione e di vita.
Oggi ci sono dei nuovi tentativi in questo ambito, i quali, pur non rifiutando i precedenti, si aprono a prospettive nuove. Uno di essi sembra essere molto carico di conseguenze in tutti gli aspetti e dimensioni della vita umana. È quello che vede nello Spirito colui che, nell’intimità divina, spezza il cerchio della solidarietà chiusa e sollecita perciò a superare tale logica nei rapporti umani. Ci spieghiamo brevemente.
Parlare del dogma trinitario equivale a produrre in molti, credenti o non, l’impressione di far riferimento a qualcosa di estremamente astratto e lontano. Diceva già Kant al suo tempo che dal dogma trinitario non se ne può ricavare niente di pratico. Eppure, nonostante la sua apparente astrusità, questo dogma, secondo il quale il Dio che si è rivelato definitivamente attraverso Gesù Cristo è da sempre e immutabilmente uno nella diversità e diverso nell'unità, se viene preso, secondo la proposta del teologo ortodosso P. Evdokimov, come «immagine conduttrice», ossia come guida ispiratrice per la costruzione di una convivenza vivificante tra gli esseri umani, può diventare qualcosa di sommamente fecondo.
Anzitutto, perché il dogma, parlando dell’eterna unità del Padre, del Figlio e dello Spirito nella totale condivisione della Vita, parla del superamento della logica dell’accaparramento che genera esclusione e quindi morte; e parlando dell’eterna diversità del Padre, del Figlio e dello Spirito tra di loro all’interno dell’unità parla del superamento della logica dell’omologazione che sopprime l’alterità dell’altro e quindi lo elimina in quanto tale negando la sua originalità.
Ma poi, e più specificamente, perché il dogma trinitario dice anche che questa unità e questa diversità si verificano concretamente fra tre: il Padre, il Figlio e lo Spirito. Già l’affermazione dell’esistenza eterna dell’alterità in Dio rompe, nell’intimità divina, il cerchio chiuso della ripetizione dell’identico e lascia spazio all’originalità dell’altro in quanto altro; ma l’affermazione dell’esistenza di tre, nel seno dell’infinita pienezza di Vita che è Dio, e non di solo due, offre un ulteriore spunto d’ispirazione per una convivenza umana positiva, ad ogni livello. Lo Spirito, infatti, che è il Terzo divino, infrange la chiusura della solidarietà tra il Padre e il Figlio, e la rende aperta. Egli è da sempre il superamento della logica della solidarietà chiusa.
Ora, l’esperienza dimostra che nel nostro mondo esistono degli stili di convivenza che sono organizzati all’insegna di tale logica. Essi generano morte. Ci sono infatti dei gruppi, piccoli o grandi, che condividono al loro interno ciò che hanno e alle volte perfino ciò che sono, ma poi si chiudono nel loro cerchio bloccando la circolazione dei beni al di là delle frontiere che li separano dagli altri. Succede effettivamente più di una volta che, nell’ambito familiare, marito e moglie vivono un intenso rapporto coniugale reciproco, rispettando anche la identità l’uno dell’altro, ma poi non vogliono aprirsi alla possibilità di un terzo o di terzi - i figli - che condividano la loro felicità; oppure succede che un’intera famiglia vive al suo interno una dinamica e arricchente situazione di condivisione di affetto e di beni materiali e culturali e di rispetto vicendevole, ma poi non si apre verso i bisogni degli altri non appartenenti al loro ambito familiare. Ci sono pure delle associazioni o dei gruppi a carattere culturale, sociale, economico e perfino i cui membri condividono largamente alcuni beni che costituiscono il loro patrimonio comune, ma che non sono disposti ad aprirsi ad altri che non ne sono membri. Essi custodiscono gelosamente ciò che è loro, e magari sviluppano al loro interno degli atteggiamenti fortemente altruisti e solidali, ma tutto finisce nel cerchio limitato della loro appartenenza.
L’intera umanità è oggi fortemente segnata nella sua globalità da una tale logica, se si tiene presente la breccia esistente tra una piccola parte dell’umanità sempre più ricca e benestante, e un’altra larga parte sempre più povera e indigente. Coloro che stanno bene tendono a creare una forte solidarietà tra di loro e ad appoggiarsi e difendersi a vicenda, ma lasciano gli altri ad aspettare invano, come il povero Lazzaro della parabola, «le briciole che cadono dalla loro mensa» (Lc 16,21). È facile constatare che si tratta di situazioni concrete le quali incidono intensamente sulla vita e sulla morte di milioni di esseri umani.
In rapporto a questa variegata realtà, la fede nello Spirito come il Terzo divino che spezza la logica della solidarietà chiusa, diventa una formidabile spinta all’impegno nella trasformazione della convivenza umana. Così si vede che veramente lo Spirito opera nel mondo ciò che gli è proprio nell’intimità della Vita divina: mediante l’agire degli uomini che si lasciano muovere dal suo impulso, come Gesù, va aprendo la solidarietà fino a includere in essa tutti ed ognuno, senza eccezione di sorta; va smontando cioè ad ogni livello le barriere che l’egoismo e la solidarietà chiusa, individuali e collettivi, creano nel mondo, facendo possibile in questo modo il trionfo della vita sulla morte. Egli è davvero «Signore che dà la vita».
PER IL LAVORO PERSONALE E DI GRUPPO
Guardati attorno e vedi quante forme di solidarietà chiusa esistono nel mondo. In quello piccolo dell’amicizia, del gruppo, della famiglia, del lavoro, e in quello grande della società nazionale e planetaria.
Fermati un momento a pensare al mistero ineffabile di Dio. Della sua eterna vita intima intravvediamo solo quello che Egli stesso ha voluto svelarci. E lo possiamo esprimere solo balbettando, perché sappiamo che non c’è parola umana che possa ingabbiarlo. In questo senso noi diciamo, nella fede, che Egli è un Dio uno e trino.
Pensa alla potenziale fecondità pratica che ha la rivelazione della presenza del Terzo Divino, lo Spirito, nel grembo eterno della Vita, che è solidarietà senza limiti. La Sua presenza la rende aperta e non ripiegata su se stessa. Inspirandoci a questo modello possiamo anche noi costruire una solidarietà umana aperta all’altro, al «terzo», in tutti i livelli della nostra esistenza. Sarà davvero una solidarietà vivificante!
Preghiera
Sei un Mistero insondabile, o Dio!
Mi sento così piccolo davanti a Te!
Ho capito però che, nella tua eterna Intimità,
lo Spirito è fonte di apertura senza limiti.
Dammi il tuo Spirito.
Per mezzo di Gesù,
che visse sempre mosso da Lui,
in un atteggiamento di inesauribile donazione,
arrivi anche al mio cuore il suo fuoco divorante.
Stabilisca in me la sua dimora,
e mi sospinga costantemente dal di dentro
verso una solidarietà aperta a tutti.
Amen.




















































