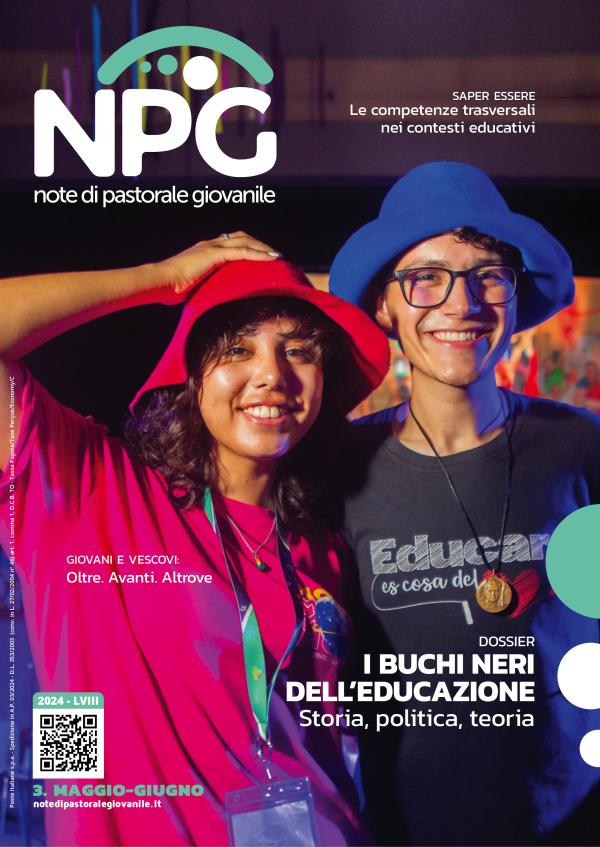Oggioratorio /5
Principi e prassi di impegno educativo
Vito Campanelli [1]
(NPG 2011-07-52)
Negli orientamenti pastorali della CEI per il decennio dedicato all’educazione, troviamo una parola autorevole sull’Oratorio definito come «espressione tipica dell’impegno educativo di tante parrocchie». Esso, «adattandosi ai diversi contesti, esprime il volto e la passione educativa della comunità».[2] In tal modo, si mette in evidenza la titolarità ecclesiale dell’esperienza oratoriana attribuibile alla parrocchia la quale, nello stesso documento, è riconosciuta come: «La comunità educante più completa… che… vive tra le case degli uomini… e… rappresenta nel territorio il riferimento immediato per l’educazione e la vita cristiana ad un livello accessibile a tutti».[3]
Come esperienza maturata all’interno del contesto ecclesiale italiano, quella oratoriana è, quindi, connotata dall’adattabilità, caratteristica che mette in luce la duttilità con cui lo stesso seme, lo stesso messaggio evangelico, possa prendere forme diverse anche in relazione allo stesso territorio e alla stessa cultura locale. Questo è il motivo per cui l’Oratorio «si declina al plurale… la cui esperienza non è accomunabile a uno standard e il modello è costituito da un insieme difficilmente cristallizzabile».[4] Consapevoli, quindi, che la tradizione abbia sviluppato, con i suoi molteplici adattamenti, «distinti modelli» di Oratorio, dobbiamo però anche ammettere che esiste «un minimo comune multiplo come denominatore della realtà Oratorio sotto il quale non si condivide tale esperienza».[5]
Educare alla cittadinanza è senz’altro uno di questi denominatori che ritroviamo attestato sia nella tradizione storica che nella realtà odierna. San Filippo Neri e San Giovanni Bosco, solo per citare due nomi di incontestabile autorità, sono stati cittadini esemplari e anche un po’ speciali: il primo acclamato e riconosciuto come «l’Apostolo della città di Roma», il secondo ricordato per il suo sistema educativo preventivo, riassumibile nella famosa affermazione: «Fare quel po’ di bene che posso ai giovanetti abbandonati adoperandomi con tutte le forze affinché diventino buoni cristiani in faccia alla religione, onesti cittadini in mezzo alla civile società».[6]
Ma cosa intendiamo per cittadinanza? Nel rispondere alla domanda, affrontiamo con consapevolezza gli innegabili risvolti e «suggestioni in prospettiva educativa e pedagogica»[7] contenuti nel tema. Il termine cittadinanza viene solitamente utilizzato per indicare sia uno «status giuridico» che un «ruolo sociale», ed esprime il tipo di relazione esistente tra un individuo e uno Stato, ma anche i diritti e i doveri che tale relazione comporta. Oggi tale concetto è in continua evoluzione e va ampliandosi sia in ambito giuridico che sociale,[8] specialmente dopo i tre grandi eventi che hanno irreversibilmente trasformato la geografia planetaria (fine della guerra fredda, unificazione europea, flussi migratori). Condividiamo, quindi, la seguente affermazione: «In questo preciso momento storico, il concetto di cittadinanza può diventare un nuovo perno educativo. Educarci per diventare ciò che siamo si può riassumere nell’esercizio dei valori della cittadinanza: essere un buon cittadino o cittadina esprime fedelmente ciò che ci fa umani».[9] L’Oratorio questo l’ha sempre fatto. Oggi, piuttosto, la novità sta nel fatto che il concetto è da intendere in termini sempre più cosmopoliti. La sfida è, quindi, quella di giungere a pensarsi «a pieno titolo e con tutte le sue conseguenze, cittadini del mondo».[10]
Nell’esaminare il tema «Oratorio e cittadinanza», dobbiamo però seguire un percorso illustrativo a ritroso rispetto a quella che è stata l’esperienza italiana, perché se da un lato la prassi ha ispirato i principi, dall’altra sappiamo che per capire meglio la prassi è necessario partire dai principi. L’interpretazione dell’esperienza oratoriana secondo il metodo ermeneutico della teologia pastorale o pratica [11] ci fornirà, quindi, i «criteri» o «nodi teologici» che sottostanno a quella che possiamo ben definire «cultura oratoriana della cittadinanza». Saranno tali criteri a farci meglio comprendere quale sia, in merito al tema, la prassi oratoriana, osservata da tre angolature: le finalità, l’impegno concreto e la stessa configurazione civica dell’Oratorio.
CRITERI ORATORIANI DI IMPEGNO EDUCATIVO
L’esperienza oratoriana sulla cittadinanza, considerata alla luce di una diagnosi valutativa «kairologica», ci permette di cogliere alcuni criteri di giudizio pastorale utili al nostro discernimento comunitario ed ecclesiale. In particolare, tale tema contiene almeno tre principi teologici di base che potremmo brevemente così definire: l’umanizzazione, l’incarnazione e la popolarità.
Primo criterio: il cittadino cristiano
La prassi oratoriana espressa nella finalità di voler educare il «cittadino cristiano» ha in sé una precisa visione antropologica unitaria di fondo. Nella convinzione che non sia in alcun modo separabile il cittadino dal credente, vi è l’idea di uomo come unità relazionale radicata nella tradizione biblica «dell’imago Dei».[12] Il dinamismo dell’atto creatore, reso ancora più esplicito dai termini ebraici «demut» e «selem», mette in luce una linea di continuità tra il piano della creazione e quello della redenzione, così come è attestato nella teologia dei Padri della Chiesa. Solo nei secoli successivi si è venuta a creare la separazione tra «il naturale» e «il soprannaturale». «L’immagine divina impressa nell’essere umano finì per costituire qualcosa di aggiunto… Dio acquisì l’aspetto di una grossa entità metafisica, immutabile, onnipotente; perciò si distingueva tra l’umano o naturale e il divino o soprannaturale».[13] La concezione di umano diventava così un’astrazione di ciò che l’uomo era in sé senza il soprannaturale. Al contrario, il riferimento ad una antropologia unitaria aiuta a comprendere come Dio stesso non abbia mai voluto creare prima «il cittadino» e poi «il cristiano», in quanto ha creato semplicemente uomini e donne umani. Da tali considerazioni, possiamo già dedurre il primo criterio, decisivo per interpretare la prassi oratoriana della cittadinanza, ovvero il principio dell’Umanizzazione. Esso indica «la via più adeguata per unire la fede con la vita e per interpretare – comprendere entrambe attorno all’umano autentico».[14] Secondo tale principio antropologico, educare alla cittadinanza esprime, quindi, come fine educativo, quello della piena umanizzazione della persona all’interno di una unità relazionale che conduce alla piena conformità a Cristo. Per dirla in breve, il cittadino cristiano cresce e si consolida non come uomo che «si realizza da solo, ma grazie alla collaborazione con gli altri e ricercando il bene comune».[15]
Secondo criterio: il cristiano nel mondo
Non si può educare alla cittadinanza in Oratorio senza riferimento al territorio e alla cultura locale. Questa dimensione intrinseca all’Oratorio lo rende, come si affermava nell’introduzione, adattabile ai diversi contesti. Entrare nelle dinamiche della vita quotidiana per assumerne concretamente e fino in fondo il linguaggio, le problematiche e le potenzialità non è una ragione di opportunità o di convenienza, ma delinea, invece, il principio dell’Incarnazione che contrassegna fino in fondo l’intera prassi oratoriana. Tale principio «rappresenta la novità incredibile e addirittura scandalosa del Cristianesimo… nell’Incarnazione l’essere divino si rivela nell’abbassamento della sua grandezza fino ad accreditarsi davanti a noi con una natura umana».[16] Il Concilio Vaticano II ci ricorda che il mistero dell’essere umano «trova vera luce nel mistero del Verbo Incarnato. Adamo infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro e cioè di Cristo, il quale svela pienamente l’uomo a se stesso».[17] Con l’irrompere del divino nell’umano, viene poi anche meno la separazione tra sacro e profano; ne deriva, quindi, uno stile fortemente ancorato alla vita quotidiana e pregno di responsabilità. Educare il buon cristiano significa non farne un «angelo disincarnato» separando la sua esistenza terrena attuale da quella celeste futura, ma un uomo che sa dire ogni giorno il proprio sì pieno alla vita, in un orizzonte che sa andare oltre la morte stessa. Questo è il motivo per cui l’Oratorio non ha mai seguito la via della «fuga mundi», ma al contrario ha sempre proposto una spiritualità incarnata, secondo quella tipica espressione di Domenico Savio «noi facciamo consistere la santità nello stare allegri» o di Laura Vicuña «per me pregare o lavorare è la medesima cosa; è lo stesso pregare, giocare o dormire. Facendo ciò che è richiesto, faccio quello che Dio vuole: questo è ciò che voglio, questa è la migliore orazione».[18] Il principio dell’Incarnazione evidenzia che per arrivare a Dio non bisogna fuggire o elevarsi al di sopra dell’umano; al contrario: «conoscere Dio e raggiungerlo non suppone un’uscita dalla nostra realtà, ma la realizzazione più profonda della nostra umanità».[19]
Terzo criterio: i cittadini nella chiesa
La prassi di cittadinanza, come la stessa natura dell’Oratorio, non ha una funzione meramente sociale o istituzionale; la sua origine è nello stesso mistero di Dio, pertanto se l’oratorio esiste laddove c’è una comunità che vive la gioia di riconoscersi come madre di quei figli che Dio ha generato, allora la stessa prassi educativa altro non è che l’esercizio di una maternità responsabile.[20] Visto da questo orizzonte ecclesiologico rivisitato dal Concilio Vaticano II, l’Oratorio non è più pensabile come monade o cittadella separata, isolata, fortificata e inaccessibile, ma come luogo aperto al dialogo e quindi come un «ponte».[21] L’attenzione ai piccoli, agli ultimi, agli emarginati, agli stranieri diventa allora essenzialmente un principio teologico, ovvero quello di una Chiesa come Popolo di Dio, definizione che, lungi dall’essere una concezione populista, mette in luce non tanto la dimensione sociologica della Chiesa ma la sua appartenenza a Dio. Contestualmente, ne richiama la dimensione storica ed escatologica, quella di una Chiesa che vive nella storia, ma è chiamata a trascenderla e per ciò a divenire universale, ovvero aperta a tutti. Il principio della Popolarità delinea lo stare vicino alla gente. L’Oratorio, nella sua imprescindibile fisionomia è proprio un’esperienza di tutti e per tutti anzi promuove la pluralità, rivelandosi, in altre parole, popolare; come il lievito che fermenta la massa [22] all’interno del più ampio orizzonte del Regno di Dio. Da tale visione di una Chiesa non separata dal mondo, ma che sta nel mondo,[23] deriva un sano concetto di laicità con la peculiare indole secolare.[24] E se educare alla cittadinanza significa non ignorare la giustizia, la legalità, il bene comune, allora essere cittadini nella Chiesa significa assumere consapevolezza della propria vocazione come servizio nel mondo.
PRASSI ORATORIANA DI CITTADINANZA
L’elaborazione dei criteri ci consente ora di illustrare la prassi oratoriana sulla cittadinanza in un percorso educativo e comunitario illuminato dalla fede. Ne considereremo sia le finalità e le attività che la stessa configurazione civica dell’Oratorio.
In Oratorio per formare «l’onesto cittadino e il buon cristiano»
Il fine dell’Oratorio, riassunto nello slogan «onesti cittadini e buoni cristiani», conferma quanto già detto sull’unità della persona. In Oratorio, l’intera proposta formativa tende, attraverso l’accompagnamento, a far crescere persone libere, autocoscienti e pienamente conformate a Cristo.
L’educazione alla cittadinanza è, quindi, l’azione di maturazione di una persona che sappia, poi, inserirsi da protagonista e in modo attivo all’interno della rete sociale e che sia capace di responsabilità e condivisione. «Aiutare il giovane a scoprire il sociale come luogo della solidarietà in cui riproporre se stessi senza mistificazioni» e quindi condurre ad «un modo di essere cittadini, fondato sulla solidarietà espressa nella libertà del gesto volontario e gratuito»[25]è l’obiettivo dell’Oratorio. Aver chiara la finalità, permette di poter distinguere l’Oratorio da un Centro socio-assistenziale: se quest’ultimo ha lo scopo di fornire servizi, l’Oratorio invece ha quello di far crescere il cittadino cristiano in una comunità che sa dare credito e fiducia alle nuove generazioni. Finalità e obiettivi non possono, però, trascurare un metodo attento alla gradualità e alla chiarezza della proposta, la quale si può articolare almeno in tre specifici momenti.[26]
Il primo, che la stessa tradizione dell’Oratorio ci consegna come condizione obbligata, è quello dell’accoglienza, una fase che consente di costruire una relazione di tipo personale, approccio determinante per liberare l’uomo «condizionato dalle cose che produce» e trasformarlo da utente in protagonista. Una sfida notevole se si pensa che la concezione dell’uomo-utente «è rimasta, nei fatti, dominante e vede il rapporto tra persona e servizio come una dialettica tra fornitore e cliente, all’interno della quale quest’ultimo può, al massimo, protestare o rivendicare una migliore qualità dei servizi, ma non intervenire sui meccanismi della loro produzione».[27]
Il momento successivo di tale proposta educativa alla cittadinanza, è la ricerca di senso, ovvero l’incontro con Gesù che coinvolge la vita in un’avventura e le lascia assaporare «il gusto del dono». Un cammino di liberazione che, attraverso un progetto di vita, permette di dare consistenza ai sogni spesso risucchiati dal vortice del «bisogno di consumare» subito e in fretta e che consente, nel tempo, di vedere i propri desideri realizzarsi.
Il terzo momento è quello finale dell’orientamento verso qualcosa d’altro, un distacco che prevede un «andare». Chi è cresciuto in Oratorio, deve continuare a prendersi cura di sé e degli altri in ogni ambiente in cui è chiamato a vivere. Il suo ruolo sarà sempre accanto a chi si trova in difficoltà per lottare e rimuovere insieme le logiche dominanti, le cause del disagio, costruire insieme risposte adeguate ed efficaci nel rispetto della complessità dei bisogni e dei diritti, nella vicendevole accoglienza.
Ma se questo è il fine come lo si realizza?
Attraverso un concreto tirocinio di cittadinanza
Prima di tracciare alcuni punti tematici fondamentali sulle attività e la prassi per una educazione alla cittadinanza, occorre fermarsi a riflettere in primis sul ruolo insostituibile della famiglia in Oratorio. Genitori e figli devono essere impegnati in un tirocinio di Cittadinanza insieme. Tutto prende avvio già dal modo di condividere spazi ed esperienze, non solo tra genitori che scoprono una paternità e una maternità più grande e che va oltre la mera funzione generativa, ma anche tra ragazzi che allargano la propria rete di relazioni.
È in questo contesto che possiamo cominciare a tracciare dei capitoli, dei percorsi concreti per educare alla cittadinanza. Tra i principali, il primo è indubbiamente quello del rispetto delle regole proposte come condizione per realizzare il futuro.
«Quello che occorre ribadire con forza è che le regole (poche e chiare) servono a far stare meglio: non necessariamente a far stare meglio me, ora e qui, ma far stare meglio, insieme a me, gli altri, altrove e domani».[28] Alla luce di questa considerazione, il regolamento dell’Oratorio è scritto insieme ai ragazzi non tanto come un mero elenco di diritti e doveri, ma con l’intento di far loro percepire che dietro ogni regola sia contenuto un sogno, una condizione che permetta il realizzarsi di un ambiente migliore e di persone migliori. Da non trascurare è poi l’elemento della sanzione o della punizione «che viene comminata senza che entri in gioco la soggettività dell’educatore, il suo moralismo, il suo latente sadismo».[29]
Altro capitolo è quello che riguarda la diversità scoperta come ricchezza e la questione delle minoranze. In tal senso, l’attività ludica concretamente ben si presta a dimostrare la preziosità di ognuno e a valorizzare ciascun talento.
Non può mancare poi una riflessione sul bene comune, perché si comprenda che rinunciare ai propri egoismi consente il realizzarsi del bene personale in quello comunitario, contro una dominante logica individualista. Nasce di qui il principio della partecipazione;[30] in Oratorio, questo si traduce concretamente nel prendersi cura di sé e degli altri, specialmente se più piccoli o appena arrivati, sapendo che ogni azione individuale ha effetti sul resto della comunità.
Decisivo, a questo punto, è il capitolo della responsabilità che porterà i ragazzi ad una presenza non più passiva, ancorata al già tutto preparato o programmato, ma ad una partecipazione attiva; li si chiamerà a dare il proprio fattivo e propositivo contributo per il buon esito di tutte le attività dell’Oratorio. È così che il ragazzo più grande viene condotto alla scoperta del servizio, inizialmente assumendo singoli incarichi all’interno della comunità, man mano iniziando a collaborare insieme agli altri fino ad arrivare a considerare la sua stessa vita come servizio. Verso l’età giovanile verrà coinvolto in attività di volontariato, invitato ad una presenza attiva nel proprio ambiente di vita, così come a scuola negli organismi di partecipazione (consigli di classe o d’Istituto) fino al raggiungimento della maggiore età quando, attraverso l’esercizio del voto potrà direttamente partecipare alla vita politica della comunità civile nella quale è inserito. La prospettiva di fondo di tutto questo cammino educativo alla cittadinanza è quella di spingere i giovani a saper continuamente mettere in gioco la propria vita «nella circolarità ermeneutica della solidarietà tra Io e Noi».[31]
La configurazione civica dell’Oratorio
Senza voler mettere in ombra quanto affermato nell’introduzione sulla titolarità ecclesiale dell’esperienza oratoriana, giunti a conclusione, è importante precisare come tale esperienza d’Oratorio possa assumere anche una configurazione civica; in tal senso va interpretata anche la legge 206, approvata a maggioranza dal Parlamento Italiano il 1° agosto 2003.
Il fatto che l’Oratorio possa essere al contempo ecclesiale e civile, è un elemento degno di considerazione, tanto più perché la configurazione civile nulla toglie all’ecclesialità delle attività oratoriane molte delle quali, di per sé, non sono prettamente di culto o di religione e, quindi, sono difficilmente attribuibili alla titolarità della parrocchia (secondo gli accordi pattizi concordatari).
Alla luce dei criteri teologici individuati per il discernimento di una «cultura oratoriana di cittadinanza», è chiaro che all’Oratorio ben si addica la convenienza di una tale configurazione civica, necessaria per la sua presenza all’interno della società civile, una presenza non semplicemente intesa come supplenza nei confronti di uno Stato assente, ma come partecipazione attiva e responsabile lì dove si concertano le politiche giovanili o le scelte di una città. Secondo la normativa più adeguata di riferimento, le forme di questa configurazione possono essere diverse: fondazioni, federazioni, associazioni di Oratori; tutte forme valide e attuabili, ma non per un privilegio di esenzione, bensì appunto per una sana testimonianza di civismo, laicità e speranza.
NOTE
[1] L’Autore è Presidente Nazionale ANSPI (Ass. Nazionale degli Oratori e Circoli Giovanili).
[2] CEI, Educare alla vita buona del vangelo, Roma 2010, n. 42.
[3] Ivi, n. 41.
[4] Sabbadini M., Un’esperienza decennale nel FOI, in NPG, XLV, 1, 2011, pag. 44.
[5] Ivi.
[6] Bosco G., Memorie dell’Oratorio di S. Francesco di Sales dal 1815 al 1885, (Introduzione, note e testo critico a cura di A. da Silva Ferriera, LAS, Roma 1991), pag. 199-200.
[7] Contini L., L’evoluzione del concetto di cittadinanza, XXIII Congresso Nazionale per amministratori e operatori dei servizi demografici, a cura del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Merano, 2-5 dicembre 2003, Palazzo «Kurhaus».
[8] Rossi U., La cittadinanza oggi. Elementi del dibattito dopo T. H. Marshall, Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche e Sociali dell’Università degli Studi di Siena, Working Paper, 2000.
[9] Moral J.L., Giovani e Chiesa, vol. 3, LDC, Leumann – Torino, 2010, pag 239
[10] Ivi, pag. 248.
[11] Midali M., Teologia pastorale o pratica, LAS, Roma, 1991, pag. 572-598. Fornisce un itinerario metodologico articolato individuando nella fase «kairologica» l’analisi e l’interpretazione della prassi servendosi sia delle scienze umane che dell’illuminazione della fede.
[12] Con alcune rare eccezioni, la maggior parte degli esegeti contemporanei riconosce la centralità del tema dell’imago Dei nella rivelazione biblica (cf Gn 1,26-27; 5,1-3; 9,6). Questo tema viene visto come la chiave per una comprensione biblica della natura umana e per tutte le affermazioni di antropologia biblica nell’Antico come nel Nuovo Testamento. Per la Bibbia, l’imago Dei costituisce quasi una definizione dell’uomo: il mistero dell’uomo non può essere compreso separatamente dal mistero di Dio.
[13] MORAL J. L., vol. 3, op. cit, pag 117.
[14] Ivi, pag 129.
[15] CEI, Educare alla vita buona, op. cit., n. 54.
[16] Moral J. L, vol. 3, op. cit., pag. 107.
[17] G.S. n. 22.
[18] Frase attribuita a Laura Vicuña.
[19] Moral J. L., vol. 3, op. cit. pag. 111.
[20] Spezzibottiani M., Non c’è Oratorio senza Domenica, Bologna, EDB, 2005, pag. 18-20, l’Oratorio: una concreta esperienza di Chiesa.
[21] Giovanni Paolo II, Discorso ai giovani della diocesi di Roma del 5 aprile 2001. «Rilanciate gli Oratori come ponti tra la Chiesa e la strada con particolare attenzione a chi è emarginato e attraversa momenti di disagio, o è caduto nelle maglie della delinquenza».
[22] Lc 13, 21.
[23] Gv 11,16.
[24] L.G. n. 31 «Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio»
[25] Pollo M., Animazione Culturale. Teoria e Metodo, LAS, Roma, 2002, pag. 208. Nella terza parte viene trattato il tema della cittadinanza attiva all’interno del più ampio obiettivo della partecipazione alla vita sociale.
[26] La proposta fa riferimento alle tre tappe presentate nei Quaderni dell’Accademia dei Ricreatori, vol. 1, Progettare l’Oratorio, liberamente tratto dal testo BARESI-FORNASINI, Oratori possibili, LDC, 2008.
[27] POLLO M., op. cit., pag. 202.
[28] MANTEGAZZA R., «Educare alla Costituzione 5», in NPG, XLV, 4, 2011, pag. 63.
[29] Ivi, pag, 64.
[30] Mantegazza R., «Educare alla Costituzione 4», in NPG, XLV, 3, 2011, pag. 72.
[31] Pollo M., op. cit. pag. 204.