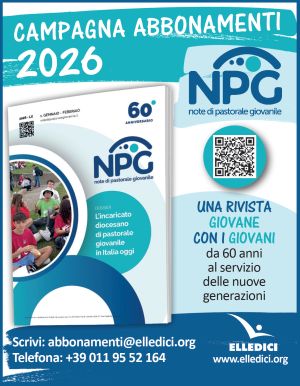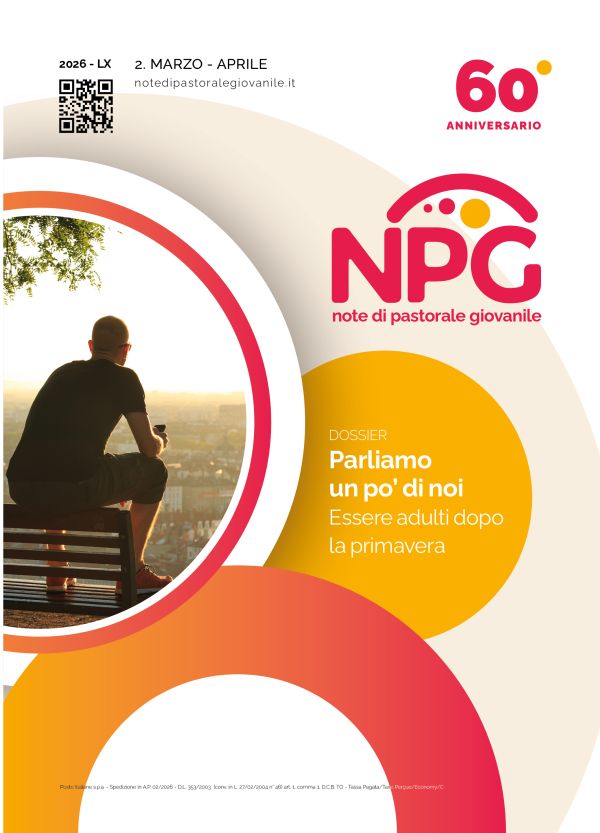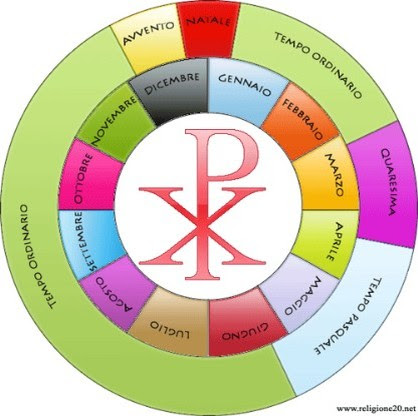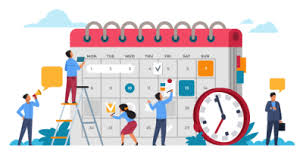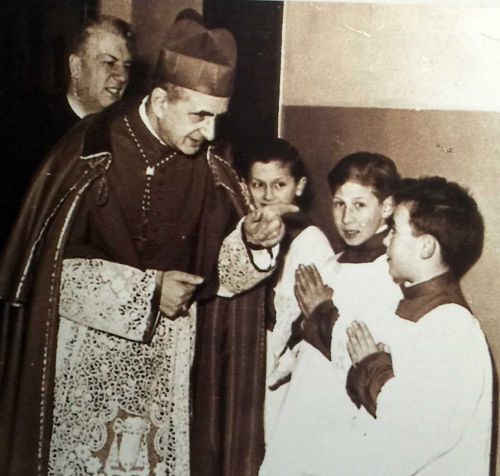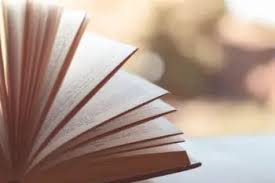PierAngelo Sequeri:
orizzonti di fiducia
Michael Paul Gallagher

Il più giovane dei nostri 'esploratori della fede', PierAngelo Sequeri, membro eminente della Facoltà di Teologia di Milano, è anche molto noto come compositore e come creatore di una scuola di musicoterapia per persone con forme di disagio psichico e mentale. Come molti altri pensatori esaminati nei capitoli precedenti, Sequeri intende andare oltre un'impostazione teologica freddamente razionale e sviluppare un linguaggio più ricco con cui riflettere sulla fede.
Dopo la Riforma, noi cattolici abbiamo posto l'accento sul credere come assenso intellettuale, a tal punto da dimenticare spesso altre dimensioni della fede che epoche precedenti avevano riconosciuto e apprezzato. Affermiamo che la fede implica una decisione libera, ma raramente ci domandiamo come viviamo, in pratica, quella libertà. Non neghiamo che la fede possa coinvolgere i sentimenti, ma releghiamo l'affettività in quello che abbiamo (vagamente) chiamato spiritualità. Finché predomina questo modello cognitivo, la fede viene concepita come accettazione della verità di certe affermazioni su Dio. Nonostante la grande tradizione dell'arte cristiana, molte immagini delle nostre chiese sono state private della profondità, come se avessimo dimenticato che la fede ha a che vedere con la bellezza.
La teologia di Sequeri è un primo passo verso la guarigione da simili forme di dimenticanza e impoverimento. La verità, egli dice, ha bisogno di riscoprire il suo rapporto con almeno tre zone trascurate: la libertà, l'affettività e la bellezza. Non possiamo riconoscere la verità religiosa se non scegliamo l'amore, se non lasciamo che i nostri cuori siano toccati, se non siamo in qualche modo sopraffatti dalla bellezza e stranezza di Dio.
Riconoscere i danni
Forse il modo migliore di avvicinarsi al pensiero di Sequeri sulla fede è partire dalla sua critica ai rischi presenti nella cultura di oggi. In primo luogo egli diffida della razionalità nata dalla modernità scientifica e sottolinea i danni che ha arrecato alla teologia. Una razionalità angusta ha generato un'immagine sminuita di chi siamo e di come dovremmo accostarci alla verità. Quando la teologia cerca di imitare il metodo scientifico, finisce col trascurare il dispiegarsi dell'esperienza religiosa e l'incontro vivo con la rivelazione. La chiarezza dottrinale (peraltro indispensabile) è diventata un idolo e la verità religiosa è stata separata dall'avventura quotidiana dell'imparare ad amare il prossimo. Questo modo di accostarsi alla fede evoca l'idea di un Dio dispotico o di una teistica `spiegazione dell'universo' (non sfugga l'eco della &Aie). Così la teologia è diventata stranamente silenziosa sulle realtà del vivere cristiano, compreso quello che Ruth Burrows ha chiamato il pendolo acceso/spento della fede personale.
Dalla modernità ci viene un secondo problema. Se l'idea dominante di verità è troppo impersonale, il paradigma moderno della libertà è quello dell'individuo autosufficiente, che non ha nessun bisogno della fede religiosa e dei cambiamenti che essa porta con sé. Sequeri nutre grande diffidenza verso questo genere di realizzazione autosufficiente, che accosta alla leggenda di re Mida: tutto ciò che ne è toccato si trasforma in narcisismo autodistruttivo. In breve, la modernità ha «raggelato il divino», ha «eroso il soggetto» e ha mancato di immaginare «una verità affidabile».
Se il nuovo quadro di razionalità e libertà tende a escludere la possibilità della fede, un terzo terreno di scontro passa per lo più inosservato. La teologia è stata talmenteimpegnata nel rispondere alla sfida dell'illuminismo sul piano razionale da trascurare una delle principali rivoluzioni culturali dello stesso periodo. Sequeri considera il movimento romantico un autentico, anche se ambiguo, tentativo di difendere le nostre possibilità spirituali. Propugnato da artisti e poeti, opponeva resistenza al grigio mondo della rivoluzione industriale e a un'idea esclusivamente empirica della verità. La sensibilità romantica, che si appellava ai sentimenti delle persone, continua a esercitare un'influenza profonda nel mondo postmoderno e, come Charles Taylor, Sequeri avverte che l'enfasi romantica sui sentimenti personali rischia facilmente di finire in un angusto individualismo. Egli ci vede anche segnati da una divisione della coscienza: la capacità di gestire saggiamente i cambiamenti non ha tenuto il passo della complessità tecnica delle nostre vite e i tipici modi di pensare non arrivano alle nostre necessità più profonde. Nel 2001 Sequeri ha così riassunto il suo punto di vista: «La questione della dignità spirituale dell'umano – e della qualità cristiana della fede, rispettivamente – sembra a me il tema della grande sfida imposta alla cultura occidentale» (SS, p. IX). A suo parere il mondo della fede ha bisogno di un genere nuovo di ragionamento, e il mondo della ragione deve ritrovare un collegamento con le profondità spirituali della nostra umanità.
Ricordando una famosa filastrocca, potremmo dire che Humpty Dumpty prova a rimettere insieme i suoi pezzi dopo un «gran capitombolo». Se i nostri modelli di verità sono finiti nella limitatezza e le nostre immagini della libertà in una chiusa autorealizzazione, come possiamo ricostruire ponti che colleghino verità e libertà? C'è molto nell'ordinario dispiegarsi dell'esistenza che non può essere colto dai sensi. In particolare, la verità della fede religiosa non può mai essere verificata attraverso l'evidenza esterna (con buona pace del professor Dawkins). Quando due persone si amano abbastanza da decidere di passare insieme il resto della vita, interviene qualcosa di più della compatibilità neuronale o psicologica. Molti livelli della loro umanità sono entrati in gioco. Sequeri ci chiede quindi di allargare l'orizzonte del nostro pensiero sulla fede, e in particolare di permettere una convergenza di almeno cinque dimensioni profonde di noi stessi: oltre alle nostre concezioni di verità e libertà, anche quelle di etica, affettività e percezione estetica. In caso contrario, Humpty Dumpty resterà in pezzi e noi resteremo privi di un prezioso livello di esplorazione delle questioni di fede.
Per ricapitolare lo scenario: culturalmente abbiamo sofferto di un'eredità sbilanciata dalla modernità e in particolare da tre forme riduttive di isolamento. Facendo coincidere la ragione con la verificazione empirica, si possono ottenere grandi successi nelle scienze, ma causare distorsioni in ambito umano. Facendo coincidere la libertà con l'autodeterminazione, costringiamo in uno spazio limitato uno splendido dono di ogni essere umano. Ancora: se i sentimenti diventano la nostra unica bussola, viene valorizzato un aspetto importante dell'umanità, ma a scapito di altri suoi naturali compagni. E se la verità è separata dalla libertà e dai sentimenti, ci ritroviamo menomati nell'affrontare le questioni esistenziali, perché questi ambiti personali, riguardando la nostra storia, i nostri sentimenti e le nostre opzioni, disposizioni e relazioni, hanno bisogno dell'intero sé. «La nostra vita sentimentale è il grande fiume nel quale impariamo ad apprezzare ciò che è veramente decisivo per noi; ciò che ci tocca e convince, ciò che chiede il nostro impegno e fa appello alla nostra risposta» (svi, p. 74).
Imparare dall'estetica
Essendo un musicista e un compositore, oltre che un uomo abituato a parlare in pubblico di arte, non sorprende che Sequeri sia tra coloro che auspicano una rivalutazione dell'estetica nella teologia. Nel 2000 egli scriveva: «Senza la mediazione dell'immaginario [.. .] lo spirito è cieco e muto anche sulle grandi questioni del senso. L'interiorità non prende forma per l'uomo né giunge a sapere di sé senza la mediazione simbolica del sensibile» (ED, p. 13). Al cuore della nostra esperienza dell'arte, secondo lui, sta una conoscenza dello spirituale attraverso i nostri sensi, ma per troppo tempo i teologi hanno cercato di discutere la fede senza prestare attenzione a sentimenti o alla bellezza o all'esperienza. Con la scusa di proteggere una qualche purezza di verità, ci hanno impedito di vedere la rivelazione come un dono che ci supera e ci trasforma.
Eppure i momenti di incontro con l'arte sono un'azzeccata analogia della fede, perché ci invitano a uscire dai nostri piccoli sé. Tale effetto è colto dal famoso verso finale della poesia di Rilke sulla statua di Apollo esposta al Louvre, un antico torso dissotterrato solo nel 1872 (citato anche da Balthasar). Il poeta contempla la sua incompleta grandiosità, priva di capo, braccia e gambe, solo per accorgersi che risplende di un'arcaica potenza e pronuncia una specie di giudizio. Conclude il poeta:
Non c'è punto di questa pietra
che non ti veda. Devi cambiare la tua vita.
Alla sua maniera, Sequeri ci rammenta che l'esperienza della fede contiene qualcosa di quel risvegliarsi della meraviglia, perché anch'essa comporta una risposta a una presenza soverchiante. La differenza è che ora siamo chiamati dall'Amore divino che si è fatto uomo in Gesù Cristo. In questo modo la bellezza della rivelazione cristiana unisce gloria e tenerezza. Come l'arte, contiene una chiamata dall'Altro a farsi altro, ma lo stesso incontro con Cristo ci dà il potere di cambiare. Alla luce di ciò, Sequeri afferma che «il nesso dell'esperienza estetica e della spiritualità cristiana deve riconquistare diritto di cittadinanza anche nella teologia» (ED, p. 440).
La fiducia come soglia
Ripercorrere il cammino della bellezza è un modo di salvarci dalla falsa obiettività. Un altro cammino che ottiene attenzione nel pensiero di Sequeri è collocato nell'ambito interpersonale. In modi che riecheggiano Newman (che non menziona mai), egli afferma che la fiducia, fondamentale per la fede religiosa, è altrettanto centrale in tutta l'esperienza umana. Molto di ciò che facciamo dipende dagli altri; senza una disposizione fiduciosa, come potremmo vivere? Sequeri ci invita a riconoscere come questa dimensione universale della nostra esperienza interpersonale ci guida al di là dei parametri esteriori e verso una logica più relazionale. Qui, però, egli va più in profondità di Newman. Credere agli altri fa parte della nostra antropologia primordiale. E quello che ci rende umani. È la sorgente della nostra dignità, il nostro modo abituale di conoscere. Siamo diventati ciechi a questo stato di cose a causa di un'eccessiva identificazione dell'osservazione impersonale con la conoscenza? Influenzati da questo presupposto predominante della nostra cultura, possiamo smarrire la fiducia nella fiducia, fino a farla sembrare un aspetto della conoscenza umana non più realmente centrale. Ma secondo Sequeri abbiamo bisogno di rivisitare in tutta la sua complessità il dispiegarsi della nostra fiducia. Solo allora avremo una base per riflettere sulla ricchezza della fede religiosa. Una delle linee principali dei suoi scritti ci invita a riflettere sulla nostra normale capacità di fidarci come chiave della nostra identità e, in definitiva, del nostro essere pronti per la fede.
L'atto del fidarsi di un'altra persona è di per sé relazionale, poiché si radica nel riconoscimento graduale che quella persona merita la nostra fiducia, ed è un atto in cui confluiscono ragionamento, decisione e sentimento. In realtà, è una caratteristica universale condivisa dall'intera umanità, e quando è compromessa o diminuita succede qualcosa di tragico. Sarebbe facile interpretare malamente questa convinzione come leggera o sentimentale, e avere timore che possa portare a una sorta di divorzio tra fede e ragione. In realtà, niente potrebbe essere più lontano dalle intenzioni di Sequeri. Semmai, come Ratzinger non ha mai perso occasione di esortarci all'allargamento della ragione, così Sequeri vorrebbe che vedessimo la fede come un genere di conoscenza più pieno di quello ottenibile tramite qualunque indagine distaccata e neutrale. In passato, la teologia ha parlato in abbondanza della 'credibilità' della fede, una parola che può avere implicazioni intellettualmente anguste, rinviando a un'analisi fredda e distaccata. Sequeri ci chiede invece di riflettere sull'affidabilità di Dio, e questo cambiamento di linguaggio implica una diversità di lunghezza d'onda. Come George Steiner ha sostenuto nel suo classico Vere presenze, non ci sarebbe nessuna storia dell'arte o della religione senza un iniziale atto di fiducia. Ma per Sequeri l'area della fiducia è anche un terreno di scontro. E dove vinciamo la radicata propensione al sospetto e all'ostilità, dove l'oscillazione costante tra fiducia e sfiducia rimanda alla battaglia tra chiusura e apertura alla grazia.
Tra i vari ponti da ricostruire uno in particolare è centrale per Sequeri: quello tra la nostra comprensione di noi stessi (l'antropologia) e la nostra comprensione di Cristo (la cristologia). Ripetutamente egli afferma che l'attuale crisi di fede ha due cause: un'idea troppo ristretta delle possibilità umane e un'idea altrettanto ristretta di Dio, basata, in ultima analisi, sulla negatività e la paura. Inoltre, a suo parere oggi la tipica perdita della fede «ha a che fare con gli affetti, non con l'idea», perché «non sentiamo più Dio» nella nostra vita (IC, p. 28). Contro le molte forme di incredulità che provengono dal sospetto, Sequeri afferma che la capacità di fidarci degli altri non solo è il cuore della nostra umanità, ma è anche la via maestra verso la fede. Nella nostra esperienza ordinaria, sostiene, «nessuna rivelazione di un'altra persona può verificarsi a meno di stabilire una relazione di fiducia» (TD, p. 143).
Lo spazio di preghiera di Cristo
Una volta capita la centralità antropologica del nostro fidarci degli altri, non potrà sfuggirci l'importanza del manifestarsi in Cristo della fiducia in Dio. Sequeri cerca quindi di orientarci verso quel culmine della fiducia che ci è dato scorgere nella rapporto di Gesù col Padre. Siamo qui di fronte alla fede nella sua forma più alta, in cui l'esperienza umana del fidarci trova un coronamento e un compimento nella fiducia reciproca del Padre e del Figlio. Qui la nostra immaginazione religiosa apprende un altro livello di fiducia partecipando, per così dire, al flusso di Dio. Tutto il sapere interpersonale è coronato e ispirato dall'amore tra Dio Padre e il Figlio diventato uomo. Abbiamo già citato il brano di Sequeri sull'amore umano: «La nostra vita sentimentale è il grande fiume nel quale impariamo ad apprezzare ciò che è veramente decisivo per noi, ciò che ci tocca e ci convince, ciò che chiede il nostro impegno e fa appello alla nostra risposta» (SVI, p. 74). Un simile, seppur diverso allargamento è raggiunto quando ci apriamo all'incontro di fede con Cristo e siamo invitati nello spazio unico del suo «luminoso rapporto con l'abbà-Dio» (IF, p. 112).
Anche se Sequeri, come si è visto, dedica molta attenzione ai pericoli culturali e spirituali che possono pregiudicare il nostro esser pronti per la rivelazione cristiana, il nucleo essenziale della sua teologia positiva della fede è l'invito a riflettere sul pregare di Cristo stesso. Benché alcuni teologi possano avere riserve in proposito, Sequeri è pronto a parlare di fede anche riguardo a Cristo stesso. «Io vedo Gesù come folgorato da un'intuizione, da una percezione, si potrebbe dire anche da una fede [...] nei confronti di Dio, del Padre» (IC, p. 55). In questo senso egli sostiene che scopriamo anche la nostra vera identità accostandoci contemplativamente alla fede di Gesù. Il mistero dell'identità di Cristo è percepito nel modo migliore in questo spazio di preghiera-fiducia con il Padre, una relazione unica in cui egli era guidato dalla «folgorante certezza dell'assoluta dedizione di Dio nei confronti dell'uomo» (IF, p. 107). Per Sequeri la nostra strada verso la pienezza della fede cristiana implica il riconoscimento della nuova visione scaturita dall'esperienza di abbà-Padre da parte di Cristo, una percezione di Dio che parla alla (e appaga la) nostra intera affettività.
Entrando attraverso la grazia in questo spazio della relazione di preghiera di Cristo, arriviamo a capire chi è Dio e anche chi possiamo essere noi. Qui tutto il nostro anelito alla verità e alla giustizia si unifica su un nuovo fondamento.
Lo shock della risurrezione
Se dedica un'attenzione particolare al nucleo relazionale della spiritualità di Cristo, Sequeri suggerisce anche un altro gruppo di esperienze evangeliche in grado di offrire una prospettiva cruciale riguardo alla fede: gli incontri dei discepoli con il Signore risorto. È sempre Gesù che prende l'iniziativa di mostrarsi, chiamando con affetto gli amici a un riconoscimento della verità capace di trasformarci. Simili momenti rappresentano per Sequeri «la capacità [di Gesù] di farsi riconoscere con certezza, nello Spirito, come il Figlio vivo del Dio vivente» (DA, p. 197). La fede che qui si manifesta è questione di un'intuizione non solo nuova, ma accompagnata da sentimenti di timore davanti a una novità sconvolgente. Quell'esperienza dei primi seguaci di Gesù continua a fare parte di ogni cammino di fede: gli apostoli passarono dallo «stupore incredulo» alla «fede testimoniale», spinti come furono a rileggere i loro ricordi degli anni della Galilea (DA, p. 206). Man mano che la realtà dell'Amore risorto penetrava nella loro immaginazione, essi poterono gradualmente vedere e interpretare tutto con occhi nuovi e raggiungere una consapevolezza del tutto diversa dell'agire divino in, e tramite, Gesù.
L'apologetica precedente si è concentrata talmente sulla realtà esteriore della risurrezione da relegare sullo sfondo il dramma del suo riconoscimento e l'effetto che ebbe sui discepoli. Un libro recente del teologo australiano Anthony Kelly appare particolarmente vicino al pensiero di Sequeri. Secondo Kelly, l'effetto della risurrezione, come vissuta dai primi seguaci di Gesù, inaugura una particolare lunghezza d'onda della razionalità cristiana. «La singolarità dell'evento della risurrezione deve in qualche modo lasciare nel disorientamento alcune forme di ragione, perfino di ragione teologica [...]. Il suo risorgere dai morti lascia stupefatte tutte le forme di ragione logica» (RE, p. 7). Anche Sequeri ci vorrebbe concentrati sulla fede in quanto ricettività al puro essere-oltre che è Dio. L'incontro con Gesù risorto ci guida, al di là della normale razionalità, a una razionalità della meraviglia e della relazione, che permette la sintesi dei molti piani della nostra umanità, dal raziocinio ai sentimenti e dalla libertà alla gratitudine, colmati dalla straordinaria novità, bellezza e sorpresa della vittoria di Dio.
Tirare le somme
Già da queste poche pagine dovrebbe essere evidente che PierAngelo Sequeri è un pensatore ambizioso e difficile. Non è un'impresa da poco condensare le sue idee in uno spazio piuttosto limitato, ma mi è parso che valesse la pena di provare. Tentiamo una sintesi finale dei principali filoni del suo pensiero.
Se la nostra cultura convive con immagini di sé troppo anguste, può facilmente misconoscere non solo la fede religiosa ma tutte le forme del fidarsi. Tuttavia, ciò che succede quando permettiamo a un'opera d'arte di influenzare i nostri sentimenti e risvegliare la nostra immaginazione mostra una strada verso il senso più personale delle forme più fredde della razionalità. Dobbiamo quindi dar spazio alle dimensioni estetica, simbolica, affettiva e interpersonale in quanto vie profonde verso la verità.
L'essere con gli altri in un sistema di rapporti reciproci precede ogni sapere astratto. La nostra attitudine a fidarci nasce lì e rappresenta la forma più originale di conoscenza. La fiducia affettiva è la radice di tutti i nostri ragionamenti. Grazie a questa pietra angolare della nostra umanità, scopriamo che la fede religiosa è la prosecuzione e il perfezionamento dei quotidiani atti di fede che viviamo nei rapporti con gli altri.
Prima di 'aver fede', ci fidiamo. In seguito, riconoscendo nella Fiducia di Gesù la nostra chiamata più piena, l'antropologico diventa teologico, così come il teologico si radica nella nostra storia. Diventando teologico, l'antropologico scopre una pienezza al di là di ogni immaginazione. I momenti privilegiati di amicizia – la bellezza e potenza della nostra attitudine a fidarci – ci rivelano come possiamo accostarci alla relazione fondamentale di Cristo manifestata dalle descrizioni evangeliche del suo pregare. Lì possiamo vedere il compimento, storico e insieme eterno, delle nostre speranze umane nel reciproco amore della Trinità. Questa realtà di Dio-amore non è accessibile come un dato empirico, ma solo come un incontro nella fiducia.
L'atto di fede è, a vari livelli, centrale per chi noi siamo, è risvegliarsi a una relazione, a una possibilità di fiducia, a una presenza e a una promessa. È riconoscimento di un riconoscimento, in cui mi è dato riconoscere di essere riconosciuto da Dio.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ALLE OPERE DI PIERANGELO SEQUERI
DA = Il Dio affidabile, Brescia 1996.
ED = L'estro di Dio. Saggi di estetica, Milano 2000.
IC = Interrogazioni sul cristianesimo (con G. Vattimo e G. Ruggeri), Roma 2000.
IF = L'idea della fede, Milano 2002.
SS = Sensibili allo spirito, Milano 2001.
SVI = Senza volgersi indietro, Milano 2000.
RE = Anthony J. Kelly, The Resurrection Effect, New York 2008.
(Mappe della fede, Vita & Pensiero 2011, pp. 157-167.