L'ateismo
André Comte-Sponville
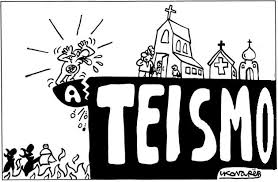
«La fede salva, dunque mente».
(Nietzsche)
L'ateismo è un oggetto filosofico singolare. È una credenza, ma negativa. Un pensiero, ma che si nutre solo del vuoto del suo,oggetto.
E ciò che indica sufficientemente bene l'etimologia: quella piccola a privativa, davanti all'immenso theós (dio)... Essere atei significa essere senza dio, o perché ci si accontenta di non credere in nessun dio, o perché si afferma l'inesistenza di tutti. In un mondo monoteista come il nostro, si potranno di conseguenza distinguere due diversi tipi di ateismo: non credere in Dio (ateismo negativo) o credere che Dio non esista (ateismo positivo e perfino militante). Assenza di credenza o credenza in un'assenza. Assenza di Dio o negazione di Dio.
Bisogna però evitare di sottolineare eccessivamente la differenza tra questi due ateismi. Si tratta di due correnti piuttosto che di due fiumi; di due poli, ma in uno stesso campo. Ogni non credente può tranquillamente collocarsi, esitare, fluttuare tra i due... Non per questo è meno ateo. O si crede in Dio, o non vi si crede: è ateo chiunque scelga il secondo termine dell'alternativa.
E l'agnostico? È colui che rifiuta di scegliere. Molto vicino in questo a ciò che chiamavo l'ateismo negativo, ma più aperto – è questo il suo tratto distintivo – alla possibilità di Dio.
È come un centrismo metafisico, o uno scetticismo religioso. L'agnostico non prende posizione. Non si decide. Non è né credente né non credente: lascia il problema in sospeso. Per farlo ha delle ottime ragioni. Dal momento che non si sa se Dio esista (se lo sapessimo, la questione non si porrebbe più), perché ci si dovrebbe pronunciare sulla sua esistenza? Perché affermare o negare ciò che si ignora? L'etimologia, ancora una volta, è illuminante. Ágnostos, in greco, significa l'ignoto o l'inconoscibile. L'agnostico, in materia di religione, è colui che ignora se Dio esista o meno, e si attiene a questa ignoranza. Come rimproverarglielo? L'umiltà sembra dalla sua parte. La lucidità sembra dalla sua parte. Per esempio in questa bella formula di Protagora: «Sugli dèi non posso dire niente, né che siano, né che non siano. Troppe cose impediscono di saperlo: in primo luogo l'oscurità della questione, in secondo luogo la brevità della vita umana». Posizione rispettabile, è ovvio, e che sembrerebbe anche di buon senso. Essa rimanda il credente e l'ateo al loro comune eccesso: entrambi dicono più di quanto sappiano.
Ma questo, che è il punto di forza dell'agnosticismo, ne è anche la debolezza. Se essere agnostici significasse soltanto non sapere se Dio esista, dovremmo essere tutti agnostici –poiché nessuno di noi dispone di un sapere su tale questione. L'agnosticismo sarebbe in questo senso più un dato della condizione umana che una posizione filosofica. Se incontri qualcuno che ti dice: «So che Dio non esiste»: non è un ateo, è uno sciocco. Diciamo che è uno sciocco che prende la sua miscredenza per un sapere. Allo stesso modo, se incontri qualcuno che ti dice: «So che Dio esiste»: è uno sciocco che ha la fede. La verità, è necessario insistervi, è che non lo sappiamo. Credenza e miscredenza sono indimostrabili, e questo è ciò che le definisce: quando si sa, non c'è più motivo di credere o non credere. Tanto che l'agnosticismo perde in comprensione, come dicono i logici, ciò che guadagna in estensione. Se è una cosa a cui tutti quanti sono soggetti, che senso ha appellarsi ad esso?
L'agnosticismo diventa filosoficamente significativo solo quando anch'esso va oltre la semplice affermazione della sua ignoranza: affermando che questa affermazione è sufficiente o migliore delle altre. Equivale a scegliere di non scegliere. Questo basta a dirci, per contrasto, che cos'è l'ateismo: una scelta, che può essere negativa (non credere in Dio) o positiva (credere che Dio non esista), ma che presuppone sempre una presa di posizione, un impegno, una risposta – laddove l'agnosticismo, è questa la sua grandezza e il suo limite, si ferma alla domanda e la lascia aperta.
L'agnostico non prende posizione. L'ateo sì: si schiera contro Dio, o meglio contro la sua esistenza.
Perché? Non ci sono prove, e a questo proposito gli atei sono stati spesso più lucidi dei credenti. Non vi è affatto l'equivalente, nella storia dell'ateismo, delle famose e pretese 'prove dell'esistenza di Dio'... Come provare una inesistenza? Chi potrebbe provare, per esempio, che Babbo Natale non esiste? Che i fantasmi non esistono? Come provare, a fortiori, che Dio non esiste? Come potrebbe la nostra ragione dimostrare che niente la oltrepassa? Come potrebbe confutare ciò che, per essenza, sarebbe fuori dalla sua portata? Questa impossibilità non ci condanna tuttavia alla stupidità, né giustifica che si rinunci a pensare. Non ci sono prove, ma ci sono argomenti. Poiché sono ateo, vorrei abbozzarne qualcuno.
Il primo, molto semplice, è puramente negativo: un valido motivo per essere atei è innanzitutto la debolezza degli argomenti opposti. Debolezza delle 'prove', certo, ma anche delle esperienze. Se Dio esistesse, la cosa si dovrebbe vedere o sentire di più! Perché Dio starebbe a tal punto nascosto? I credenti in genere rispondono che è per preservare la nostra libertà: se Dio si mostrasse in tutta la sua gloria, noi non saremmo più liberi di credere o meno...
Tale risposta non mi soddisfa. In primo luogo perché in questo modo noi saremmo più liberi di Dio (come potrebbe, poveretto, dubitare della propria esistenza?) o della maggior parte dei suoi profeti (che si suppone lo abbiano incontrato di persona), cosa che sembrerebbe filosoficamente e teologicamente difficile da pensare.
In secondo luogo, perché c'è sempre meno libertà nell'ignoranza che nel sapere. Per rispettare la libertà dei bambini, dovremmo forse rinunciare a istruirli? Ogni insegnante e ogni genitore fa la scommessa opposta: che i giovani, al contrario, saranno tanto più liberi quanto più sapranno! L'ignoranza non è mai libera; la conoscenza, mai schiava.
Infine, e soprattutto, perché l'argomento mi sembra incompatibile con l'immagine, oggi dominante, di un Dio Padre. Che io rispetti la libertà dei miei figli è evidentemente auspicabile. Ma la loro libertà è di amarmi o no, di obbedirmi o no, di rispettarmi o no, il che presuppone... che essi sappiano almeno che esisto! Quale triste padre sarebbe colui che, per rispettare la libertà dei propri figli, rifiutasse di vivere con loro, di accompagnarli, e perfino di farsi espressamente conoscere da loro! La Rivelazione? Ma quale padre si accontenterebbe, per crescere i suoi figli, di una parola rivolta ad altri, morti da secoli, e che non sarebbe trasmessa loro che attraverso testi equivoci o dubbi? Quale padre rimanderebbe i suoi figli alla lettura delle sue opere scelte, o di quelle dei suoi discepoli (quali? la Bibbia? il Corano? le Upanishad?), piuttosto che parlar loro direttamente e stringerli al proprio cuore? Strano padre: strano Dio! E quale padre più atroce di quello che continuasse a nascondersi quando i suoi figli soffrono? Qual è quel Padre che si nasconde ad Auschwitz, che si nasconde in Ruanda, che si nasconde quando i suoi figli stanno male o hanno paura? Il Dio nascosto di Pascal o di Isaia sarebbe un cattivo padre. Come amarlo? Come crederci? L'ateismo fa un'ipotesi più verosimile. Se Dio non si vede e se non si può concepire che si nasconda, è forse perché semplicemente non esiste...
Il secondo argomento è ugualmente negativo, ma questa volta più teorico che empirico, se così si può dire. La principale forza di Dio, per il pensiero, è di spiegare il mondo, la vita, il pensiero stesso... Ma che valore ha questa spiegazione, dal momento che Dio, se esiste, è per definizione inspiegabile? Che la religione sia una credenza possibile, non lo nego. Che essa sia rispettabile, è ovvio. Ma mi interrogo sul suo contenuto di pensiero. Una religione cos'altro è se non una dottrina che spiega qualcosa che non si comprende (l'esistenza dell'universo, della vita, del pensiero...) per mezzo di qualcosa che si comprende ancor meno (Dio)? E che valore può avere, da un punto di vista razionale, questa spiegazione? È «l'asilo dell'ignoranza», come diceva Spinoza, e temo che questo valga anche per il suo proprio Dio. «Dio, cioè una sostanza costituita da un'infinità di attributi di cui ciascuno esprime un'essenza eterna e infinita, esiste necessariamente». Questo è ciò che si legge nell'Etica. Ma cosa sappiamo noi di un tale Dio e di questa infinità di attributi infiniti? Niente, se non ciò che ci assomiglia o ci attraversa (l'estensione, il pensiero), che non fa un Dio. Ma allora, perché crederci? E Freud ad aver ragione qui: «L'ignoranza è l'ignoranza; non potrebbe derivarne nessun diritto a credere qualcosa». O meglio, si ha il diritto di credere, ma questo non potrebbe sostituire la conoscenza. Onore al pirronismo. L'ignoranza non potrebbe giustificare alcuna fede, né la ragione, trattandosi di Dio, sopprimere l'ignoranza.
Ma allora, spiegare qualsiasi cosa per mezzo di Dio (e a fortiori pretendere di spiegare tutto!) significa non spiegare niente del tutto, e sostituire un'ignoranza con un'altra. A che pro?
«Non sono ateo – mi dice un amico: – credo che vi sia un mistero...» Oh bella! Per essere atei bisognerebbe non riconoscerlo? Bisognerebbe pretendere di sapere tutto, di comprendere tutto, di spiegare tutto? Questo non sarebbe più ateismo ma scientismo, cecità, stupidità. Quand'anche si potesse spiegare tutto nell'universo, e ce ne manca, resterebbe da spiegare l'universo stesso, cosa impossibile. Poi resterebbe da giudicare, agire, amare, vivere, ciò per cui nessuna scienza potrebbe bastare. Essere atei non dispensa dall'essere intelligenti e lucidi. Questo è ciò che distingue l'ateismo dallo scientismo, che sarebbe un ateismo ottuso. Lo scientismo è una religione della scienza: non è l'essenza dell'ateismo, del materialismo o del razionalismo; è la loro fossilizzazione dogmatica e religiosa. Diciamo che è la religione dei non credenti: tale libero pensiero è quasi sempre il contrario di un pensiero libero!
Che le scienze non spieghino tutto, che la ragione non spieghi tutto, è un fatto evidente. Ci sono l'ignoto, l'incomprensibile, il mistero, e ci saranno sempre. Gli scientisti hanno sicuramente torto a negarlo. Ma con quale diritto i credenti vorrebbero appropriarsi di questo mistero, riservarlo per sé, farne una propria specialità? Che vi sia del mistero non dà ragione alla religione né torto alla ragione! Dà torto al dogmatismo, a ogni dogmatismo, che sia religioso o razionalista. Per questo dà torto in particolare alle religioni, che non esistono se non per i loro dogmi. Uno scienziato non ha bisogno di adorare la scienza. Ma cosa sarebbe un credente che non adorasse il suo Dio?
Essere atei non significa rifiutare il mistero; significa rifiutare di sbarazzarsene o di ridurlo a una cosa di poco conto, per mezzo di un atto di fede o di sottomissione. Non significa spiegare tutto, ma rifiutare di spiegare tutto facendo ricorso all'inspiegabile.
Credere in Dio, al contrario, non significa aggiungere mistero al mondo; significa aggiungere un nome (fosse anche impronunciabile) a questo mistero, e ricondurlo, molto tranquillamente, molto miseramente, a una storia di potere o di famiglia, di alleanza o d'amore... Dio onnipotente, Dio creatore, Dio giudice e misericordioso – «Padre nostro, che sei nei cieli...» Questo spiega tutto, ma per mezzo di qualcosa che non si spiega. Dunque non spiega niente; non fa che spostare il mistero – quasi sempre dalla parte dell'antropomorfismo. «In principio, Dio creò il cielo e la terra, poi l'uomo, a sua immagine...» Significa spiegare l'universo, che ci contiene,per mezzo di qualcosa che ci assomiglia, o di qualcuno a cui assomigliamo. «Se Dio ci ha fatti a sua immagine – scriveva Voltaire, – noi lo abbiamo ben ricambiato». Psicologicamente, cosa vi è di più comprensibile? Filosoficamente, cosa di più dubbio? L'universo è più misterioso della Bibbia o del Corano. Come potrebbero questi libri, che esso contiene, spiegarlo?
Il più piccolo fiore rappresenta un mistero insondabile. Ma perché dovremmo volere che questo mistero si risolva nella fede?
L'essenziale ci è ignoto. Ma perché dovremmo volere che l'ignoto sia Dio?
Gli altri tre argomenti sono invece positivi. Il primo è insieme il più banale e il più forte: è l'argomento del male. Ci sono nel mondo troppi orrori, troppe sofferenze, troppe ingiustizie, perché si possa credere facilmente che sia stato creato da un Dio assolutamente buono e onnipotente.
L'aporia è ben nota, fin dai tempi di Epicuro o Lattanzio: o Dio vuole eliminare il male e non può, ma allora non è onnipotente; oppure potrebbe e non lo vuole, ma allora non è perfettamente buono... Ora, se non è l'una e l'altra cosa (e a fortiori se non è né l'una né l'altra: se non vuole né può sopprimere il male), è ancora un Dio? Questo è il problema di ogni teodicea, come lo formula Leibniz: «Se Dio esiste, da dove viene il male? Se non esiste, da dove viene il bene?» Ma il male rappresenta un'obiezione più forte, contro la fede, di quanto lo faccia il bene contro l'ateismo. Questo perché è più incontestabile, più illimitato, più irriducibile. Un bambino ride? Non c'è affatto bisogno di un Dio per spiegarlo. Ma quando un bambino muore, quando un bambino soffre atrocemente? Chi oserebbe, davanti a questo bambino, davanti alla madre, celebrare la grandezza di Dio e le meraviglie della sua creazione? Ora, quanti bambini soffrono atrocemente, in ogni istante, in qualche parte del mondo?
I credenti ribatteranno che, di questi orrori, è spesso responsabile l'uomo... Certo. Ma non è causa di tutti, né di se stesso. La libertà non spiega tutto. Il peccato non spiega tutto. Si pensi alla pesante battuta di Diderot: «Il Dio dei cristiani è un padre che tiene in gran conto le sue mele e in molto poco conto i suoi figli». Ciò vale anche contro il Dio degli ebrei o dei musulmani. Vale contro ogni presunto Dio d'amore e di misericordia – e come potrebbe Dio essere altrimenti? Perché, di nuovo, accettare da lui ciò che non tollereremmo da alcun padre? Mi è capitato di trascorrere parecchie ore nel reparto di pediatria di un grande ospedale parigino. E un'esperienza che dà un'idea piuttosto alta dell'uomo. E una piuttosto bassa di Dio, se esistesse. «La sofferenza dei bambini – scrive a buon diritto Marcel Conche – è un male assoluto», che basta a rendere impossibile ogni teodicea. Quante atrocità che nessuna colpa potrebbe spiegare o giustificare? Quante sofferenze precedono il primo peccato? Quanti orrori, poi, prima che esistesse l'umanità? Che Dio è quello che abbandona le gazzelle alle tigri e i bambini al cancro?
Il secondo argomento è più soggettivo, e lo do per tale. Non ho un'idea abbastanza alta dell'umanità in generale e di me stesso in particolare per immaginare che un Dio ci abbia potuti creare. Ciò costituirebbe una ben grande causa per un così piccolo effetto! Troppa mediocrità ovunque, troppa bassezza, troppa miseria, come dice Pascal, e troppo poca grandezza.
Non che convenga esagerare su questo terreno. Ogni misantropia è ingiusta: significa fare come se non esistessero gli eroi, la brava gente, e per questo dar ragione, molto stupidamente, ai malvagi e ai vili. Ma alla fine anche gli eroi hanno le loro piccolezze, che li rendono umani, come le brave persone hanno le proprie debolezze. Né gli uni né gli altri hanno bisogno di un Dio per esistere o per essere concepibili. Basta il coraggio. Basta la gentilezza. Basta l'umanità. E quale Dio, al contrario, per giustificare l'odio, la violenza, la viltà, la stupidità, che sono innumerevoli? Lasciamo da parte i mostri o le carogne. La semplice conoscenza di sé, come ha capito Bergson, spinge a compatire o a disprezzare l'uomo, più che ad ammirarlo. Troppo egoismo, vanità, paura. Troppo poco coraggio e generosità. Troppo amor proprio, troppo poco amore. L'umanità rappresenta una creazione talmente insignificante. Come avrebbe potuto un Dio volere questo?
C'è del narcisismo nella religione, in ogni religione (se Dio mi ha creato, significa che ne valeva la pena!), ed è una ragione per essere atei: credere in Dio sarebbe un peccato d'orgoglio.
L'ateismo, al contrario, è una forma di umiltà. Equivale a considerarci animali, quali in effetti siamo, e a lasciarci il compito di diventare umani. Si obietterà che questo compito è Dio che ce l'ha affidato, per permetterci di protrarre, a nostra misura, la sua creazione... Forse. Ma la responsabilità è troppo pesante e la misura troppo stretta perché la risposta mi possa soddisfare. La natura, per i piccoli esseri che noi siamo, mi sembra una causa più plausibile.
Il terzo argomento positivo può sorprendere maggiormente. Se non credo in Dio è anche, e forse soprattutto, perché preferirei che esistesse. E la scommessa di Pascal, se vogliamo, ma invertita. Non si tratta di pensare ciò che è più vantaggioso – il pensiero non è né un commercio né una lotteria – ma ciò che è più verosimile. Ora, Dio è tanto meno verosimile, mi sembra, quanto più è desiderabile: corrisponde talmente bene ai nostri desideri più forti che c'è spazio per chiedersi se non l'abbiamo inventato per questo.
Cosa desideriamo più di tutto? Non morire, ritrovare le persone care che abbiamo perduto, essere amati... E cosa ci dice, per esempio, la religione cristiana? Che non moriremo, o non veramente, o che resusciteremo; che ritroveremo di conseguenza le persone care che abbiamo perduto; che siamo, infine, amati fin d'ora di un amore infinito... Cosa chiedere di più? Niente, certo, ed è ciò che rende la religione improbabile! Per quale miracolo il reale, che non è solito farlo, corrisponderebbe a tal punto ai nostri desideri? Ciò non prova che Dio non esiste – poiché sarebbe, per definizione, colui che rende i miracoli possibili – ma spinge a chiedersi se Dio non sia troppo bello per essere vero, se credere in lui non significhi scambiare i propri desideri per la realtà, insomma se la religione non sia semplicemente un'illusione, nel senso che Freud dà a questo termine: non necessariamente un errore (potrebbe darsi, ripetiamolo, che Dio esista), ma «una credenza derivata dai desideri umani». Questo, senza confutarla, la indebolisce. «Sarebbe certo molto bello – scrive Freud – che ci fosse un Dio creatore del mondo e una Provvidenza piena di bontà, un ordine morale dell'universo e una vita futura, ma è tuttavia molto curioso che tutto questo sia esattamente ciò che potremmo augurare a noi stessi». Credere in Dio è credere a Babbo Natale, ma alla millesima potenza, anzi infinita. È darsi un Padre sostitutivo, che ci consolerebbe dell'altro o della sua perdita, che sarebbe la vera Legge, il vero Amore, la vera Potenza, che accetterebbe infine di amarci come siamo, di soddisfarci, di appagarci, di salvarci... Che si possa desiderarlo, lo capisco fin troppo bene. Ma perché bisognerebbe crederci? «La fede salva – diceva Nietzsche, – dunque mente». Diciamo che essa ci fa troppo comodo per non essere sospetta.
Immagina che io ti dica: «Sto cercando di acquistare un appartamento di sei vani, a Parigi, dietro il Luxembourg, con vista assicurata sul parco... Non vorrei spenderci più di centomila franchi; ma ho fiducia, ci credo!». Verosimilmente ti diresti: «Si fa delle illusioni; scambia il suo desiderio per la realtà...» Avresti evidentemente ragione (per quanto ciò, a rigore, non provi niente: chi può sapere se mi imbatterò in un venditore folle?) E quando ti si dice che Dio esiste, che noi resusciteremo ecc., non trovi questo più incredibile di un sei vani dietro il Luxembourg per meno di centomila franchi? Significa che hai un'opinione di Dio ben piccola, o una ben grande del settore immobiliare.
La posizione dell'ateo, al contrario, è tanto più forte in quanto il più delle volte preferirebbe avere torto. Ciò non prova che abbia ragione, ma lo rende meno sospetto di pensare, come tanti altri, solo per consolarsi o per rassicurarsi...
Mi fermo qui. Volevo solo suggerire qualche argomento possibile. A ognuno di valutarne la forza e i limiti. Che Dio esista è una possibilità che non si può razionalmente escludere. Questo fa dell'ateismo ciò che è: non un sapere, ma una credenza, ripetiamolo, non una certezza ma una scommessa.
È anche ciò che deve spingerci tutti alla tolleranza. Atei e credenti sono divisi solo da ciò che ignorano. Come potrebbe questo contare di più di ciò che conoscono: una certa esperienza della vita, dell'amore, dell'umanità sofferente e degna, malgrado la sua miseria, dell'umanità sofferente e coraggiosa? È ciò che chiamo la fedeltà, che deve riunire coloro le cui rispettive fedi o non fedi rischierebbero altrimenti di opporre. Sarebbe folle uccidersi l'un l'altro per ciò che si ignora. E meglio battersi, insieme, per ciò che conosciamo o riconosciamo: una certa idea dell'uomo e della civiltà, un certo modo di abitare il mondo e il mistero (perché c'è qualcosa piuttosto che niente?), una certa esperienza dell'amore e della compassione, una certa esigenza dello spirito... Questo è ciò che possiamo chiamare l'umanesimo, che non è una religione ma una morale. Fedeltà all'uomo e all'umanità dell'uomo.
Ciò non sostituisce alcun Dio. Ciò non sopprime alcun Dio. Ma nessuna religione o ateismo potrebbe essere, senza questa fedeltà, umanamente accettabile.
(Da: Discorsi brevi sui grandi temi della filosofia, Angelo Colla 2010, pp. 81-91)













































