La guida alla preghiera
nel Vangelo
secondo Luca
Anselm Grün
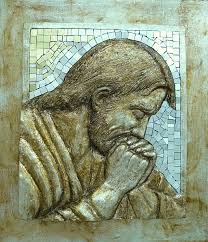
Più di ogni altro evangelista, Luca ha posto la preghiera al centro del suo Vangelo, da una parte descrivendo Gesù che prega e dall'altra offrendo in due capitoli una sua personale guida alla preghiera, in cui si sofferma in particolare sull'atteggiamento che il cristiano deve assumere pregando.
Per Luca la preghiera è il luogo in cui possiamo incontrare e comprendere Gesù Cristo. La natura di Gesù e il suo atteggiamento verso il Padre, infatti, si evidenziano soprattutto nel suo modo di pregare. Imparando da lui a pregare, riconosciamo chi è per noi Gesù Cristo. E al tempo stesso la preghiera è il modo per diventare sempre più simili a lui, instaurando così un rapporto con Dio. La preghiera è il luogo in cui lo spirito di Gesù ci tocca e sana le nostre ferite.
GESÙ CHE PREGA
Nessun evangelista [come Luca, ndr] descrive così tante scene nelle quali incontriamo Gesù che prega. Per Luca Gesù è il grande orante: affronta pregando gli eventi più importanti della sua vita. Prega prima delle decisioni e si ritira spesso in luoghi solitari per pregare il Padre.
Quando Luca descrive Gesù che prega, ha sempre in mente il cristiano credente. Per lui la preghiera è soprattutto un modo per superare le difficoltà della vita. Come Gesù affronta pregando la sua passione, così il cristiano nella preghiera deve aggrapparsi a Dio, in modo da arrivare alla gloria attraverso tutte le difficoltà. La preghiera è il mezzo per esercitarsi nell'atteggiamento di Gesù ed essere pervasi dal suo spirito.
Se, sulla falsariga del Vangelo secondo Luca, descrivo ora le situazioni più importanti in cui Gesù prega, ottengo una sorta di «scuola di preghiera» alla quale Gesù ci ammette, insegnandoci a pregare con il suo esempio. Con le scene in cui Gesù prega, d'altro canto, Luca ci vuole anche dimostrare l'effetto che la preghiera può avere. Luca dipinge con le parole. I suoi racconti delle preghiere di Gesù sono immagini di ciò che può accadere anche a noi quando preghiamo.
L'evangelista Luca è il solo a raccontarci che Gesù ha pregato in occasione del suo battesimo: «Mentre (...) Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: "Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento"» (Lc 3,2122). E una bella immagine per descrivere l'effetto della preghiera. Quando preghiamo, il cielo si apre sopra di noi. Nella preghiera lo Spirito Santo discende su di noi e ci dà forza per ciò che ci aspetta. E nella preghiera sentiamo che Dio ci ama incondizionatamente. Nella preghiera riconosciamo chi siamo davvero. Nella preghiera ci sperimentiamo come figli amati da Dio e abbiamo la conferma del suo amore incondizionato.
Quando ebbe guarito i lebbrosi e la gente accorreva a lui da ogni parte, Gesù «si ritirava in luoghi deserti a pregare» (Lc 5,16). La preghiera è anche uno spazio protetto e appartato nel quale possiamo trovare riparo dal frastuono del mondo e dalle aspettative degli uomini. Come Gesù, anche noi dobbiamo godere della preghiera come di un luogo nel quale siamo soli con Dio. La preghiera ci libera dalla pressione di essere sempre efficienti e attivi. Ci mostra dove dare e dove prendere. Incontrando Dio nella preghiera ci prendiamo il tempo per rientrare in contatto con noi stessi. Se non preghiamo, corriamo il rischio di dare fondo a tutte le nostre energie.
Prima di scegliere i dodici apostoli tra i suoi discepoli, Gesù «se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio» (Lc 6,12).
La preghiera ci mette in grado di prendere le decisioni giuste. Prima di situazioni, colloqui o decisioni importanti, la preghiera ci potrebbe aiutare a trovare la calma e a vederci più chiaro. Nella preghiera vediamo le decisioni in un contesto più ampio. Le presentiamo a Dio e ci fidiamo della sensazione che affiora in noi nella preghiera: una sensazione di tranquillità e concordia.
Prima della confessione di Pietro, Gesù prega in un luogo appartato (cfr. Lc 9,18). Soltanto dopo aver pregato pone ai discepoli la domanda decisiva: chi è lui secondo loro? Nella preghiera giungiamo alle domande da cui dipende tutto. Ma per Gesù la preghiera è anche una adeguata preparazione per introdurre i suoi discepoli al mistero della sua passione e al modo di seguirlo sulla via della croce. Dopo aver pregato spiega loro che chi vuole essere suo discepolo deve rinnegare se stesso e prendere ogni giorno la sua croce.
Luca è il solo a raccontare della preghiera di Gesù prima della sua trasfigurazione. «Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante» (Lc 9,29). Nella preghiera entriamo in contatto con il nostro vero essere e tutto ciò che è superficiale scompare. Cadono le maschere dietro le quali ci nascondiamo. Trasfigurazione significa che traspare ciò che è genuino: la nostra bellezza originaria. Lo splendore di Dio che è in noi emana dal nostro volto. Riconosciamo di essere la gloria di Dio.
Quando Gesù si trasfigura, compaiono Mosè ed Elia. Mosè è colui che dà la legge e libera: quando preghiamo, nella nostra vita si fa ordine e sperimentiamo in Dio la vera libertà. Ciò che pensa di noi la gente non ha più importanza. Elia è il profeta: nella preghiera scopriamo la nostra missione profetica. Intuiamo di poter esprimere con la nostra vita qualcosa che può evidenziarsi in questo mondo soltanto per nostro tramite. Nella preghiera – ci dice il racconto della trasfigurazione di Gesù – entriamo in contatto con il nostro vero io, la gloria di Dio risplende in noi.
Tuttavia questa esperienza non la si può trattenere, ma scompare ogni volta. Una nube oscura il nostro sguardo e dobbiamo tornare nella valle spesso nebbiosa del nostro vivere quotidiano, conservando soltanto il ricordo di questa esperienza di luce.
Il culmine della preghiera di Gesù, Luca ce lo racconta nella passione. Mentre Gesù prega sul Monte degli ulivi lottando con la volontà di Dio, un angelo del cielo gli appare a rinfrancarlo. La preghiera non è sempre solo un'esperienza di pace. Può essere anche una lotta dolorosa per accettare la volontà di Dio, il quale però manda a chi prega il suo angelo per dargli nuova forza. L'angelo non risparmia la paura di morire a Gesù, che anzi suda per il terrore. Ma proprio per questo prega ancora più intensamente (cfr. Lc 22,44).
Luca racconta questa scena della preghiera sul Monte degli ulivi sullo sfondo delle difficoltà che molti, oggi come allora, hanno con la preghiera. Pregando, spesso avvertiamo il buio. Abbiamo l'impressione che le nostre suppliche cadano nel vuoto. Ci appaiono vane. Dio sembra nascondersi, in silenzio, dietro uno spesso muro. Poiché non riusciamo ad arrivare a Dio, spesso ci stanchiamo, come i discepoli. Ci addormentiamo e così pure la nostra preghiera. E Gesù ci deve svegliare: «Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione» (Lc 22,46).
Soffriamo delle stesse pene di Gesù: solitudine, paura, abbandono, disperazione e sofferenza. La preghiera è per noi un modo di resistere, come Gesù, alla tentazione e di aggrapparci a Dio anche nei momenti più difficili.
A quanto pare, la preghiera sul Monte degli ulivi dà a Gesù la forza di intraprendere la via della passione. Gli dona la fiducia di non cadere dalle mani buone di Dio neppure nella morte. La preghiera di Gesù culmina con l'invocazione sulla croce. Là Gesù non prega solo per sé ma anche per i suoi assassini: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). Se preghiamo per le persone che ci hanno ferito, non dobbiamo costringerci a perdonarle. Tuttavia, pregando per loro, l'atteggiamento del perdono nasce spontaneo in noi. Affidiamo l'altro alla misericordia divina e così facendo possiamo accostarci a lui in modo diverso.
Gesù muore con una preghiera sulle labbra. È un versetto del Salmo 31, la preghiera serale ebraica. Nello stesso momento in cui gli ebrei osservanti pronunciano il Salmo 31: «Alle tue mani affido il mio spirito», Gesù sulla croce pronuncia le stesse parole, aggiungendovi però la parola «Padre» (cfr. Lc 23,46). Anche in punto di morte si rivolge in termini affettuosi al Padre come al genitore e consegna il suo spirito nelle mani amorevoli di suo Padre, da cui morendo ritorna. La preghiera trasfigura la sua morte.
Nonostante le atrocità patite, Gesù continua a pregare e rimane così in contatto con Dio pur nella sofferenza estrema. Anzi, il rapporto con Dio lo libera dal potere degli uomini. Nemmeno i suoi assassini possono trionfare su di lui. La preghiera lo eleva in un altro mondo, dove le grida dei suoi carnefici non possono arrivare.
La preghiera accompagna Gesù dall'inizio del suo operato fino alla sua morte sulla croce. Ciò dimostra da dove traeva il suo vero sostegno. E rivela che Gesù, per la forza datagli dalla preghiera, può percorrere il suo cammino anche attraverso le più grandi difficoltà, perché sopra a tutta la sofferenza il cielo è aperto e lui sa di essere una cosa sola con il Padre.
Anche la nostra preghiera culmina alla fine con l'abbandono nelle mani amorevoli di Dio. Ogni sera ci lasciamo cadere nelle sue mani buone, esercitandoci a morire. Nella morte non finiamo in una terribile oscurità, bensì andiamo tra le braccia amorevoli di Dio. La preghiera è l'esercizio a rifugiarsi continuamente nelle mani di Dio, anche nella solitudine, nelle difficoltà e nella morte. Con il versetto «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» Luca descrive che cosa significhi da ultimo l'invocazione del Padre nostro «Sia fatta la tua volontà» che compare in Matteo. Per Luca cedere alla volontà di Dio ha un che di affettuoso: mi affido alle mani buone di Dio. Ho la certezza di essere protetto, sorretto e al sicuro nelle mani affettuose di Dio. La scuola della preghiera alla quale Gesù ci ammette nel Vangelo secondo Luca è una scuola dell'esempio. Nella preghiera di Gesù possiamo imparare a rivolgerci al Padre fiduciosi quanto lui.
Inoltre Luca raccoglie in due capitoli separati parole e parabole di Gesù nelle quali ci viene spiegato l'atteggiamento da tenere nella preghiera. All'inizio del racconto in cui Luca ci descrive le peregrinazioni di Gesù, questi ci indica Dio come un amico e un padre al quale rivolgere fiduciosi le nostre preghiere (cfr. Lc 11,1-13). E alla fine dei suoi spostamenti, poco prima della sua passione, Gesù spiega in due parabole quando la preghiera riesce o non riesce, mostrandocela come un modo per ritrovare la fiducia e sentirci aiutati nei momenti difficili della nostra vita (cfr. Lc 18,1-8; 18,9-14).
PREGARE FIDUCIOSI DIO COME AMICO E PADRE
Subito dopo aver soddisfatto con il Padre nostro la richiesta dei discepoli («Signore, insegnaci a pregare»), Gesù racconta loro due parabole, che trattano entrambe della fiducia con la quale i discepoli devono pronunciare le parole della preghiera del Signore.
La parabola dell'amico che supplica (Lc 11,5-8) tiene conto della vita in un villaggio palestinese, dove non esistono negozi e ogni famiglia produce da sé il cibo di cui necessita. In questo villaggio un uomo riceve una visita nel cuore della notte e non ha nulla da offrire al suo ospite. È in imbarazzo, perché in Oriente l'ospitalità è sacra. Così va dal suo amico e bussa alla porta. Sa di metterlo in difficoltà, perché lo costringe ad alzarsi e ad aprire la porta sprangata. Il rumore sveglierà i bambini. Tuttavia l'ospitalità è un dovere sacrosanto. Perciò l'altro si alza e dà all'amico tutto quello di cui ha bisogno.
Con questa parabola Gesù vuole dirci che Dio è nostro amico. E Luca la interpreta secondo la filosofia greca: noi cristiani siamo amici di Dio [1].
Pregare significa rivolgersi a Dio come a un amico. Possiamo supplicarlo spudoratamente come faremmo con un amico. E Dio non ci rifiuterà nulla perché l'amicizia tra lui e noi è ancora più salda che tra gli uomini. Il mistero dell'amicizia ci si rivela quando nella preghiera sperimentiamo Dio come un nostro amico che ci dà ciò di cui abbiamo bisogno per vivere e per amare.
Nel Vangelo secondo Luca Gesù spiega la fiducia incondizionata che possiamo nutrire nei confronti di Dio con le parole: «Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto» (Lc 11,9-10).
Con queste poche parole incisive Gesù ci invita a chiedere anche nelle situazioni disperate, a cercare e a «bussare» presso Dio. Lui ci aprirà il suo cuore e ci darà ciò di cui necessitiamo. Talvolta il dono di Dio sarà diverso da come ce l'eravamo immaginato, ma nessuna preghiera è vana perché rafforza il rapporto con Dio come nostro amico. E Dio, alla fine, ci darà sempre ciò che nel profondo del nostro cuore ci serve per vivere.
Dopo questa esortazione a pregare con fiducia, Gesù domanda come si comporterebbe un padre umano con il proprio figlio: «Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un [pane, gli darà una pietra?] O se gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!» (Le 11,11-13; nella nuova versione la richiesta del pane è stata omessa).
In questi tre esempi Gesù spiega che cosa significhi avere Dio per padre. Ogni padre sa ciò che va bene per i suoi figli. E anche se questi spesso sono cattivi, è difficile che un padre riesca a essere davvero duro con loro, anche perché nel suo cuore sa esattamente di che cosa hanno bisogno. Perciò non gli darà una pietra al posto del pane, o una serpe invece di un pesce o uno scorpione anziché un uovo. Gesù si appella qui all'amor proprio degli uomini. «A leggere questi esempi attribuiti a un padre, il lettore o la lettrice provano un tuffo al cuore» [2].
Dio è il nostro buon Padre. Sa che cosa ci fa bene. Non ci deluderà né ci darà niente che possa nuocerci. Ci dona ciò che ci nutre. Agostino dà un'interpretazione simbolica dei tre doni. Il pane indica l'amore, il pesce la fede e l'uovo la speranza.
Un buon padre non dà al figlio la pietra della durezza e del rifiuto anziché il pane dell'amore. Crede nel figlio e non lo ferisce con una serpe. Gli dona la speranza e non lo avvelena con lo scorpione dell'amarezza o dei sensi di colpa. Dio è il buon Padre che ci regala la cosa migliore che ha: lo Spirito Santo. Nello Spirito Santo ci dona se stesso e ci è vicino.
Lo Spirito Santo sana le ferite inferteci da un padre che ci ha effettivamente dato una pietra, una serpe o uno scorpione, ferendoci profondamente. Per Luca la preghiera è il luogo in cui possiamo sperimentare la guarigione delle ferite inferteci dai nostri genitori. E al tempo stesso ci mostra cosa significhi pregare Dio come nostro padre. Questo padre ci tratterà bene. Ci darà ciò di cui abbiamo bisogno per vivere: la fede, la speranza e l'amore. Nello Spirito Santo ci dà tutto quello che serve alla vita.
La teologia di Luca è diversa. Dopo la sua risurrezione Gesù ci manda lo Spirito Santo. E in forza dello Spirito Santo gli apostoli possono fare ciò che faceva Gesù. Stefano, come Gesù, perdona i suoi assassini. Pietro e Giovanni guariscono gli storpi grazie alla forza conferitagli da Gesù. E Paolo, come Gesù, sopporta fiducioso la sofferenza che gli è toccata.
Nella preghiera siamo colmati dello spirito di Gesù. E in forza di questo spirito diventiamo capaci di seguirlo e, come lui, di guarire i malati, di perdonare chi ci fa del male e di giungere, attraverso le afflizioni di questo mondo, alla gloria di Dio. Lo Spirito Santo fa sì che ciò che ci capita in questo mondo non ci spezzi, ma ci apra all'immagine originaria e incontaminata che Dio si è fatto di noi quali suoi figli.
LA PREGHIERA DETTATA DA UNO STATO DI BISOGNO
Nel diciottesimo capitolo del suo Vangelo Luca riprende ancora una volta le sue istruzioni su/ modo giusto di pregare narrando due parabole: la parabola della vedova e del giudice disonesto e la parabola del pubblicano che prega nel tempio.
Nell'undicesimo capitolo del suo Vangelo Luca ha interpretato la preghiera come compimento dell'amore di Dio. Perciò ha sviluppato la sua dottrina della preghiera subito dopo la storia di Marta e Maria. Nella preghiera diventiamo Maria, che si siede ai piedi di Gesù e si lascia istruire da lui nel mistero della contemplazione e nell'arte della giusta preghiera. Nel diciottesimo capitolo, invece, Gesù ha presente i problemi degli uomini. Nei conflitti del vivere quotidiano dobbiamo pregare fiduciosi Dio. Dio è colui che rimane al nostro fianco anche quando gli uomini ci lasciano soli.
La donna che, in quanto vedova, è oppressa da un avversario (cfr. Lc 18,1-8) rappresenta la comunità cristiana alla fine del I secolo che, minacciata, si appella invano alle autorità statali. Il giudice, al quale la vedova si rivolge, non teme Dio né ha riguardo per nessuno.
Alla fine del I secolo non era ancora iniziata una persecuzione generalizzata, ma per i cristiani tirava una brutta aria. Le autorità non li proteggevano dagli attacchi ostili, anzi spesso operavano contro di loro. In questa situazione – pensa Luca – la comunità deve rifugiarsi nella preghiera. Così potrà sperimentare il proprio diritto di esistere. In questo senso la parabola è attuale anche oggi, perché anche adesso il mondo è spesso ostile a noi cristiani. I media evidenziano sovente i difetti della Chiesa o la attaccano. Invece di pensare di doversi sempre difendere, la Chiesa dovrebbe anche oggi sperimentare la sua vera identità nella preghiera. Allora questi attacchi o altri simili perderanno il loro potere e non potranno più minare l'identità dei cristiani.
La vedova che si rivolge al giudice può però anche rappresentare un singolo individuo e quindi la situazione personale di chi è pressato dai nemici, è stato ferito dagli altri e non è in grado di difendersi. La donna che ha perso il marito è l'immagine di quelle persone che hanno la «scorza tenera» e sono quindi esposte alle emozioni del loro ambiente. Non hanno barriere difensive. Tutti gli aspetti negativi del mondo che le circonda penetrano in loro.
Anche questa seconda interpretazione è utile. Proprio chi si sente ferito o perseguitato dagli altri può trovare riparo nella preghiera. Nella vicinanza a Dio sperimenta il diritto di vivere. E nella preghiera scopre in sé il luogo dove Dio dimora. Là nessuno può fargli del male. Là può rinascere.
Un'altra possibile interpretazione di questa parabola è quella che gli psicologi chiamano interpretazione a livello soggettivo. Come i sogni, anche le parabole si possono interpretare a livello soggettivo. Ciò significa che tutti i personaggi raffigurano sfere diverse presenti in noi stessi.
La donna simboleggia quindi l'anima, la sfera interiore dell'uomo e ciò che intuiamo della sua dignità divina. L'avversario rappresenta il modello esistenziale che ci impedisce di vivere, le nostre debolezze che ci danno tanti problemi, e le ferite che la vita ci ha inferto. Il giudice, che non ha riguardo né per Dio né per gli uomini, simboleggia il Super-Io, l'istanza interiore, che vorrebbe frenarci e non si cura affatto del nostro benessere, ma solo di norme e principi. L'anima deve stare zitta e accontentarsi di quello che trova.
In questo modo di vedere, la preghiera è quella che rende giustizia all'anima. Conferma ciò che intuiamo della nostra dignità inviolabile e della nostra unicità. La preghiera mette a tacere le voci assordanti del Super-Io e del modello di vita avverso.
La donna apparentemente impotente combatte per se stessa. Continua a tornare dal giudice per incalzarlo: «Fammi giustizia contro il mio avversario» (Lc 18,3). In risposta il giudice ragiona tra sé con un monologo tipico della commedia greca: "Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi" (Lc 18,5).
L'originale greco andrebbe tradotto letteralmente: «Perché alla fine non mi faccia un occhio nero» [3]. L'ascoltatore potrà sorridere divertito all'idea di un giudice potente che ha paura di una debole vedova e teme che questa gli faccia un occhio nero, tuttavia proprio con il monologo del giudice Luca induce il lettore a fidarsi del mezzo così apparentemente debole della preghiera, che ha invece più potere di tutti i potenti. Nella preghiera l'uomo ottiene giustizia; gli viene riconosciuto il diritto alla vita, all'assistenza, alla dignità. Nella preghiera possiamo sperimentare che gli uomini non hanno più alcun potere su di noi.
Se consideriamo la vedova un simbolo dell'anima, ciò significa che nella preghiera sperimentiamo che l'anima ha più diritto delle voci del Super-Io che ci vogliono frenare. Nella preghiera l'anima fiorisce e mette, per così dire, le ali. Nella preghiera entriamo in contatto con il nostro vero io, con l'immagine originaria che Dio ha pensato per noi, con lo splendore che Dio ci ha dato. Questa immagine di Dio nella nostra anima il mondo non la può offuscare né distruggere.
I PERICOLI DELLA PREGHIERA
Dopo la parabola che parla di una donna, Luca fa l'esempio di un uomo che prega. Ciò è tipico di Luca, il quale è convinto che si possa parlare nel modo giusto del nostro rapporto con Dio e di Dio come padre e madre soltanto se lo si fa dal punto di vista tanto maschile quanto femminile. Per la donna pone l'accento sul fatto di lottare senza arrendersi, per l'uomo sull'umiltà. Conosce i pericoli della spiritualità maschile e femminile. La donna potrebbe a volte desistere; l'uomo, viceversa, corre il rischio di usare la preghiera per porsi al di sopra degli altri. Perciò deve imparare dal pubblicano e non rischiare, come il fariseo, di pregare per sentirsi superiore. Un simile atteggiamento non ha niente a che fare con la spiritualità, ma soltanto con il narcisismo religioso.
In questa parabola Luca ci mostra due modi di pregare: la preghiera del fariseo presuntuoso e la preghiera dell'umile pubblicano. I modi di pregare dei due sono diametralmente opposti. Per il fariseo la preparazione alla preghiera è breve. Rimane in piedi e inizia a pregare, ma in realtà non fa che parlare di sé. Usa Dio per mettersi in una buona luce. Non gli importa di Dio ma della propria presunzione. Il pubblicano invece rimane indietro, non osa alzare gli occhi e si batte il petto. Prega anche e soprattutto con il corpo.
Il testo greco dice letteralmente del fariseo che «prega se stesso». Pronuncia le parole «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini» (Lc 18,11), ma in realtà vuole soltanto tenere a Dio un lungo monologo. Il fariseo non vuole servire Dio quanto piuttosto servirsi di Dio per avere una conferma del proprio valore e per autoincensarsi. Chi prega in questo modo non alza gli occhi al cielo ma guarda solo se stesso.
Il pubblicano, viceversa, sente la sua distanza da Dio al punto che non osa neppure alzare gli occhi, ma sa di dovergli presentare la propria verità. E dinanzi a Dio riconosce chi è in realtà. Prende coscienza di aver vissuto male nei confronti di Dio e suoi propri. Perciò si batte il petto per esprimere la sua disponibilità a convertirsi e prega: «O Dio, abbi pietà di me peccatore» (Lc 18,13). Riconosce di non poter riparare a tutto il male fatto nella sua vita, perciò confida nella pietà e nella misericordia divine.
Gesù stesso commenta questi due modi di pregare: il pubblicano torna a casa giustificato dalla sua preghiera. Ha riconosciuto dinanzi a Dio la propria verità e gliel'ha presentata pieno di rimorso. Il fariseo, invece, si è servito di Dio soltanto per vantarsi. Dio però ci rinfranca e ci giustifica solo se nella preghiera ci presentiamo a lui come realmente siamo.
E poi Gesù enuncia la regola per la preghiera cristiana: «Chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato» (Lc 18,14). Chi usa la preghiera per innalzarsi al di sopra degli altri è costretto ad affrontare i propri lati bui e a scendere in fondo al proprio cuore, dove riconosce tutta l'immondizia della propria anima. Chi però, dinanzi a Dio, ha il coraggio di calarsi nella propria umanità e gli presenta la propria verità sarà rinfrancato da Dio e, come suo figlio e figlia, potrà tornare a casa dopo la preghiera giustificato e a testa alta.
Luca spiega le parole di Gesù circa il fariseo e il pubblicano facendo seguire a questa parabola la benedizione dei bambini. In quel frangente i discepoli fanno un po' come i farisei. Respingono bruscamente quelli che portano i loro bambini a Gesù. Questi però obietta: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite; a chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come l'accoglie un bambino, non entrerà in esso» (Lc 18,16-17).
La preghiera riesce soltanto se, come il pubblicano, riconosciamo la nostra dipendenza da Dio. I bambini capiscono di avere bisogno di aiuto. Non usano per sé il regno di Dio. Riconoscono la propria impotenza e il proprio bisogno di aiuto. Perciò dobbiamo pregare il Padre con la fiducia dei bambini. Così sperimenteremo il regno di Dio e Lui regnerà in noi.
LA PREGHIERA DELLA COMUNITÀ
Per Luca la preghiera è la via maestra per imparare da Gesù. E al tempo stesso la preghiera è anche il luogo dove i cristiani possono conoscere il mistero della risurrezione. Nella preghiera possono sperimentare che Dio li rinfranca e li libera dalle catene.
È quanto ci racconta l'evangelista Luca negli Atti degli Apostoli, in cui parla venticinque volte della preghiera e descrive la Chiesa primitiva come una comunità orante che trova nella preghiera la sua identità più profonda. Esporrò quindi otto aspetti della preghiera che saltano agli occhi leggendo gli Atti degli Apostoli.
1) La comunità cristiana conosce nella preghiera il suo vero fondamento
Quando Luca descrive la comunità cristiana, la descrive sempre come una comunità orante. Dopo l'ascensione di Gesù, la comunità persiste unanime nella preghiera e attende la venuta dello Spirito Santo (cfr. At 1,14). Dopo la discesa dello Spirito Santo i primi cristiani «ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo» (At 2,46-47).
Nonostante le persecuzioni esterne e i conflitti interni, la comunità trova sostegno e protezione nella preghiera. I primi cristiani sanno che Gesù è in mezzo a loro e che Dio li sorregge. E capiscono che il regno di Dio è già venuto: giovani e vecchi, ricchi e poveri, ebrei e greci, uomini e donne sono uniti e concordi nella preghiera, che crea una comunione che supera ogni confine.
2) La preghiera come intercessione per altri
Gli apostoli pregano sempre prima di affidare qualche incarico ad altri. Pregano per i diaconi e impongono loro le mani affinché svolgano bene il loro servizio (cfr. At 6,6). E pregano per Paolo e Barnaba, prima di inviarli in altre comunità (cfr. At 13,3). Pietro e Giovanni pregano che i cristiani di Samaria ricevano lo Spirito Santo (cfr. At 8,15). E gli apostoli pregano quando qualcuno è malato o in difficoltà. La preghiera li rende capaci di guarire i malati (cfr. At 3,1) o di riportare in vita Tabità che era morta (cfr. At 9,40). La comunità prega per Pietro che è in prigione e queste preghiere fanno sì che Dio mandi un angelo a liberarlo (cfr. At 12,5).
Luca ci ripete più volte che dobbiamo pregare per gli altri. La preghiera per gli altri non sostituisce l'azione, ma la rafforza e la benedice.
La guarigione è sempre un miracolo. Sostenere con le nostre preghiere l'operato del medico o del terapeuta ci dona fiducia e speranza per gli altri. La preghiera è espressione dell'amore e dell'attaccamento agli altri. E nella preghiera possiamo sperimentare ogni volta che Dio opera su di noi anche oggi, sana le nostre ferite, spezza le nostre catene e ci libera dalla prigionia. E così la preghiera ci rende più forti per servire gli altri.
3) La preghiera come esperienza di comunione anche nel commiato e nella separazione
Luca descrive in modo commovente il commiato di Paolo dalla comunità di Efeso e Mileto. «Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano» (At 20,36-37).
Nella preghiera si accomiatano da Paolo, ma sanno anche che continueranno a essergli vicini. Questa è un'immagine meravigliosa anche per noi. Per molti è difficile accomiatarsi. Si sentono soli. La preghiera è il luogo in cui ci sentiamo vicini all'amico, all'amica, al coniuge, ai figli che vivono lontani.
Un manager che durante la settimana doveva lavorare lontano dalla famiglia mi raccontava che pregare per loro gli faceva sentire il legame profondo con i suoi cari. La preghiera è però anche il luogo in cui ci sentiamo vicini a quanti si sono accomiatati da noi nella morte. Quando pronunciamo il Padre nostro, possiamo ricordarci che i nostri cari pregavano questa preghiera ed esprimevano con queste parole la loro fede e il loro anelito. Nella preghiera ci sentiamo legati alle persone che oggi invocano queste parole in cielo, contemplando Dio.
4) La preghiera come esperienza di comunione al di là delle religioni
Luca non parla solo della preghiera dei cristiani ma anche dei pagani. Cornelio, un centurione romano, era un pagano religioso e timorato di Dio che «pregava sempre Dio» (At 10,2). Nello stesso momento in cui Cornelio prega, anche Pietro sale sulla terrazza a pregare (cfr. At 10,9). In una visione capisce che deve andare dai pagani. E quando, dopo la visione, alcuni uomini lo pregano di andare con loro, lui è pronto. La preghiera gli ha fatto conoscere la comunione con tutti gli uomini, anche con quelli che non appartengono alla religione ebraica.
Paolo ha perseguitato i cristiani. Anania apprende nella preghiera di dover andare da lui. Gli ripugna andare da un nemico, tuttavia il Signore gli dice che Paolo «sta pregando» (At 9,11). La preghiera unisce gli uomini: unisce amici e nemici, uomini di confessioni e religioni diverse. Crea comunione al di là di tutte le differenze. È il luogo in cui sperimentiamo l'ecumenismo nel senso più vero del termine: l'unione nel mondo intero al di là di tutte le differenze. Nella preghiera l'ostilità è superata. Quanto più preghiamo nello spirito di Gesù, tanto più si eliminano le barriere tra uomini e religioni.
5) La preghiera in determinati momenti
Luca ci racconta che gli apostoli si recavano al tempio a pregare secondo gli orari consueti per gli ebrei (cfr. At 3,1; 10,9). I primi cristiani avevano adottato gli orari ebraici della preghiera. La Didachè, una dottrina della preghiera degli inizi del cristianesimo, prevede che i cristiani pronuncino il Padre nostro tre volte al giorno. I monaci hanno ripreso i tempi della preghiera. Benedetto da Norcia fissa sette momenti per la preghiera: tempi sacri in cui la preghiera trasforma sempre più i monaci e li ricolma dello spirito di Cristo. Questi orari stanno a significare che il nostro tempo appartiene a Dio e che ogni ora è un'ora santa.
E la preghiera a orari fissi ci vuole indicare che, in ultima analisi, dobbiamo pregare incessantemente, come scrive Paolo nella Prima lettera ai Tessalonicesi (cfr. 1 Ts 5,17). Pregando almeno in certi orari, abbiamo la certezza che nessun giorno trascorra senza che abbiamo pregato. E ogni giorno sarà santificato dalla preghiera. I tempi regolari della preghiera trasformano tutto il tempo, che diventa per noi un tempo santo, un tempo piacevole e un tempo della grazia. Non sperimentiamo più il tempo come «chronos», come tempo che ci divora, bensì come «kairos», come il tempo che ci viene donato da Dio e in cui siamo interamente noi stessi.
6) La preghiera scuote il mondo
Luca ci racconta che la preghiera della comunità fa tremare il luogo dove si riunisce: «Quand'ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza» (At 4,31). E mentre Paolo e Sila pregano verso mezzanotte nella loro cella, un terremoto abbatte le porte della prigione e spezza le catene (cfr. At 16,25-28). La preghiera scuote le fondamenta della prigione. La preghiera non è mai priva di effetto, riesce a far tremare un luogo.
Molti cristiani hanno l'impressione che la preghiera non produca nulla. Quando pronunciano le loro invocazioni in chiesa, talvolta questo dubbio funge da alibi per la loro impotenza. Sono altri a comandare nel mondo, non i cristiani che pregano. Luca presenta un'esperienza diversa: quando preghiamo, ciò produce un effetto. Spesso non lo riconosciamo, ma ci possiamo contare.
Sovente nelle chiese in cui si prega molto si avverte un'atmosfera buona e salutare. In queste chiese chi è sensibile può sperimentare il potere terapeutico della preghiera. Può viverle come fonti di forza, luoghi dove si sa al sicuro, protetto e pervaso di nuove energie.
Se preghiamo insieme, dovremmo anche essere fiduciosi che la nostra preghiera superi i muri della chiesa per uscire nel mondo. Quando preghiamo insieme, ciò si ripercuote sul mondo, che diventa più luminoso e più caldo. Creiamo un'atmosfera che si espande. Il campo del pensiero e del sentimento umano cambia. La preghiera provoca un «terremoto» nel mondo, che non è più lo stesso.
7) La preghiera come compito precipuo dei discepoli di Gesù
Quando la comunità diventa sempre più vasta e insorgono tensioni tra ellenisti ed ebrei, gli apostoli decidono di nominare dei diaconi, adducendo come motivazione: «Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola» (At 6,4).
Gli apostoli scorgono il loro vero compito nella preghiera e nel servizio della Parola. Le due cose vanno insieme: possiamo servire la parola di Dio soltanto se nella preghiera abbiamo appreso ciò che Dio vuole veramente dirci. Possiamo divulgare la parola di Dio soltanto se nella preghiera ci immergiamo nel senso più profondo delle sue parole. La preghiera è il luogo della contemplazione, in cui facciamo silenzio e ci apriamo allo Spirito di Dio. E la preghiera è il luogo nel quale possiamo udire il sussurro di Dio.
Nell'impegno sociale per gli altri, quindi, la Chiesa e i singoli cristiani non devono mai dimenticare di accertarsi, nella preghiera, del fondamento della loro fede. Per l'evangelista Luca la preghiera è decisiva per la vita del cristiano: questi non deve dedicarsi anima e corpo al lavoro esteriore, bensì riflettere sempre su ciò che è vero e aprirsi nella preghiera al mistero di Dio e al mistero della redenzione attraverso Gesù Cristo.
Non è soltanto la comunità a trovare la propria identità nella preghiera collettiva. Anche il singolo sperimenta nella preghiera il mistero del suo essere cristiano. Essere discepolo di Gesù per Luca equivale a pregare continuamente e, nella preghiera, aprirsi a Dio e diventare tutt'uno con Gesù Cristo.
Il Padre nostro, tramandatoci da Matteo e Luca come preghiera centrale dei cristiani, è il luogo in cui dobbiamo accertarci continuamente della nostra identità e del nostro compito di cristiani. Il Padre nostro ci mostra chi siamo, chi siamo diventati per mezzo di Gesù Cristo e qual è il mistero del messaggio di Gesù e il mistero della salvezza, che Gesù Cristo ha portato e continua a portarci nella preghiera.
8) La preghiera come lode a Dio
La preghiera degli apostoli è spesso una lode a Dio (cfr. At 2,46; 10,46). In prigione Paolo e Sila non pregano per la propria liberazione, ma magnificano Dio e cantano inni di lode. Nella preghiera l'uomo rende onore a Dio, ne loda la gloria, il suo santo nome, il suo regno perché risplenda anche in questo mondo. Lodare significa dimenticare se stessi e fissare lo sguardo esclusivamente su Dio, di cui siamo le creature.
Chi ha capito che Dio è il creatore e noi le sue creature non può far altro che lodare Dio. È un concetto ripreso dalla tradizione cristiana che in versioni successive del Vangelo secondo Matteo ha aggiunto al Padre nostro un'esaltazione: «Perché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Amen». Anche se questa lode non proviene da Gesù ma si ispira a una preghiera di ringraziamento del re Davide (cfr. 1Cr 29,10-11), esprime comunque qualcosa di essenziale: la nostra preghiera è sempre anche esaltazione di Dio. Sia pure con tutte le invocazioni che possiamo rivolgere a Dio affinché ci salvi dalla nostra miseria e sani le nostre ferite, ogni preghiera dovrebbe sfociare nella lode di Dio.
Nella lode anticipiamo il soddisfacimento delle nostre invocazioni. Alle nostre suppliche nel Padre nostro rispondiamo: «Perché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Amen». Crediamo che il regno di Dio, che invochiamo, è già qui. Crediamo che Dio fa scorrere la sua potenza, la sua «dynamis», la sua energia in questo mondo, che dietro alla sua apparente lontananza ci sta già guarendo con la sua presenza e che nella profondità del cosmo la sua energia è all'opera per pervadere sempre più questo mondo con il suo Spirito. E pregando contempliamo la gloria di Dio, che è già qui – nella natura, nella bellezza dell'arte – e che risplende sul volto dell'uomo. Nella lode esprimiamo la nostra fiducia che Dio regna su questo mondo, il quale riposa tra le sue braccia materne e paterne per l'eternità. Nella preghiera partecipiamo già, pur nelle difficoltà della nostra esistenza, alla soddisfazione e alla perfezione che ci saranno donate un giorno in cielo, quando contempleremo Dio in tutto il suo splendore.
NOTE
1 Cfr. W. Grundmann, Das Evangelium nach Matthäus, p. 234.
2 E Bovon, Vangelo di Luca, vol. 2, Paideia, Brescia 2007, p. 178.
B. Heininger, Metaphorik, Erzählstruktur und szenisch-dramatische Gestaltung in den Sondergutgleichnissen bei Lukas, Münster 1991, p. 202.
(da: Il Padre nostro. Come pregarlo, come viverlo, Paoline 2010, pp. 123-158)













































