Incontro a Gesù
José A. Pagola
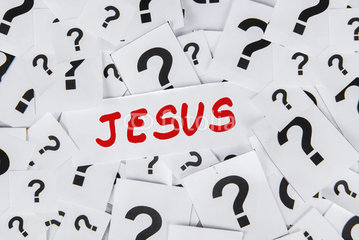
CHI DITE CHE IO SIA?
Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia; altri uno degli antichi profeti che è risorto». Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio».
Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell'uomo - disse - deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno».
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà»
(Luca 9,18-24).
Crediamo in Gesù?
Le prime generazioni cristiane conservarono il ricordo di questo episodio come di un racconto di importanza vitale per i seguaci di Gesù. Sapevano che la Chiesa di Gesù avrebbe dovuto ascoltare spesso la domanda che un giorno Gesù fece ai suoi discepoli nei dintorni di Cesarea di Filippo: «Voi, chi dite che io sia?».
Se nelle comunità cristiane lasciamo che si spenga la nostra fede in Gesù, perderemo la nostra identità. Non riusciremo a vivere con audacia creativa la missione che lui ci ha affidato; non avremo il coraggio di affrontare il futuro, aperti alla novità del suo Spirito; soffocheremo nella mediocrità. Oggi, chi è Gesù per noi?
Come Pietro, confessiamo che Gesù è il «Cristo di Dio», l'Inviato del Padre. Certamente: Dio ha amato tanto il mondo da donarci Gesù. Ma noi cristiani sappiamo accogliere, curare, gustare e celebrare questo grande dono di Dio? È Gesù il centro delle nostre celebrazioni, dei nostri incontri e delle nostre riunioni?
Lo confessiamo anche come «Figlio di Dio». Lui ci può insegnare a conoscere meglio Dio, a confidare di più nella sua bontà di Padre, ad ascoltare con più fede la sua chiamata alla costruzione di un mondo più fraterno e giusto per tutti. Stiamo scoprendo nelle nostre comunità il volto di Dio incarnato in Gesù? Sappiamo annunciarlo e comunicarlo come la grande notizia per tutti?
Chiamiamo Gesù «Salvatore», perché ha la forza di umanizzare le nostre vite, liberare le nostre persone e instradare la storia umana verso la sua salvezza definitiva. È questa la speranza che si respira tra noi? È questa la pace trasmessa dalle nostre comunità?
Confessiamo Gesù come nostro unico «Signore». Non vogliamo avere altri signori o sottometterci a falsi idoli. Ma, Gesù occupa realmente il centro delle nostre vite? Gli diamo il primato assoluto nelle nostre comunità? Lo mettiamo al di sopra di tutto e di tutti? Apparteniamo a Gesù? È lui a incoraggiarci e a farci vivere?
Oggi, il grande compito di noi cristiani è quello di aggregare le forze e aprire vie per riaffermare molto di più la centralità di Gesù nella sua Chiesa. Tutto il resto viene dopo.
Confessare con la vita
«Chi dite che io sia?». I primi tre vangeli raccolgono questa domanda rivolta da Gesù ai suoi discepoli nella regione di Cesarea di Filippo. Per i primi cristiani era molto importante ricordare spesso chi stavano seguendo, come stavano collaborando al suo progetto e per chi stavano rischiando la vita.
Quando noi ascoltiamo questa domanda oggi, tendiamo a pronunciare le formule che il cristianesimo ha progressivamente coniato nel corso dei secoli: Gesù è il Figlio di Dio fatto uomo, il Salvatore del mondo, il Redentore dell'umanità... Basta pronunciare queste parole per trasformarci in suoi «seguaci»?
Purtroppo si tratta spesso di formule apprese in età infantile, accettate in maniera meccanica, ripetute con leggerezza e affermate, più che vissute. Confessiamo Gesù per abitudine, per pietà o per disciplina, ma viviamo spesso senza cogliere l'originalità della sua vita, senza ascoltare la novità della sua chiamata, senza lasciarci attrarre dal suo progetto, senza lasciarci contagiare dalla sua libertà, senza sforzarci di seguire il corso della sua vita.
Lo adoriamo come «Dio», ma non è il centro della nostra vita. Lo confessiamo come «Signore», ma viviamo voltandogli le spalle, senza sapere molto bene come era e che cosa voleva. Gli diciamo «Maestro», ma ci comportiamo come membri di una religione, non come suoi discepoli.
Paradossalmente, l'«ortodossia» delle nostre formule dottrinali ci può infondere sicurezza, dispensandoci da un incontro più vivo con lui. Ci sono cristiani molto «ortodossi» che vivono una religiosità istintiva, ma non conoscono per esperienza cosa significhi nutrirsi di Gesù. Si sentono «proprietari» della fede, ma non conoscono il dinamismo dello Spirito di Cristo.
Non dobbiamo illuderci. Ognuno di noi deve porsi davanti a Gesù, lasciarsi guardare direttamente da lui e ascoltare dal fondo del proprio essere le sue parole: «Chi sono io veramente per voi?». A questa domanda si risponde con la vita, più che con parole sublimi.
Che ne abbiamo fatto di Gesù?
A volte è pericoloso sentirsi cristiani «da sempre», poiché si corre il rischio di non rivedere mai la nostra fede e di non capire che, in definitiva, la vita cristiana non è altro che un continuo cammino dall'incredulità alla fede nel Dio vivente di Gesù Cristo.
Spesso crediamo di avere una fede incrollabile in Gesù, perché l'abbiamo definito perfettamente con formule precise, e non ci rendiamo conto che, nella vita quotidiana, lo stiamo continuamente sfigurando con i nostri interessi e le nostre vigliaccherie.
Lo confessiamo apertamente come Dio e Signore nostro, ma a volte difficilmente significa granché negli atteggiamenti che ispirano la nostra vita. Per questo è bene ascoltare sinceramente la sua domanda: «Voi, chi dite che io sia?». In realtà, chi è Gesù per noi? Quale posto occupa nel nostro vivere quotidiano?
Quando, in momenti di vera grazia, uno si accosta sinceramente al Gesù del Vangelo, si incontra con qualcuno vivo e palpitante, con qualcuno che non è più possibile dimenticare. Uno che continua ad attrarci nonostante le nostre vigliaccherie e la nostra mediocrità.
Gesù, «il Messia di Dio», ci pone davanti alla nostra verità ultima e diventa per ognuno di noi un invito gioioso al cambiamento, alla conversione costante, alla ricerca umile ma appassionata di un mondo migliore per tutti. Gesù è pericoloso. In lui scopriamo una dedizione incondizionata ai bisognosi che mette a nudo il nostro egoismo radicale. Una passione per la giustizia che scuote le nostre sicurezze, vigliaccherie e schiavitù. Una fede nel Padre che ci invita a uscire dalla nostra incredulità e diffidenza. Gesù è la cosa più grande che abbiamo noi cristiani. Egli conferisce un altro senso e un altro orizzonte alla nostra vita. Ci trasmette un'altra lucidità e un'altra generosità. Ci comunica un altro amore e un'altra libertà. Egli è la nostra speranza.
Riorientare la vita
Non è sempre facile dare un nome allo strano disagio che a volte sentiamo in qualche momento della vita. È quanto mi hanno confessato in più di un'occasione persone che, d'altra parte, cercavano «qualcosa di diverso», una nuova luce, forse un'esperienza capace di dare un senso nuovo al loro vivere quotidiano.
Possiamo chiamarlo «vuoto interiore». A volte sarebbe meglio chiamarlo «noia», stanchezza di vivere sempre le stesse cose, sensazione di non trovare il segreto della vita: stiamo sbagliando in qualcosa di essenziale, e non sappiamo esattamente in cosa.
A volte la crisi assume un tono religioso. Non sappiamo in cosa credere, nulla riesce a illuminarci dentro, abbiamo abbandonato la religione ingenua di altri tempi, ma non l'abbiamo sostituita con qualcosa di meglio. Allora può crescere in noi una strana sensazione di colpevolezza: siamo rimasti senza una chiave per orientare la nostra vita. Che cosa possiamo fare?
La prima cosa è non cedere alla tristezza: tutto ci sta chiamando a vivere. All'interno di questo disagio si trova qualcosa di somma importanza: il nostro desiderio di vivere qualcosa con maggiore verità. Ciò di cui abbiamo bisogno è riorientare la nostra vita. Non si tratta di correggere un aspetto o un altro. Questo verrà dopo. Ora l'importante è andare all'essenziale, trovare una nuova fonte di vita e di salvezza.
È una fortuna allora incontrarci con la persona di Gesù. Egli può aiutarci a conoscerci con maggiore verità, suscitando il meglio che c'è in noi. Egli può condurci all'essenziale, poiché ci invita a farci le domande che ci avvicinano a ciò che è importante.
In lui ascoltiamo una chiamata a vivere l'esistenza partendo dalla sua radice ultima, vale a dire da un Dio «amante della vita». Egli ci invita a riorientare tutto verso una vita più degna, più generosa, più umana. Per questo è così importante in qualsiasi momento della vita rispondere sinceramente a questa domanda di Gesù: «Chi dite che io sia?».
La cosa decisiva
Che cosa, in definitiva, ci rende cristiani? Poche domande possono essere di maggiore interesse per chi desidera chiarire il suo atteggiamento religioso. La risposta, in termini concisi, può essere solo questa: l'essenziale della fede cristiana di fronte alle altre religioni è Cristo stesso, cioè l'adesione fiduciosa a lui e la sequela fedele della sua persona.
Prima ancora di credere in un insieme di verità, la fede cristiana consiste nel credere a Gesù Cristo. È questa la cosa decisiva. Solo partendo da questa fede nella sua persona, il cristiano scopre la verità ultima, dalla quale cerca di trovare un senso alla propria vita. Il cristiano conosce anche altre interpretazioni dell'esistenza; ascolta il messaggio di altre religioni; può arricchirsi con elementi validi provenienti da altre ideologie. Ma solo in Cristo trova la verità ultima, e solo a partire da lui va configurando la propria personalità.
Per questo, la morale cristiana non consiste in primo luogo nell'osservanza di un insieme di leggi morali, quanto piuttosto nel seguire Gesù come modello di vita, e partendo da lui, nel vivere l'amore come forza ispiratrice di tutto il nostro agire. Il cristiano non ignora altri progetti etici; conosce stili diversi di comportamento; è attento a quanto può umanizzare il mondo. Ma solo in Cristo trova il criterio ultimo per vivere in modo umano, e solo partendo da lui va consolidando la sua responsabilità.
La speranza cristiana, da parte sua, più che «sperare qualcosa» dopo la morte, consiste nello sperare in Gesù Cristo come unico Salvatore, affidando a lui tutto il nostro essere e il nostro futuro. Il cristiano conosce anche altre offerte di salvezza; osserva quanto a volte si spera dalla scienza o dallo sviluppo; collabora a tutto quello che può apportare liberazione, anche se in forma frammentaria. Ma solo da Cristo risorto spera quella salvezza ultima che l'essere umano non può darsi da solo, e solo partendo da lui costruisce la proria speranza.
Per questo, chi in mezzo alla crisi religiosa desidera sapere se continua a essere cristiano, non deve esaminare la sua posizione di fronte al papa, alla Chiesa cattolica o alla pratica domenicale. La prima cosa è domandarci sinceramente: «Credo a Gesù Cristo?», «Lo seguo?», «Confido in lui?». Il nostro cuore smette di essere cristiano quando Cristo non significa più niente per noi. Per questo è così importante ascoltare la sua domanda: «Chi dite che io sia?», «Che cosa significo nelle vostre vite?».
ASCOLTARE GESÙ
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui.
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva.
Mentre parlava così, venne una nube e li copri con la sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!».
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto
(Luca 9,28b-36).
Chi ascoltare?
Sin da piccoli, noi cristiani abbiamo sentito parlare di una scena evangelica tradizionalmente chiamata la «trasfigurazione di Gesù». Non è più possibile sapere con sicurezza come abbia avuto origine il racconto. Venne raccolto nella tradizione cristiana soprattutto per due motivi: li aiutava a ricordare il mistero racchiuso in Gesù e li invitava ad ascoltare solo lui.
Sulla cima di un «alto monte», i discepoli più intimi vedono Gesù con il volto «trasfigurato». Lo accompagnano due personaggi leggendari della storia di Israele: Mosè, il grande legislatore del popolo, ed Elia, il profeta di fuoco, che difese Dio con zelo ardente.
I due personaggi, rappresentanti della Legge e dei Profeti, hanno il volto spento: solo Gesù irraggia luce. D'altra parte, non proclamano nessun messaggio, vengono a «conversare» con Gesù: solo lui ha l'ultima parola. Solo lui è la chiave per leggere qualsiasi altro messaggio.
Pietro non sembra averlo capito. Propone di fare «tre capanne», una per ciascuno. Mette tutti e tre sullo stesso piano. Non ha colto la novità di Gesù. La voce uscita dalla nube chiarirà le cose: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!». Non si devono ascoltare Mosè ed Elia, ma Gesù, il «Figlio amato». Le sue parole e la sua vita ci rivelano la verità di Dio.
Vivere ascoltando Gesù è un'esperienza unica. Finalmente stiamo ascoltando qualcuno che dice la verità. Qualcuno che sa perché e a quale fine vivere. Qualcuno che offre le chiavi per costruire un mondo più giusto e più degno dell'essere umano.
Noi seguaci di Gesù non viviamo di una qualunque credenza, nonna o rito. Una comunità diventa cristiana nella misura in cui mette al suo centro il Vangelo e solo il Vangelo. Qui si mette in gioco la nostra identità. Non è facile immaginare un fatto sociale più umanizzante di un gruppo di credenti che ascoltano insieme il «racconto di Gesù». Ogni domenica possiamo ascoltare la sua chiamata a guardare la vita con occhi diversi e a viverla con maggiore responsabilità, costruendo un mondo più abitabile.
Ascoltare solo Gesù
La scena è tradizionalmente chiamata la «trasfigurazione di Gesù». Non è possibile ricostruire con certezza l'esperienza che diede origine a questo sorprendente racconto. Sappiamo solo che gli evangelisti vi conferiscono grande importanza, poiché si tratta di un'esperienza che lascia intravedere qualcosa della vera identità di Gesù.
In un primo momento, il racconto sottolinea la trasformazione del suo volto e, anche se vengono a conversare con lui Mosè ed Elia, forse a rappresentare rispettivamente la Legge e i Profeti, solo il volto di Gesù resta trasfigurato e splendente al centro della scena.
A quanto pare, i discepoli non colgono il contenuto di quello che stanno vivendo, poiché Pietro dice a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Pone Gesù sullo stes-
so piano e allo stesso livello dei due grandi personaggi biblici. A ciascuno la sua tenda. Gesù non occupa ancora un posto centrale e assoluto nel suo cuore.
La voce di Dio lo correggerà, rivelando la vera identità di Gesù: «Questi è il Figlio mio, l'eletto», colui che ha il volto trasfigurato. Non va confuso con i volti di Mosè e di Elia, che restano spenti. «Ascoltatelo!». Lui e nessun altro. La sua Parola è l'unica decisiva. Gli altri devono portarci a lui.
Nella Chiesa attuale è urgente recuperare l'importanza decisiva che ai suoi inizi ebbe l'esperienza di ascoltare nel seno delle comunità cristiane il racconto di Gesù raccolto nei vangeli. Questi quattro scritti costituiscono per noi un'opera unica che non dobbiamo mettere sullo stesso piano degli altri libri biblici.
C'è qualcosa che possiamo trovare solo in essi: l'impatto avuto da Gesù sui primi che si sentirono attratti da lui e lo seguirono. I vangeli non sono libri didattici che espongono una dottrina accademica su Gesù. E neanche biografie redatte per informare dettagliatamente sul corso della sua storia. Sono «racconti di conversione» che invitano al cambiamento, alla sequela di Gesù e a identificarsi col suo progetto.
Per questo richiedono di essere ascoltati in atteggiamento di conversione. E con questo atteggiamento devono essere letti, predicati, meditati e custoditi nel cuore di ogni credente e di ogni comunità. Una comunità cristiana che ogni domenica sa ascoltare il racconto evangelico di Gesù con atteggiamento di conversione, comincia a trasformarsi. La Chiesa non possiede un potenziale di rinnovamento più vigoroso di quello racchiuso in questi quattro piccoli libri.
Vivere di fronte al Mistero
L'uomo moderno inizia a sperimentare l'insoddisfazione prodotta nel suo cuore dal vuoto interiore, dalla banalità del quotidiano, dalla superficialità della nostra società, dall'incomunicabilità con il Mistero.
Sono parecchi quelli che, a volte in modo vago e confuso, altre in modo chiaro e tangibile, avvertono una delusione e un disincanto inconfessabili di fronte a una società che spersonalizza le persone, le svuota interiormente e le rende incapaci di aprirsi al Trascendente.
La traiettoria seguita dall'umanità è facile da descrivere: essa ha progressivamente imparato a utilizzare con sempre maggiore efficacia lo strumento della sua ragione; è andata accumulando un numero sempre maggiore di dati; ha sistematizzato le sue conoscenze in scienze sempre più complesse; ha trasformato le scienze in tecniche sempre più potenti per dominare il mondo e la vita.
Questo appassionante cammino nel corso dei secoli ha un rischio. Inconsciamente abbiamo finito col credere che la ragione ci porterà alla liberazione totale. Non accettiamo il Mistero. E, tuttavia, il Mistero è presente nel più profondo della nostra esistenza.
L'essere umano vuole conoscere e dominare tutto. Non può però conoscere e dominare la sua origine né il suo destino ultimo. E la cosa più razionale sarebbe quella di riconoscere di essere coinvolti in qualcosa che ci trascende: dobbiamo muoverci umilmente in un orizzonte di Mistero.
Nel messaggio di Gesù c'è un invito scandaloso per le orecchie moderne: non tutto si riduce alla ragione. L'essere umano deve imparare a vivere di fronte al Mistero. E il Mistero ha un nome: Dio, nostro «Padre», che ci accoglie e ci chiama a vivere da fratelli.
Forse il nostro problema più grande è che siamo diventati incapaci di pregare e di dialogare con un Padre. Siamo orfani e non riusciamo a ritenerci fratelli. Anche oggi, tra nubi e tenebre, si può udire una voce che continua a chiamarci: «Questi è il Figlio mio... Ascoltatelo!».
Perduti
Secondo gli esperti, uno dei dati più preoccupanti della società moderna è la «perdita di referenti». Tutti possiamo rendercene conto: la religione sta perdendo la sua forza nelle coscienze; si sta stemperando la morale tradizionale; nessuno sa più esattamente chi possa essere in possesso delle chiavi che orientano l'esistenza.
Parecchi educatori non sanno cosa dire né a nome di chi parlare ai loro alunni riguardo alla vita. I genitori non sanno quale «eredità spirituale» lasciare ai loro figli. La cultura si sta trasformando in mode che si succedono. I valori del passato interessano meno dell'informazione sull'immediato.
Sono molti quelli che non sanno molto bene dove fondare la loro vita né a chi rivolgersi per orientarla. Non si sa dove trovare i criteri che possano supportare il modo di vivere, pensare, lavorare, amare o morire. Tutto resta soggetto al cambio costante delle mode o dei gusti del momento.
È facile constatare già alcune conseguenze. Se non c'è nessuno a cui rivolgerci, ognuno deve difendersi come può. Alcuni vivono con una «personalità in prestito», nutrendosi della cultura dell'informazione. Ci sono alcuni che cercano qualche surrogato nelle sette oppure addentrandosi nel mondo seducente del «virtuale». D'altra parte, sono sempre più quelli che vivono perduti. Non hanno mèta né progetto. Presto diventano facile preda di chiunque possa soddisfare i loro desideri immediati.
Dobbiamo reagire. Vivere con un cuore più attento alla verità ultima della vita; fermarci ad ascoltare le necessità più profonde del nostro essere; sintonizzarci col nostro vero io. E , facile che nasca in noi la necessità di ascoltare un messaggio diverso. Forse allora faremo più spazio a Dio.
La scena evangelica di Luca riacquista un senso profondo ai tempi nostri. Secondo il racconto, i discepoli, «hanno paura» all'entrare nella nube. Si sentono soli e perduti. In mezzo alla nube ascoltano una voce che dice loro: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!». È difficile vivere senza ascoltare una voce che porti luce e speranza nel nostro cuore.
Dove ascoltare Gesù?
Tra tutti i metodi possibili per leggere la Parola di Dio, in alcuni settori cristiani si sta sempre più rivalutando il metodo chiamato lectio divina, molto apprezzato in altri tempi, soprattutto nei monasteri. Consiste in una lettura meditata della Bibbia, orientata direttamente a suscitare l'incontro con Dio e l'ascolto della sua parola in fondo al cuore. Questa forma di lettura del testo biblico esige che si seguano diversi passi.
Il primo è quello di leggere il testo, cercando di coglierne il senso originale, per evitare qualsiasi interpretazione arbitraria o soggettiva. Non è giusto far dire alla Bibbia qualunque cosa, travisandone il senso reale. Dobbiamo comprendere il testo impiegando tutti gli aiuti a disposizione: una buona traduzione, le note della Bibbia, qualche semplice commentario.
La meditazione suppone un passo ulteriore. Ora si tratta di accogliere la Parola di Dio meditandola in fondo al cuore. Per questo si comincia a ripetere lentamente le parole fondamentali del testo, cercando di assimilarne il messaggio e farlo nostro. Gli antichi dicevano che è necessario «masticare» o «ruminare» il testo biblico per «farlo scendere dalla testa al cuore». Questo momento richiede raccoglimento e silenzio interiore, fede in Dio, che mi parla, docile apertura alla sua voce.
Il terzo momento è la preghiera. Il lettore passa ora da un atteggiamento di ascolto a uno di risposta. Questa preghiera è necessaria perché si stabilisca il dialogo tra il credente e Dio. Non c'è bisogno di grandi sforzi di immaginazione né di inventare bei discorsi. Basta chiederci con sincerità: «Signore, che cosa vuoi dirmi attraverso questo testo? A cosa mi chiami in concreto? Quale fiducia vuoi infondermi nel cuore?».
Si può poi passare a un quarto momento, che si è soliti designare come contemplazione o silenzio davanti a Dio. Il credente riposa in Dio mettendo a tacere altre voci. È il momento di stare davanti a lui ascoltando solo il suo amore e la sua misericordia, senza altra preoccupazione o interesse.
Infine, è necessario ricordare che la vera lettura della Bibbia finisce nella vita concreta, e che il criterio per verificare se abbiamo ascoltato Dio è la nostra conversione. Per questo bisogna passare dalla «Parola scritta» alla «Parola vissuta». San Nilo, venerabile Padre del deserto, diceva: «Io interpreto la Scrittura con la mia vita».
Secondo il racconto della scena del Tabor, i discepoli ascoltano questo invito: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!». Un modo per farlo è imparare a leggere i vangeli di Gesù con questo metodo. Scopriremo uno stile di vita che può trasformare per sempre la nostra esistenza.
SEGUIRE GESÙ
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé.
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio.
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo».
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va' e annuncia il regno di Dio».
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio»
(Luca 9,51-62).
Senza adagiarci né volgerci indietro
Seguire Gesù è il cuore della vita cristiana. L'essenziale. Non esiste nulla di più importante o decisivo. Proprio per questo Luca descrive tre scenette perché le comunità che leggeranno il suo vangelo prendano coscienza del fatto che, agli occhi di Gesù, non ci può essere nulla di più urgente e improrogabile.
Gesù impiega immagini dure e scandalose. Si vede che vuole scuotere le coscienze. Non cerca altri seguaci, ma seguaci più impegnati che lo seguano senza riserve, rinunciando a false sicurezze e accettando i necessari distacchi. Le sue parole pongono in fondo una sola questione: quale relazione vogliamo stabilire con lui, noi che diciamo di essere suoi seguaci?
Prima scena. Uno di quelli che lo accompagnano si sente tanto attratto da Gesù che, ancora prima che questi lo chiami, prende l'iniziativa: «Ti seguirò dovunque tu vada». Gesù gli fa prendere coscienza di quello che sta dicendo: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi», ma lui «non ha dove posare il capo».
Seguire Gesù è tutta un'avventura. Non offre ai suoi sicurezza o benessere. Non aiuta a guadagnare denaro o ad acquisire potere. Seguire Gesù è «vivere in cammino», senza adagiarci nel benessere e senza cercare un falso rifugio nella religione. Una Chiesa meno potente e più vulnerabile non è una disgrazia. È la cosa migliore che può accaderci per purificare la nostra fede e avere più fiducia in Gesù.
Seconda scena. Un altro è disposto a seguirlo, ma gli chiede di poter adempiere dapprima all'obbligo sacro di «seppellire il padre». Nessun ebreo può sorprendersi di ciò, poiché si tratta di uno degli obblighi religiosi più importanti. La risposta di Gesù è sconcertante: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va' e annuncia il regno di Dio».
Aprire vie al regno di Dio operando per una vita più umana è sempre il compito più urgente. Nulla deve ritardare la nostra decisione. Nessuno ci deve trattenere o frenare. I «morti», che non vivono al servizio del regno della vita, si dedichino invece ad altri obblighi meno urgenti rispetto al regno di Dio e alla sua giustizia.
Terza scena. A un terzo che vuole congedarsi da quelli di casa sua prima di seguirlo, Gesù dice: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». Non è possibile seguire Gesù volgendosi indietro. Non è possibile aprire vie al regno di Dio restando nel passato. Operare al progetto del Padre richiede dedizione totale, fiducia nel futuro di Dio e audacia per camminare seguendo le orme di Gesù.
Seguire Gesù
«Seguire» Gesù è una metafora che i discepoli appresero per le vie della Galilea. Per loro significa in concreto: non perdere di vista Gesù; non fermarsi lontano da lui; camminare e muoversi dietro di lui. «Seguire» Gesù esige una dinamica di movimento. Per questo l'immobilismo nella Chiesa è una malattia mortale: uccide la passione di seguire Gesù condividendone la vita, la causa, il destino.
Le prime generazioni cristiane non dimenticano mai che essere cristiani significa «seguire» Gesù e vivere come lui. Questa è la cosa fondamentale. Per questo Luca attribuisce tanta importanza a tre detti di Gesù.
Primo detto. A uno che gli si avvicina deciso a seguirlo, Gesù dà questo ammonimento: «Il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». L'istinto di sopravvivenza nella società moderna sta portando noi cristiani a cercare sicurezza. La gerarchia si affanna a recuperare un sostegno sociale che è in diminuzione. Le comunità cristiane perdono peso e forza di influenza nei loro ambienti. Non sappiamo «dove posare il capo». È il momento di imparare a seguire Gesù in modo più umile e vulnerabile, ma anche più autentico e reale.
Secondo detto. A uno che gli chiede di andare dapprima a seppellire suo padre, Gesù dice: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va' e annuncia il regno di Dio». Nella Chiesa viviamo spesso distratti da abitudini e obblighi provenienti dal passato, che però oggi non aiutano a generare vita evangelica. Ci sono pastori che si sentono come «morti intenti a seppellire altri morti». È il momento di tornare a Gesù e di cercare innanzi tutto il regno di Dio. Solo così ci porremo nella vera prospettiva per comprendere e vivere la fede come voleva lui.
Terzo detto. A un altro dice: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». Non è possibile annunciare il regno di Dio se ci si volge solo indietro. Quando soffochiamo la creatività o uccidiamo l'immaginazione evangelica, quando controlliamo ogni novità ritenendola pericolosa e promuoviamo una religione statica, stiamo ostacolando la sequela viva di Gesù. È il momento di cercare, ancora una volta, «vino nuovo in otri nuovi». Lo chiedeva Gesù.
Un cristianesimo di sequela
In tempi di crisi è grande la tentazione di cercare sicurezza, tornare a posizioni facili e bussare di nuovo alle porte di una religione che ci «protegga» da tanti problemi e conflitti.
Dobbiamo rivedere il nostro cristianesimo per vedere se nella Chiesa attuale siamo motivati dalla passione di seguire Gesù o andiamo in cerca di «sicurezza religiosa». Secondo il noto teologo tedesco Johann Baptist Metz, è questa la sfida più grave che dobbiamo affrontare noi cristiani in Europa: deciderci tra una «religione borghese» o un «cristianesimo di sequela».
Seguire Gesù non significa rifugiarsi in un passato ormai morto, ma cercare di vivere oggi con lo spirito che lo animò. Come ha detto acutamente qualcuno, si tratta di vivere oggi «con la brezza di Gesù» non secondo «il vento dominante». La sequela non consiste nella ricerca di novità o nella promozione di gruppi scelti, ma nel fare di Gesù l'unico asse delle nostre comunità, mettendoci decisamente al servizio di ciò che lui chiamava regno di Dio.
Per questo, seguire Gesù implica quasi sempre l'andare «controcorrente», in atteggiamento di ribellione verso abitudini, mode o correnti di opinione che non concordano con lo spirito del Vangelo.
E ciò esige non solo che non ci lasciamo addomesticare da una società superficiale e consumistica, ma anche che contraddiciamo i nostri amici e familiari quando ci invitano a seguire vie contrarie al Vangelo.
Per questo, la sequela di Gesù esige di essere disposti alla conflittualità e alla croce. Essere disposti a condividerne il destino. Accettare il rischio di una vita crocifissa come la sua, sapendo che ci attende la risurrezione. Saremo capaci oggi di ascoltare la chiamata sempre viva di Gesù a seguirlo?
L'inverno nella Chiesa
Negli ultimi anni della sua vita, il celebre teologo Karl Rahner diceva che in Europa la fede si trova in un «periodo invernale». Poi ci sono stati vari teologi europei che hanno usato la stessa metafora per descrivere il momento attuale della Chiesa. Si tratta, senza dubbio, di un'espressione dura, suggerita però da alcuni gravi indizi. Segnalerò solo quelli che emergono con maggiore forza.
Parecchi cristiani si sentono scossi nella loro stessa identità. Non sono sicuri di essere credenti. Non riescono neanche a comunicare con Dio. Alcuni parlano della «segreta mancanza di fede» che cresce all'interno stesso della Chiesa. D'altra parte, non sembra che le Chiese stiano riuscendo a trasmettere la fede alle nuove generazioni.
Un altro dato importante è la perdita di credibilità. La Chiesa non suscita più la fiducia di alcuni anni fa. La sua parola, molte volte autoritaria ed esigente, non possiede il peso morale di altri tempi. L'autorità religiosa è messa in discussione dentro e fuori la Chiesa. Al cristianesimo vengono chiesti fatti, non discorsi.
Inoltre, «ciò che è cristiano» sembra socialmente sempre più irrilevante. Il teologo di Tubinga Nobert Greinacher osserva che «la Chiesa sta diventando un fenomeno sempre più marginale nella nostra società». In alcuni ambienti, la sua condotta non è neanche considerata degna di discussione o di critica.
L'immagine di Karl Rahner racchiudeva, tuttavia, un senso più positivo di quello della «rigidità invernale». Nell'inverno si annuncia già la primavera, e sotto i campi gelati la vita si prepara a una nuova rinascita. Ma nulla di importante nasce in modo facile. Lo stesso Rahner chiedeva, in primo luogo, radicalità, ritorno alle radici. «È difficile sapere in che modo o con quali mezzi farlo, ma, se il cristianesimo fosse caratterizzato dalla radicalità, nella Chiesa arriverebbe la primavera». Oggi non abbiamo santi tra noi, o forse non siamo in grado di riconoscerli. È questo il nostro primo problema.
La Chiesa deve spogliarsi dalle false sicurezze per accompagnare gli uomini e le donne di oggi alla ricerca di senso e speranza. Il «restaurazionismo» conduce solo a un accumularsi pericoloso di rigidità e di esasperazione. Ciò di cui abbiamo bisogno è la conversione personale e collettiva al Dio vivente di Gesù Cristo.
È arrivato il momento in cui la Chiesa, mettendo da parte questioni secondarie, deve ascoltare la chiamata di Gesù: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va' e annuncia il regno di Dio».
Dio non è violento
Gesù non accettò nessuna forma di violenza. Al contrario, volle eliminarla alla radice. Non c'è alcun dubbio. I cristiani lo hanno sempre proclamato e lo afferma chiaramente la ricerca attuale. La non violenza è uno dei tratti essenziali dell'azione e del messaggio di Gesù. Nel racconto di Luca, Gesù reagisce energicamente e riprende i suoi discepoli perché desiderano che «un fuoco dal cielo» distrugga gli odiati samaritani che non li hanno accolti.
Tuttavia, sorprendentemente, questa non violenza di Gesù non è stata considerata normativa né rilevante per il cristianesimo. Nel corso dei secoli, i cristiani l'hanno considerata come qualcosa senza nessuna relazione con la fede o con il comportamento cristiano. Si è arrivati perfino a benedire guerre, crociate e posizioni militaristiche, senza essere coscienti di andare contro qualcosa di essenziale dell'adesione a Gesù Cristo.
Dove si trova la radice di questa contraddizione? Secondo diversi teologi, il cristianesimo continua a essere prigioniero dell'idea del Dio violento della Bibbia, senza avere il coraggio di seguire Gesù. Si conosce e si ammira la non violenza del maestro di Galilea, ma nella coscienza sociale dei popoli «cristiani» continua a essere vivo e operante l'archetipo di un Dio giustiziere e castigatore, che si impone a tutti perché ha più forza degli altri. È questo Dio che ci porta continuamente alla guerra.
Gesù volle senz'altro sradicare dalle coscienze l'immagine di un Dio violento. I suoi gesti, le sue parole, tutta la sua vita rivelano un Dio Padre che non si impone mai con la violenza. Per Gesù, accogliere il regno di Dio significa precisamente eliminare ogni forma di violenza tra gli individui e tra i popoli. Il suo messaggio è sempre lo stesso: «Dio è un Padre vicino. L'unico suo desiderio è una vita più degna e felice per tutti. Cambiate il vostro modo di pensare e di agire, e credete in questa Buona Notizia».
La fede di Gesù non è ancora riuscita a cambiare l'inclinazione umana al ricorso alla violenza. Coloro che dominano il mondo sembrano comprendere solo il linguaggio della guerra. Pensano di «imporre la giustizia» agendo a immagine del Dio violento di alcune pagine dell'Antico Testamento. Si deve cambiare e credere nel Dio di Gesù. Non è assurdo cercare vie non violente. L'assurdo è che ci sia ancora qualcuno che continui a credere nella guerra nonostante i tanti secoli della sua barbara inutilità.
(La via aperta da Gesù 3. Luca, Borla 2012, pp. 113-130)













































