I «fondamentali»
del Padre nostro
Gruppo di Dombes
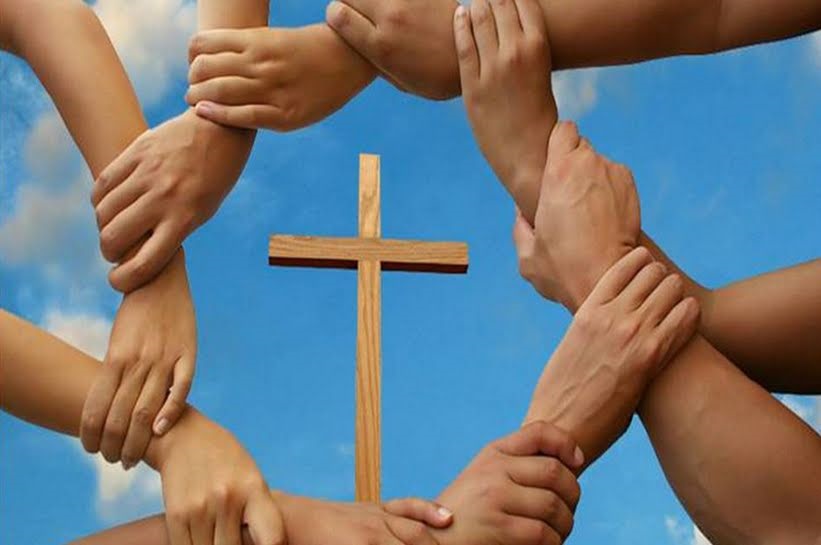
«Padre Nostro»
Fondarsi sulla paternità di Dio comporta il rischio di evocare immagini ambivalenti, legate all'esperienza positiva o negativa del padre umano che abbiamo avuto. Il termine «padre» può inviare a quanto c'è di più rassicurante: fedeltà, fiducia, protezione, responsabilità. Ma può anche essere associato a quanto c'è di più triste: conflitto, violenza, instabilità, assenza. L'analogia è comunque importante, poiché se non sapessimo cos'è un padre terreno, sarebbe impossibile parlare di un Padre celeste.
Legame filiale unico con il Padre è quello del Figlio, Gesù Cristo. Egli ci rivela il Padre, ci rivela chi è il Padre e come lo è, ed è solo per mezzo di lui che possiamo parlare non solo di Dio ma anche a Dio in quanto «Padre nostro». La relazione con il Padre ha anche una dimensione trinitaria, poiché, secondo san Paolo, è nello Spirito che, in quanto «figli di Dio», gridiamo: «Abbà, Padre» (Rm 8,14-17; cf. Gal 4,6-7).
Affermare che Dio è Padre significa dire molte cose di centrale importanza per i credenti.
In noi stessi noi non abbiamo né la nostra origine né la nostra fine. La nostra vita e la nostra identità si concepiscono solo in relazione: con altri, con i genitori, i fratelli, le persone che incrociamo per strada e infine in relazione con Dio. La relazione è costitutiva della nostra identità umana e cristiana.
L'identità battesimale di «figli di Dio» è una qualità di relazione, viva e vitale, da riattualizzare nel quotidiano, per un divenire: «Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato» (1Gv 3,2). Come abbiamo visto nella riflessione di Lutero, Dio non diventa Padre solo per i suoi figli più meritevoli, ma lo è, una volta per tutte, adottandoci nel suo Figlio unico in una filiazione che niente può distruggere.
Nella preghiera del Padre Nostro noi domandiamo di vivere e testimoniare sempre più questa verità in risposta al dono, già totale, di un'identità inviolabile, che ci libera per un impegno responsabile. Infatti questo «nostro» (Padre) non si limita alla comunità cristiana, a coloro che sono abitati dalla stessa fede o fanno parte della stessa famiglia (cf. Gal 6,10). La solidarietà cristiana con l'intera umanità è radicata nella convinzione che Dio in quanto Padre rappresenta quella terza istanza alla quale tutti gli esseri umani possono far riferimento. Nel suo significato cristiano, l'amore del prossimo si situa oltre il particolarismo e la predilezione, poiché, senza escluderne alcuna, arriva a ogni persona, che diventa mia interlocutrice. [1]
Quanto ai credenti, essi hanno in comune un vincolo spirituale proprio di chi appartiene alla famiglia cristiana. Essi formano una fraternità, termine caratteristico del cristianesimo nascente (1Pt 2,17; 5,9); tale fraternità non è dello stesso ordine della fratellanza che si riferisce a una stessa discendenza carnale; i suoi membri sono legati gli uni agli altri per l'appartenenza allo stesso Padre, il quale li ha fatti rinascere mediante il battesimo e la fede in Cristo. Come in ogni famiglia, non possiamo scegliere i fratelli e le sorelle. La fraternità è donata, esiste prima di me, mi accoglie, ma può essere vissuta solo in prospettiva. Non basta chiamarsi fratelli e sorelle. In verità lo siamo in funzione del divenire, per appropriarci di ciò che siamo. Ne deriva l'importanza della durata e della resistenza, del perdono e della benevolenza.
Questa fraternità va vissuta in modo cosciente e come impegno reciproco in seno alla Chiesa universale. Non deve sorprendere che essa, concretamente, presenti il volto di confessioni differenti, ognuna con una storia e una spiritualitàproprie: anche il Nuovo Testamento dà testimonianza di una grande diversità. Ecco invece le cose che creano problema: l'appartenenza a una Chiesa con la sua tradizione particolare si dimostra importante tanto quanto l'appartenenza allo stesso Padre; la confessione della stessa fede in Cristo e il dono dello stesso battesimo non sono sufficienti a trasformare la fraternità cristiana in una comunione vissuta, che permetta di celebrare insieme la pienezza dei doni di Dio.
La fraternità non è un'esigenza solo nel contesto di ogni Chiesa; per quanto possibile essa deve informare le relazioni tra le Chiese stesse, senza peraltro avverarsi a detrimento della verità: una Chiesa non può rinunciare a quanto legittimamente ritiene vero. Ma questa lealtà dottrinale non deve impedire alle Chiese di vivere già una reale fraternità nella confessione di fede, nella liturgia e nel servizio della carità. [2]
Pregare il Padre Nostro ci immette in un itinerario di conversione a Cristo: dobbiamo diventare sempre più coscientemente figli dello stesso Padre, Chiese che testimoniano lo stesso vangelo, a nostra volta in una «fraternità» responsabile verso gli altri che pregano e ascoltano il Padre Nostro. La comunità cristiana ha davanti a sé la sfida di rispondere a un unico Padre e di rendere concreta e visibile la comunione già donata in Cristo ai fratelli e alle sorelle.
Il Regno
«Venga il tuo regno!». Il cristiano guarda in avanti, verso il domani, secondo modalità proprie: dopo la risurrezione di Gesù Cristo, essere cristiano significa vivere già nella vita nuova, in attesa dell'avvento della parusia, la venuta nella gloria del Signore Gesù, quando «Dio sarà tutto in tutti» (1Cor 15,28). Questa speranza struttura e mobilita la vita cristiana ed ecclesiale nelle sue dimensioni liturgica, spirituale ed etica:
«Maràna tha. Vieni, Signore Gesù!» (cf. Ap 22,29; 1Cor 16,22). Il banco di prova dei cristiani è precisamente nella qualità di questa attesa, di questa pazienza e di questa speranza nel mondo, come testimonia il seguente inno liturgico:
Resta con noi, Signore Gesù,
Convitato di Emmaus [...].
Tu dai senso ai nostri desideri, futuro alle nostre opere.
Tu, il primo pellegrino,
Stella dell'ultimo mattino,
risveglia in noi, con il tuo amore,
l'immensa speranza del tuo ritorno.[3]
L'operante attesa del Regno implica anzitutto una memoria cristiana del passato, già in grado di dare testimonianza dei doni di Dio. Se ogni essere umano è soprattutto progetto, in quanto non cessa di trascendere il passato per proiettarsi verso l'avvenire e tentare così di anticipare il futuro, al credente è dato di sperare nel futuro di Dio a partire da fondamenti solidi, testimoniati nella rivelazione biblica: la realizzazione dell'alleanza con il popolo ebraico e con i credenti in Gesù Cristo di tutte le nazioni.
L'operante attesa del Regno diventa anche un impegno nel presente, nell'oggi di Dio. Domandare la venuta del Regno mi decentra da me stesso e dai miei desideri immediati, egocentrici; domandare il Regno vuol dire rivolgersi verso un'alterità, quella di Dio e della sua volontà, e anche accettare che questo regno di Dio sconvolga completamente i nostri valori, trasformi le nostre attese e superi le nostre speranze.
Domandare il Regno è volere, con la grazia di Dio, la giustizia, la fraternità e la pace per tutti gli esseri umani. La buona notizia della venuta del Regno non si limita infatti alle Chiese, ma si estende all'intero cosmo: cielo nuovo e terra nuova. Insieme, anche in questo caso, le Chiese devono imparare a gioire dei segni del Regno nel mondo, ad attendere in esso la pienezza della nuova creazione. Le Chiese devono decentrarsi da loro stesse per annunciare con una sola voce il vangelo, partecipando agli sforzi per rendere la terra più umana, per combattere l'ingiustizia e le opere mortifere. Domandare il Regno, significa aprire strade per la sua venuta: le Chiese non esistono per se stesse. Come dice molto bene il prologo della Carta ecumenica europea (2001):
Nel nostro continente europeo, dall'Atlantico agli Urali, da Capo Nord al Mediterraneo, oggi più che mai caratterizzato da un pluralismo culturale, noi vogliamo impegnarci con il vangelo per la dignità della persona umana, creata a immagine di Dio, e contribuire insieme come Chiese alla riconciliazione dei popoli e delle culture. [4]
La domanda del Regno ci ricorda l'urgenza della realizzazione dell'unità e della nostra collaborazione a tale scopo, ma anche i suoi inevitabili ritardi. Siamo invitati a provare meraviglia nel riconoscere ciò che Dio fin d'ora dona alla sua Chiesa nelle sue molteplici tradizioni, ciò che Dio dona alla tale o tal altra comunità cristiana che non è la «mia». Questo dono già offerto e ancora atteso è la mia Chiesa come Chiesa invitata, essa pure, a riconoscerlo con stupore nelle altre Chiese. Così la mia Chiesa sarà decentrata da se stessa, per concentrarsi piuttosto sul Regno già venuto e ancora in formazione, buona notizia annunciata da Gesù. È chiamata a pregare con e per le altre Chiese cristiane in vista dell'unità e, ancor più, a vivere la sua vita non in maniera isolata, ma tenendo permanentemente conto delle altre Chiese cristiane, in una voluta concertazione per vivere il vangelo assieme a loro.
Con l'abbé Paul Couturier preghiamo il Cristo di donare l'unità alla sua Chiesa quando egli vorrà e con i mezzi che egli vorrà. Siamo chiamati a una fervente supplica e conversione quotidiana per l'unità, ma anche a pazientare nella speranza di questo dono.
Il pane
Con la quarta domanda comincia la seconda «parte» del Padre Nostro, che sembra parlare di noi più che di Dio. In realtà in entrambe le parti si tratta di Dio e di noi. Nelle domande della seconda parte, osiamo rivolgerci a Dio in nostro favore, ma lo possiamo fare solo perché abbiamo compreso chi è per noi quel Dio, che ci coinvolge in una relazione.
Nessun'altra domanda è così semplice e naturale come quella che riguarda il nostro pane. E perfino strano che il Padre Nostro non cominci con questa domanda; invece comincia in modo ben diverso: con la santificazione del nome. Si può anche rovesciare l'osservazione: è strano che, dopo le prime tre domande esplicitamente (per così dire) «spirituali», entri in gioco questa, la più fondamentale: noi vogliamo vivere! Donaci la vita!
Come ogni essere vivente, anche l'essere umano per vivere deve nutrirsi. Questo bisogno fa parte della sua vitalità e della sua finitezza. In nessun altro ambito l'uomo si manifesta così palesemente come un essere non autarchico; infatti è continuamente rinviato a ciò da cui dipende, a ciò che è esterno alla sua persona; non si può mangiare una volta per tutte, come non si può respirare una volta per tutte. [5]
È quasi banale a dirsi, ma, per gli esseri viventi, il nutrimento è indispensabile. «Banale», perché l'atto di nutrirsi torna e si ripete ogni giorno; «quasi» banale perché, se il cibo manca, è la fine della nostra esistenza. Eccesso della normalità e al tempo stesso della fragilità! Anche se nel mondo occidentale il pane è diventato un alimento come gli altri (più sofisticati), rimane pur sempre la quintessenza del nutrimento: la sua realtà è la più evidente e il suo simbolismo quello più eloquente. Quando abbiamo una gran fame, non ci viene da pensare anzitutto ai tartufi o al fegato d'oca, ma a un buon pezzo di pane. Il pane e noi: cosa saremmo se non esistesse? Al di là del cibo, esso rappresenta tutto ciò che fa vivere.
Alla luce delle prime domande, la richiesta del pane suona come materialistica. Ma contiene qualcosa di più. Chi chiede a Dio il pane quotidiano prende coscienza della propria dipendenza: l'essere umano dipende dalla cosa più rudimentale, il pane. Con questa domanda, l'uomo riconosce che quello (o colui) da cui dipende non solo è al di fuori della sua portata, ma lo supera. La cosa di cui abbiamo assolutamente bisogno viene a noi, ci è data.
Una cosa così fondamentale ed elementare come il pane si lega dunque al Padre, al dono che ci è fatto: «Dacci», gesto, parola, movimento per eccellenza della preghiera. Movimento tale da essere reso possibile dalle prime parole di questa preghiera: «Padre nostro!», che Lutero parafrasa così: «Vengo, caro Padre, e prego, non a motivo della mia propria decisione o della mia propria dignità, ma del tuo comandamento e della tua promessa, che non possono andare a vuoto né mentire». [6] Noi domandiamo, Dio dona; noi domandiamo affinché Dio doni, noi domandiamo perché Dio dona. Dio già dona, ha già donato, ha sempre donato e la nostra vita ne è la prova. Che cosa dona? Qui e ora: la nostra vita. La nostra vita come suo dono.
Ma allora è proprio il pane che domandiamo o il dono? La domanda può sembrare artificiale. Non lo è nella misura in cui alla domanda corrisponde la risposta di Dio, il suo dono. Forse il pane è proprio il pane affinché il dono sia dono: dono che Dio ci fa di se stesso, cui risponde il dono di noi stessi.
E la fame che persiste nel mondo? Possiamo ricevere con gratitudine il dono che ci fa vivere, senza che la fame diventi la nostra preoccupazione, per far sì che il nostro rapporto con gli altri sia legato al nostro rapporto con Dio? Per far sì che non possiamo pregare Dio per il nostro pane senza pregare per il pane dei poveri e senza batterci per il pane dei poveri. Perché? Per il semplice motivo (è quello che ci «insegna» questa preghiera, questa domanda) che quello che manca, nella fame, non è solo il pane, è il fatto stesso del dono, del pane in quanto «dono».
Su questo punto, le nostre Chiese sono molto prossime fra loro. Davanti alla fame, sperimentano la stessa indigenza. Dovranno arrivare a condividere il dono del pane, dono di Dio per il mondo, non solo nella spartizione del cibo, ma anche in quella della parola. La domanda del pane ha una risonanza eucaristica, come preciseremo più avanti.
Il perdono
La domanda relativa al perdono solleva subito una difficoltà: come possiamo domandare a Dio di rimettere i nostri debiti «come noi li rimettiamo ai nostri debitori»? Non è quasi come dire che il perdono di Dio dipenderebbe dal perdono che noi stessi offriamo agli altri?
E, d'altra parte, il perdono non è forse la cosa più difficile? Se una persona è stata gravemente ferita e mortificata, come potrà perdonare chi le ha fatto così tanto male? Se molte persone sono state umiliate e schiacciate, potranno i sopravvissuti perdonare gli aggressori? La difficoltà di perdonare si esprime bene nella frase, che tante volte abbiamo udito: «Perdono, ma non dimentico...». A volte il perdono si presenta semplicemente come impossibile, e ancor più la riconciliazione.
Di fronte a queste difficoltà, dobbiamo anzitutto riconoscere che un perdono ci è già stato offerto: «Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi [...]. Quando eravamo nemici di Dio, siamo stati riconciliati con lui per mezzo della morte del Figlio suo» (Rm 5,8.10). Da parte nostra, il perdono non può essere un gesto volontaristico e soprattutto non deve essere inteso come la condizione da cui far dipendere il perdono di Dio. In realtà nasce dal perdono di cui noi stessi siamo beneficiari: se Dio ci ha riconciliati con sé quando noi ci eravamo allontanati da lui, allora solo lui può darci la forza di offrire a nostra volta il perdono.
È vero però che il dono di Dio non sempre viene accolto; infatti Paolo dice ai corinzi: «Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 5,20). Il primo passo da fare per poter offrire il perdono agli altri - e per poter essere capaci di offrirlo - è quello di lasciarci riconciliare con Dio, lasciarci perdonare da lui, vivere del suo perdono.
Solo sul fondamento di questo perdono ricevuto può risuonare l'invito a perdonare, ossia, se riprendiamo l'immagine usata nel Nuovo Testamento, a «rimettere i debiti». Dio si aspetta da noi che trattiamo i nostri simili come li tratta lui stesso, il Padre misericordioso. Ci riusciremo forse solo per tappe successive: ci vuole tempo per rinunciare alla vendetta, per accettare di essere stati feriti, per consentire a perdonare; ci vuole tempo anche perché la persona che ha dei debiti verso di noi riconosca i suoi torti e ne chieda perdono. Ma l'invito rimane: accogliere in verità il perdono di Dio significa accettare di donare il perdono a coloro che ci hanno offeso. Nella parabola del vangelo, il servo (pure lui debitore verso il suo padrone, e il cui debito era stato condonato) si vede rimproverare di non aver avuto a sua volta pietà del suo simile (Mt 18,33). Noi stessi siamo debitori che hanno beneficiato del perdono di Dio e dobbiamo a nostra volta perdonare «non sette volte, ma fino a settanta volte sette» (Mt 18,22). Rifiutare di dare il perdono agli altri significa rifiutare il perdono che noi abbiamo già ricevuto da Dio: perdonare agli altri è, al contrario, accogliere il dono di Dio nell'atto stesso di trasmetterlo e disporci quindi ad accoglierlo di nuovo, quando lo domandiamo con le parole: «Rimetti a noi i nostri debiti».
Se applicata al movimento ecumenico, questa domanda costituisce un profondo invito alla conversione e alla riconciliazione delle Chiese. Senza perdono infatti non ci sarà né unità né vero ecumenismo. Tutte le Chiese sono chiamate a domandare perdono a Dio, perché tutte sono formate da figli infedeli all'amore del Padre e alla sua chiamata all'unità. [7] Tutte devono chiedere lo spirito di penitenza per se stesse e le une per le altre, dal momento che non possono schivare il passaggio, cruciale e pasquale, attraverso la riconciliazione fraterna. [8] L'esperienza del perdono donato ai fratelli e da loro ricevuto, sul previo fondamento del dono di Dio, può permetterci di capire meglio la missione della Chiesa. Essa, ricevendosi da Dio, fonte di ogni perdono, non può far altro che invitare ogni credente e ogni Chiesa a praticare attivamente il perdono reciproco; in esso infatti consiste il dono che abbiamo ricevuto da Dio. Se il perdono di Dio è la radice di tutto - e nella fede possiamo esserne sicuri, perché è visibile sull'albero della croce - il perdono tra fratelli e tra Chiese diventa il frutto indispensabile, segno della misericordia di Dio in mezzo a coloro che lo invocano come Padre di ogni misericordia.
Le prove
Normalmente, anche la domanda «non ci indurre in tentazione» solleva gravi difficoltà. Sembra infatti presupporre che Dio potrebbe indurci lui stesso in tentazione; ma come accettare l'immagine di Dio che ne viene fuori? Non sarebbe quest'ultima incompatibile con la rivelazione di un Dio che dona la vita e perdona? E inoltre, non implicherebbe un attentato alla nostra libertà, inducendo a credere che noi subiremmo passivamente la tentazione alla quale Dio ci avrebbe sottoposti?
Di fronte a tali questioni, è bene ricordare che, come c'insegna l'esperienza umana, alcune prove possono effettivamente distruggerci, ma ciò non significa che tali prove vengano da Dio: non è Dio che le manda, Dio è piuttosto colui che dà la forza di attraversarle e di rialzarsi.
Abbiamo soprattutto bisogno di ritrovare il significato biblico della «tentazione», del «mettere alla prova», così come esso traspare nella storia di personaggi quali Abramo o Giobbe, oppure più estesamente attraverso la storia dell'intero popolo d'Israele. Spesso, infatti, questo popolo si è trovato alla prova; ciò è successo durante l'esodo verso la terra pro-messa e, più tardi, al tempo dell'esilio. Nella prova, ha certamente rischiato di dubitare del suo Dio e anche di allontanarsi da lui, ma attraverso la prova ha potuto anche affermare la propria fede e la propria fedeltà. E stato «messo alla prova» non per essere fatalmente condotto al peccato (anche se, di fatto, vi è spesso caduto), ma per poter credere in Dio finanche nelle avversità e, per questo, ricevere la vita. Gesù stesso è stato «tentato» nel deserto, ma giustamente non ha ceduto al tentatore, al quale ha replicato: «Sta scritto: "Il Signore tuo Dìo tu adorerai; a lui solo renderai culto" (Mt 4,10)». [9] Parimenti, attraverso la prova della sua passione, Gesù ha manifestato la sua perfetta fedeltà e la sua totale obbedienza al Padre.
Oggi la difficoltà nasce dal fatto che il termine «tentazione» ha due significati diversi. Se la comprendiamo come «volontà di attirare qualcuno al male», è chiaro che tale volontà non può essere attribuita a Dio. Se invece la tentazione è intesa come «prova», allora, alla luce della Scrittura, comprendiamo che Dio possa in questo senso «provare» il credente. Questa prova ha una sua funzione pedagogica: anche nell'esperienza umana un maestro può testare le capacità del suo scolaro o i genitori possono verificare le attitudini di un figlio. Ma, nel nostro caso, la prova è anzitutto quella della fede. Dio ci mette alla prova perché si manifesti lo spessore della fede. Se non è concepibile che Dio tenti l'uomo per indurlo al male, è invece comprensibile che metta alla prova i figli che vuole condurre alla santità, cioè alla piena comunione con lui.
La prova dev'essere l'occasione per affermare la nostra fede; ciò nondimeno essa ci espone al rischio di soccombere al male (mentre per Gesù non è stato così, come dimostra l'episodio delle tentazioni nel deserto). Per questo chiediamo al nostro Padre di non sottometterci alla tentazione. Dio può certamente «provarci», cioè «metterci alla prova» affinché si manifesti la nostra fede; tuttavia, poiché conosce la nostra fragilità, gli chiediamo di risparmiarci la prova stessa, affinché, sotto i suoi colpi, non finiamo per soccombere effettivamente al peccato e non arriviamo a dimenticare che Dio è Padre misericordioso.
Vi è, in questa preghiera del Padre Nostro, un significato ancora più profondo. Di fatto, la prova dalla quale chiediamo di essere preservati è anche quella escatologica, cioè la prova estrema del pericoloso scontro con l'avversario, il quale, secondo la Scrittura, è capace di condurre l'uomo alla perdizione. Sotto l'effetto del diavolo o «maligno», che propriamente parlando è il «tentatore», a dispetto del dono ricevuto, potremmo essere condotti a quel male totale e mortifero che è l'abbandono della fede, cioè la perdita della relazione fiduciosa con il Padre. Ne deriva l'insistenza della nostra preghiera, che implora Dio di non permettere che ci sia imposta quest'ultima paurosa prova, altrimenti rischieremmo di soccombere alle forze del male scatenate contro di noi.
Il paradosso sta nel fatto che, mentre Dio stesso prova i suoi affinché si affermi e s'irrobustisca la loro fede, da parte sua il credente chiede che la prova gli sia risparmiata. Il discepolo di Cristo è cosciente della propria incapacità non solo di affrontare l'avversario nella prova ultima appena evocata, ma anche di resistere al male nelle prove quotidiane. Possiamo allora intendere la domanda del Padre Nostro «non ci indurre in tentazione» come l'espressione di un'autentica povertà interiore. L'uomo sa di essere troppo debole per osare presentarsi alla prova: al contrario di uno sportivo che cerca la prova anche a rischio di perdere, il credente che prega il Padre Nostro non mette la sua fiducia nelle proprie capacità, ma nella misericordia di Dio, che può risparmiargli la prova ed evitargli così di soccombere al male. Il fatto stesso di rivolgere la domanda «non ci indurre in tentazione» è comunque, in quanto tale, un atto di resistenza al male. E nel caso in cui, in futuro, sia malgrado tutto provato e tentato, il credente implora fin d'ora il Padre di Gesù Cristo perché possa liberarlo dal «male» o dal «maligno».
La domanda di essere dispensati dalla prova giunge appositamente a ripetere alle Chiese che le loro divisioni fanno il gioco delle forze del male e che sono il risultato delle loro infedeltà di ieri e di oggi all'invito all'unità che hanno ricevuto dal Signore. Certamente ricorda che l'unità cercata non è anzitutto frutto dei loro sforzi, quasi fosse una prestazione sostenuta per dimostrare competenze umane: l'unità dei cristiani si presenta come un dono da accogliere. Nell'attesa e nella speranza di questo dono, ci rivolgiamo al Padre mentre, fin da ora, la preghiera accolta dal Signore deve ispirare le nostre Chiese a progredire ancora sul cammino del pentimento e della conversione in vista della piena comunione.
NOTE
1 Un'inflessione che si annuncia già nella Torà, quando l'interpretazione communitarista del comandamento «Amerai il tuo prossimo come te stesso» (Lv 19,18) viene corretta un po' più oltre con l'ingiunzione che bisogna amare l'emigrato come se stesso (Lv 19,34).
2 Ottato di Milevi, nel secolo IV, rivolgendosi a un cristiano appartenente a una comunità separata, scriveva: «Voi non potete non essere nostri fratelli: voi siete stati generati dalla stessa madre, la Chiesa, da una stessa carne, i sacramenti, e siete stati accolti da Dio Padre, allo stesso modo, come suoi figli adottivi» (OTTATO DI MILEVI, Adversus donatistas – Trattato contro i donatisti IV,2,4: SC 413,83).
3 Reste avec nous, Seigneur Jésus, Toi, le convive d'Emmatis [...]. Tu donnes un sens à nos désirs, À nos labeurs un avenir.
Toi, le premier des pèlerins, L'étoile du dernier matin, Réveille en nous, par ton amour, L'immense espoir de ton retour.
Reste avec nous, testo della COMMISSIONE FRANCOFONA CISTERCENSE (Fr. Pierre Yves de Taizé), Ensemble. Recueil cecuménique de chants et de prières, Bayard-Olivétan, Paris-Lyon 2002, n. 741, 465; Prières et chants du peuple de Dieu. Manuel des paroisses, Tardy, Paris 1998, n. P 10-80-1, 428.
4 In E0 8/1273.
5 Cf. quanto si è detto sopra sulla manna e sul significato dell'espressione «il nostro pane quotidiano» nei testi evangelici di Mt e Le (nn. 135.149-150).
6 LUTERO, Il grande catechismo, in ID., Opere scelte, 1. Il piccolo catechismo – Il grande catechismo, a cura di E FERRARIO, Claudiana, Torino 1998, 252.
7 Cf. quanto scriveva AGOSTINO a proposito della preghiera «Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori»: «Questa è la preghiera di tutta la Chiesa valida fino alla fine del mondo» (Retractationes 1,19,3: BA 12,389).
8 Cf. gli esempi dati sotto, n. 195, nota 6 della Parte IV, capitolo 2.
9 Cf. le spiegazioni date sopra nella parte biblica, nn. 153-154.
(Fonte: «Voi dunque pregate così». Il Padre Nostro. Itinerario per la conversione della Chiese, EDB 2011, pp. 139-151, nn.166-189)













































