I Quaderni
dell'animatore
15. AGGREGAZIONE
GIOVANILE
E ASSOCIAZIONISMO
ECCLESIALE
Giancarlo De Nicolò
INDICE
l. SOCIALIZZAZIONE E AGGREGAZIONE IN ITALIA
1.1. Aggregazione: un fenomeno consistente e significativo
- Alcuni dati iniziali
- L'area degli interessi: il personale
1.2. La socializzazione nell'Italia degli anni '70 e '80
2. l GRUPPI E l MOVIMENTI GIOVANILI ECCLESIALI
2. l. L'associazionismo ecclesiale: una forte ripresa
- Le caratteristiche della ripresa
- Una prima interpretazione
2.2. Alcune distinzioni sociologiche
2.3. Verso una tipologia
- Qualche criterio per la costruzione di una tipologia
- Una tipologia «descrittiva»
- Una tipologia «interpretativa»
2.4. Una storia dell'associazionismo ecclesiale
- Legittimazione ideologica ed emergere del dissenso
- Contrazione dei gruppi ad azione sociale
- L'espansione dei gruppi a specifica identità
3. L'ASSOCIAZIONE INVISIBILE
3. l. Annotazioni di metodo e dati dell'indagine Quaranta
3.2. Quale cultura e quali modelli di interazione ?
- Perché il gruppo di base?
- Una cultura nuova e omogenea
3.3. 1 modelli interpretativi
- Modello della «reazione religiosa
- Modello della «risocializzazione»
- Modello dei «sincretismo religioso»
4. PROBLEMATIZZAZIONE EDUCATIVA
4. l. 1 problemi educativi di fondo
-La possibilità educativa
- Il problema della maturità cristiana
4.2. l problemi educativi «funzionali»
4.3. l problemi educativi di oggi
- Il rapporto gruppo/ persona/ istituzioni
- L'identità personale e collettiva
- Quale presenza sul territorio?
^ Con questo quaderno si chiude la serie dedicata all'analisi della situazione sotto il titolo «fare animazione con questi giovani». Nei quattro quaderni della serie non si . è voluto offrire un quadro esaustivo della situazione sociale, culturale, religiosa, giovanile, ma solo uno spaccato per far intuire i problemi emergenti e le «nuove soluzioni» e, soprattutto, delle griglie di lavoro per sollecitare ad una lettura personale della realtà. Il Q12 ha offerto un quadro sociologicogenerale dell'attuale momento socioculturale per «collocare» i giovani e la loro «difficile identità» (Milanesi) e un quadro psicologico per ricordare le principali fasi del cammino dalla fanciullezza alla giovinezza (Amione). Il Q13 ha invece approfondito con cura i tratti principali della attuale condizione e cultura giovanile raccogliendoli attorno all'immagine della «generazione della vita quotidiana» (Garelli). Il Q14, a sua volta, ha analizzato le diverse immagini d'uomo e filosofie della vita in circolazione, assumendole come punto di arrivo delle immagini d'uomo degli anni '60 e '70 e come ricerca faticosa di nuovi modi di essere per uscire dall'attuale crisi culturale (Nanni). In questo quaderno, infine, G. De Nicolò esamina l'evolversi, a partire dagli anni '60, delle forme di aggregazione giovanile in genere e le diverse forme di associazionismo giovanile ecclesiale negli stessi anni.
^ Perché questo quaderno? Il nostro progetto di animazione vede nel «piccolo gruppo» il luogo privilegiato dell'animazione e dell'educazione alla fede. Esso è un «mondo vitale» entro il quale il giovane nel soddisfare i bisogni di identità, certezza, amore, sicurezza, trova nutrimento e forza per sviluppare le sue potenzialità e per confrontarsi, senza esserne fagocitato ma anche senza rifiuto pregiudiziale, con la cultura e le sue elaborazioni, con la comunità ecclesiale e la sua esperienza di fede. Non vogliamo però parlare del gruppo in termini astratti magari andando a ripescare dai classici manuali di dinamica di gruppo. Sarebbe troppo poco. Ci sono alcuni «fattori» di gruppo che vanno tenuti presenti perché contribuiscono a caratterizzare il «volto» del gruppo giovanile oggi. Il primo è da ricercare nella natura storica di ogni forma aggregativa. Ogni aggregazione, anche il gruppo giovanile, è frutto non solo del bisogno di identità psicologica, ma anche di una interazione tra giovani e società, giovani e cultura. Il secondo fattore è da ricercare nello scambio» tra aggregazioni giovanili in genere e aggregazioni giovanili ecclesiali. £ facile riconoscere che i gruppi giovanili ecclesiali sono più simili ai gruppi dei loro coetanei che ai gruppi di adulti nella comunità cristiana... In base a questo fattore, è importante, per capire i gruppi giovanili ecclesiali, metterli a confronto con quelli giovanili in genere dello stesso periodo. Il terzo fattore è da ricercare nella diversa configurazione che i gruppi vengono ad avere se si inseriscono in associazioni e movimenti ecclesiali ufficiali (Azione Cattolica, per esempio), oppure se vengono ad ingrossare le fila della cosiddetta «associazione invisibile» (Quaranta). Se fino a qualche anno fa il gruppo spontaneo sembrava quello vincente, oggi l'associazionismo nazionale è in forte ripresa. Ne deriva una certa tensione tra i gruppi e le associazioni / movimenti e la necessità di trovare «puntifermi» comuni.
^ Muovendosi dentro questi «fattori», il quaderno si propone tre obiettivi. Il primo obiettivo è offrire un tracciato storico evolutivo dei vari modelli di gruppo e associazione dagli anni '60 ad oggi. Per ogni periodo si precisano le principali caratteristiche aggregative. Tuttavia l'autore non si limita ad una sua lettura dei fatti. Mari mano che procede, sollecita il lettore ad una personale interpretazione con l'aiuto di alcune tipologie applicabili «in situazione». Questo è il secondo obiettivo. Il terzo obiettivo è la messa a fuoco dei nodi e sfide educative dell'attuale prassi associativa giovanile ecclesiale. A questi nodi e sfide, ma anche alle intuizioni positive dell'attuale momento associazionistico, si ricollegherà la riflessione sull'animazione e sulla educazione alla fede, soprattutto al momento d'individuare le strategie di intervento.
1. SOCIALIZZAZIONE E AGGREGAZIONISMO OGGI IN ITALIA
Introduzione
Questo quaderno dell'animatore «aggregazione giovanile e associazionismo ecclesiale» tenta di leggere ed interpretare il fenomeno in questione da un suo particolare punto di vista.
Anzitutto, da quale prospettiva non si colloca.
Non da quella psicologica: e cioè dall'esame delle caratteristiche degli individui che portano all'aggregazione, che maturano all'appartenenza, che entrano nelle dinamiche dell'inculturazione e socializzazione...
Non da una prospettiva psicosociologica: la considerazione delle dinamiche di gruppo e di interazione, i fenomeni della leadership, la formazione del consenso e del dissenso, la diversa tipologia dei gruppi rispetto alle esigenze psicologiche dei partecipanti...
Non viene considerata nemmeno la prospettiva tipica dell'animazione: il gruppo o movimento come luogo di comunicazione, educazione, animazione...
E nemmeno da una prospettiva più propriamente teologica: a quali condizioni l'esperienza di appartenenza e aggregazione ecclesiale può diventare esperienza di chiesa; come matura la fede nel gioco dei dinamismi psicologici di interazione gruppo/membro, membri fra di loro, gruppo/istituzione ecclesiale...
E nemmeno, per ultimo, nel senso inteso in A. Favale, Movimenti ecclesiali contemporanei, Las, Roma, 1982: cioè una storia e considerazione critica dei movimentiassociazioni più significativi presenti oggi nella chiesa.
La prospettiva da cui si colloca il presente quaderno è quella storicosociologica.
Sociologica nel senso di un tentativo di interpretazione, attraverso tipologie, dei modo con cui gli appartenenti vivono e sperimentano la loro socializzazione, oggettivamente e soggettivamente, in una aggregazione.
Storica nel senso che questo fenomeno viene calato nel contesto della società italiana degli ultimi anni.
Uno studio approfondito, che rientrerebbe negli ambiti di una più allargata sociologia della conoscenza, vedrebbe il modo con cui sono costruiti e interiorizzati, all'interno del fenomeno aggregativo, gli universi di significato o il sistema di valori propri di una cui cultura o subcultura come vengono istituzionalizzati i rapporti e le relazioni reciproche, come viene «routinizzato» il carisma iniziale, come vengono conservati e difesi attraverso svariate procedure i sistemi interiorizzati, come viene letta e interpretata la realtà, come si struttura l'identità individuale e collettiva...
Tutti elementi di un discorso sociologico, che però vengono qui soltanto accennati, mancando studi sperimentali approfonditi al riguardo.
Vengono tuttavia dati alcuni elementi, soprattutto attraverso delle tipologie, che renderebbero possibile indagare più a fondo nel fenomeno associativo, non solo ecclesiale.
1.1. Aggregazione: un fenomeno consistente e significativo
Che l’analisi della condizione giovanile non possa prescindere dalla considerazione dell'importanza che in essa svolge l' «associazionismo», appare una cosa ovvia e scontata.
Ciò è rilevato anche nelle ricerche più recenti sui giovani, sia che ne tentino una descrizione e interpretazione più globale, cioè riferita all'insieme della loro vita quotidiana, sia ad aspetti più tipici di essa, come la religiosità, la partecipazione (o meglio orientamento) politico culturale, il sistema di valori.
La variabile «associazionismo», cioè, entra in maniera significativa a determinare la qualità stessa del vissuto e della cultura giovanile, e talvolta sembra essere elemento determinante di atteggiamenti o comportamenti di fondo dei giovani stessi.
Essa in più viene ad essere considerata particolarmente interessante e utile per verificare e comprendere le dinamiche stesse e i processi di mutamento dell'intera società.
Infatti essa può essere la spia non solamente di un certo grado di socializzazione giovanile, ma l'indicatore di quella globale sfiducia (o distacco o ravvicinamento selettivo) che sembra da alcuni anni aver investito le forme di partecipazione giovanile, o di quel prevalere di una logica di particolarizzazione degli interessi presente in varie aree dei sociale, o di una nuova sensibilità emergente, anche nel sociale, che tenta una mediazione (una «transazione») tra istanze di personale e istanze di pubblico.
Per giungere a una globale interpretazione sociologica occorre passare attraverso i dati delle ricerche, un esame delle tipologie che si possono costruire, la storia dell'associazionismo stesso.
È un esame che verrà condotto soprattutto attraverso la considerazione dell'associazionismo organizzato, come fenomeno più significativo: esaminare ogni forma di associazionismo, a cominciare dal più spontaneo, informale, non strutturato, significherebbe infatti disperdersi in una realtà troppo vasta, incontrollabile, e che in definitiva non direbbe nulla di nuovo di quanto ci si aspetterebbe dallo studio sociologico e psicologico della socializzazione.
Affermare l'importanza dell'aggregazionismo è dire una cosa scontata, dal momento che i luoghi e i modi della socializzazione sono diventati oggi, al di fuori di quelli tipici del passato (scuola e famiglia), quelli aggregativi.
L'associazionismo spontaneo, non organizzato, interessa infatti la totalità dei giovani, o attraverso un gruppo di amici fissi, o attraverso amici che pur non costituiscono gruppo. Si tratta in genere, secondo le ricerche, di gruppetti di dimensione non elevata, una quindicina di persone in tutto, ma che sono veri e propri laboratori di vita e di esperienza, e quindi di formazione dell'identità.
Rilevante tuttavia è anche l'associazionismo organizzato.
Circa la sua quantità globale, le ricerche più recenti, condotte in varie aree nazionali, parlano di una realtà che interessa quasi il 30% della popolazione giovanile. Il che significa che poco meno di un terzo dei giovani italiani vive la sua socializzazione all'interno di gruppi o associazioni o movimenti di vario tipo.
È un dato che esprime già di per se stesso la globale significanza e consistenza della realtà aggregativa giovanile, dal momento che interessa una quota assai ampia, e come vedremo, molto significativa dei giovani, se pur non maggioritaria.
1.1.1. Alcuni dati iniziali
Un profilo socioanagrafico dei giovane italiano aggregato potrebbe rilevare la prevalenza dei maschio rispetto alla ragazza (rispettivamente il 55% e il 45%), fatto probabilmente imputabile al maggior controllo della famiglia; di un'età oltre i 18 anni (quasi il 60%: il che denota la preferenza di relazioni di altro tipo nei giovanissimi); di una migliore situazione sociale, che risulta quindi essere precondizione favorevole al fatto associativo (il che non preclude la presenza di altri soggetti di condizione sociale «mediobassa»).
Quanto alla distribuzione tra i differenti tipi di associazione, proponiamo come sufficientemente indicativi, in prima approssimazione, i seguenti dati, ricavati dalla ricerca GiOC «1 giovani degli anni '80». La quota più ampia comprende gruppi ad interesse sportivo (9,4%), seguita da quelli religiosi (7,1%), da quelli educativi (3,3%), dai gruppi di interesse sociopolitico (4,2%), da quelli culturali (2,7%).
Già alcune annotazioni sarebbero possibili a un primo sguardo dei dati.
Anzitutto la forte crisi in cui sono caduti i gruppi che negli anni precedenti (e non troppo lontani) infoltivano le schiere politiche: è un continuo calo, rilevato da tutte le analisi di tipo quantitativo, una globale non tenuta dell'associazionismo legato alle forze politiche e, indicativamente, anche un calo delle forme di gruppi legati a tematiche di tipo sociale impegnato. Lo stesso succede per il cosiddetto associazionismo non tradizionale, come i gruppi spontanei o dei dissenso, che mescolano nelle loro motivazioni elementi politici sovente intrecciati a fattori personali.
Quasi in opposizione, risulta invece una tenuta (o una notevole ripresa) dei gruppi a tonalità religiosa: il che è ovviamente da interpretare.
1.1.2. L'area degli interessi: il personale
Un altro dato caratteristico dell'associazionismo giovanile in genere, globalmente si può descrivere come uno spostamento di interessi verso l'area dei personale. La citata ricerca GiOC annota come circa il 40% dei giovani affronta in gruppo problemi legati soprattutto a tematiche di realizzazione personale e di rapporti interpersonali. Quote molto minori affrontano prioritariamente problemi attinenti al lavoro e allo studio, o problemi di tipo sociale, politico, religioso.
Lo stesso dato può essere rilevato se si ricerca la modalità con cui all'interno dei vari gruppi si vive l'esperienza associativa e si interpreta l'appartenenza.
Prendiamo, per esempio, l'indagine Milanesi sulla domanda religiosa dei giovani (Oggi credono così, LDC Leumann, 1981).
Assumiamo, per semplificazione, una distinzione tra gruppi «religiosi», che operano in ambito religioso ecclesiale, e gruppi «profani», che hanno scarsi o minori contatti con l'ambiente religioso.
Ora, i gruppi di tipo «religioso» accentuano molto l'interesse attorno all'area dei personale: essi sembrano spinti all'appartenenza da motivazioni riconducibili al bisogno di solidarietà, di relazione, di affrontare i problemi dei significato che la vita pone.
Ma anche i gruppi «profani» sono in gran parte ispirati, oltre che, com'è ovvio, da motivazioni più specificamente legate al «motivo di aggregazione», e quindi al bisogno di azione, di protagonismo socioculturali e politico, anche da motivazioni attinenti all'area dei personale: bisogno di relazione, di solidarietà ed amicizia.
Questo conferma i processi di mutamento dell'area associativa, nel passaggio dallo specificamente politico e sociale allo specificamente personale, oltre che a sottolineare la rilevanza essenziale dell'associazionismo in genere, dei pari in specie, per la socializzazione dei giovani e la ricerca della loro identità. Questi primi dati ovviamente sono la descrizione approssimativa di una realtà molto differenziata, e non dicono molto se non sono collegati ad una descrizione della qualità del fenomeno stesso, che è da leggersi all'interno di una interpretazione della socializzazione giovanile, non solo in generale, ma storicizzata nella forma della società che è l'Italia degli anni settanta e ottanta.
1.2. La socializzazione nell'Italia degli anni '70 e '80
Quanto verrà detto in questo para grafo potrà risultare un po’ difficile e complicato: e del resto è un discorso tecnico, dal momento si rifà alle discipline della psicologia e della sociologia . E tuttavia risulta necessario sia per un apprendimento dei vocabolario di base, sia per comprendere i meccanismi di fondo. che in ultima analisi portano al fenomeno che stiamo considerando, l’aggregazionismo, sia per valutare i mutamenti intervenuti negli ultimi anni.
1.2.1. La socializzazione: essere individui nella società
Offriamo ora pertanto una serie di definizioni e di affermazioni sulla socializzazione e sui suoi processi.
Socializzazione è l'insieme dei vari processi mediante i quali un individuo impara a diventare membro della società. È, se si vuole, l'imposizione di modelli sociali sul comportamento.
La socializzazione non è un fenomeno indifferente o poco importante: è la garanzia della sopravvivenza della società, della possibilità che una società possa trasmettere il patrimonio culturale accumulato nel tempo; ed è la garanzia dell'esperienza sociale dell'individuo. Ora, l'esperienza sociale di un individuo è globalmente la sua vita stessa, dal momento che la maggior parte delle esperienze delle persone è di tipo sociale, e anche quelle non direttamente sociali sono mediate e modificate dagli altri.
Assumendo l'importanza della socializzazione, come processo che permette la trasmissione dei patrimonio della società negli individui, e contemporaneamente l'ingresso dell'individuo nella società, quali sono i meccanismi con cui ciò avviene?
Le scienze della psicologia e della sociologia mostrano con chiarezza i meccanismi della socializzazione: quello fondamentale è il processo di interazione e di identificazione con gli altri.
È in questi processi che si impara ad assumere l'atteggiamento dell'altro (ed il significato di esso fino a farlo proprio imprimendolo fermamente nella coscienza) e ad assumere il ruolo dell'altro.
In questo processo si attua un passaggio dall'interazione (e identificazione) con gli «altri importanti» all'interazione (e identificazione) con «l'altro generalizzato», che rappresenta la società nel suo complesso. Questo è un passo cruciale della socializzazione: il mondo sociale, con le sue leggi, norme, significati, proibizioni, viene interiorizzato nella coscienza, vissuto non più come esterno ma come interno all'individuo, e viene così stabilita una certa simmetria tra il mondo sociale esterno e il mondo interiore dell'individuo. Nel processo di interiorizzazione si percepisce e interpreta un evento oggettivo come avente significato, cioè come manifestazione di processi soggettivi di un altro che diventa soggettivamente significativo per l'individuo stesso: essa è quindi la base di una comprensione dei propri simili, e della percezione dei mondo come una realtà significativa e sociale, e in definitiva, della capacità di scoprire se stessi, la propria identità. Evidentemente il processo di interiorizzazione inizia con la socializzazione primaria, certamente la più importante e definitiva nella vita di un individuo per la presenza emotivamente forte di persone che gli mediano significati e realtà.
Dire che la socializzazione primaria è importante è dire cosa ovvia.
Essa infatti ha luogo nella prima infanzia. quando la plasticità dell'individuo è massima, aperta a tutte le possibilità, quando l'individuo è totalmente dipendente dagli altri, quando le figure che lo circondano e gli mediano l'esperienza hanno per lui una grande carica emotiva e vitale.
L'ambiente in cui avviene questo processo è la famiglia: e non la famiglia in astratto, ma la famiglia storica: cioè che vive in una determinata società e cultura, che ha una certa provenienza sociale, che vive di certi lavori e in certi rapporti coi mondo dei lavoro, ecc.
Il mondo comunicato e interiorizzato è un mondo base, con certi atteggiamenti di fondo e radicali, un alto grado di stabilità e fermezza. Esso si presenta quasi come inevitabile. non può essere troppo facilmente mutato (ciò è possibile forse solo nel caso di «conversioni», per esempio di tipo religioso, o politicoradicale: queste però a loro volta nascono e si sviluppano in un ambiente che assume di nuovo forme e caratteristiche «forti» di socializzazione «primaria», ad alta carica emotiva, con un forte grado di identificazione).
Globalmente comunque si può dire che la socializzazione primaria termina quando il concetto dell'altro generalizzato è instaurato nella coscienza dell'individuo, per cui a questo punto egli è un membro effettivo della società e ha il possesso soggettivo di un'identità e dei mondo.
Ma esiste anche una socializzazione cosiddetta secondaria, ed è l'interiorizzazione di «sottomondi» legati ad un'istituzione. Essa indica tutti i processi successivi attraverso i quali un individuo viene ammesso in un mondo sociale specifico, nell'assunzione di ruoli legati ad una situazione sociale specifica, come è per esempio il mondo della scuola, dei lavoro, il mondo di nuovi rapporti sociali, le attività dei tempo libero, le amicizie...
Normalmente tutti questi processi non hanno l'intensità della prima socializzazione, non essendo carichi di quella intensità emotiva tipica della prima infanzia. Questi nuovi mondi sociali non hanno quindi il carattere di certezza e di stabilità dei mondobase, ma sono egualmente interiorizzati attraverso i medesimi processi di interazione e di identificazione. Si assumono in tal caso, attraverso i ruoli, valori e norme che strutturano le interpretazioni e le condotte nuove legate ad essi. In una parola, anche questi sottomondi sono realtà più o meno dotate di coesione, caratterizzate da componenti normative ed affettive, oltre che cognitive.
Dalla famiglia al gruppo
Dove avvengono oggi soprattutto le pratiche di socializzazione nel mondo giovanile?
E quale rilevanza assumono quelle di socializzazione secondaria?
Nel paragrafo successivo leggeremo la storia italiana degli ultimi anni (e la pratica di vita delle nuove generazioni), come tentativo di risposta a queste domande.
Ma un indizio lo possiamo già rilevare nell'andamento delle tematiche affrontate dagli studi sulla socializzazione che leggono e interpretano la realtà giovanile.
Fino a poco tempo fa, gli studi sulla socializzazione avvenivano soprattutto nella direzione della individuazione, all'interno della socializzazione primaria, dei fattori di innovazione e di quelli di conservazione, dei dibattiti sulla trasmissione ereditaria o sull'apprendimento, sulla relazione tra socializzazione e classi sociali (e quindi sul rapporto tra struttura sociale e formazione della personalità). E quindi le ricerche vertevano sulle classi sociali, soprattutto media e operaia, nella ricerca del rapporto tra classe di appartenenza, pratiche di socializzazione e valori (e stili di vita, modalità di linguaggio) appresi.
La conclusione era che la socializzazione primaria, ad opera soprattutto della famiglia di origine, non fosse altro che lo strumento principale della riproduzione della disuguaglianza sociale.
Ma oggi la ricerca si sposta soprattutto sulla socializzazione secondaria, dal momento che si è constatato che, soprattutto per l'analisi della condizione e cultura giovanile, hanno sempre minor importanza i fattori relativi alla famiglia di origine e alla classe di appartenza.
Infatti, nonostante la presa di coscienza della differenziazione regnante all'interno della condizione giovanile stessa, si individuano tratti di omogeneità tra i giovani, al di là delle diverse appartenenze sociali, e si vedono le origini nelle pratiche di socializzazione secondaria: in una parola, nella scuola e nella aggregazione giovanile. Però per non rischiare di fare soltanto un discorso formale e generico, tutte queste osservazioni sono da storicizzare, cioè da calare nel contesto della società italiana degli anni '70 e '80, e da leggersi all'interno di quella che è stata chiamata la crisi degli apparati di formazione e la socializzazione dal basso.
1.2.2. Italia anni '70: crisi degli apparati della famiglia e della scuola
Secondo Bassi-Pilati (1 giovani e la crisi degli anni settanta, Editori Riuniti, Roma, 1978), bisogna riandare agli inizi degli anni settanta per comprendere la mutazione avvenuta nei processi di socializzazione, e la nascita di nuove soggettività e di nuove forme di socializzazione.
Il punto di partenza sarebbe la modificazione dei rapporti di produzione (e cioè dei processi produttivi e dei mercato dei lavoro). La causa è ovviamente tutta la serie di trasformazioni strutturali dell'Italia degli anni '70. Ora, si sa che è soprattutto il rapporto con il lavoro (la posizione nel processo di lavoro e i modi di questa posizione) che definisce le basi di sviluppo dell'esperienza, soprattutto dell'esperienza sociale, con tutta la serie di rapporti che si creano con la socialità organizzata dei mondo della conoscenza e dei lavoro. Modificato sostanzialmente il rapporto con il lavoro, si modifica sostanzialmente l'esperienza sociale dell'individuo. A questa modificazione è da collegarsi la crisi degli stessi apparati di produzione ideologica (scuola, famiglia, apparati di comunicazione).
L'analisi potrebbe essere condotta sia in riferimento alla crisi della scuola, al suo progressivo isolamento dalla realtà sociale, alla sua ghettizzazione e riduzione ad area di parcheggio, per lo scadimento dei contenuti formativi, di conoscenza, il distacco dal mondo dei lavoro. Era una evidente conseguenza l'impoverimento anche dei contenuti di esperienza sociale, l'impoverimento dei rapporti sociali, la mancanza di criteri offerti per la valutazione delle conseguenze dell'agire e quindi della responsabilità. Ma un'analisi altrettanto valida potrebbe essere condotta a riguardo della crisi dell'altro grosso apparato di produzione ideologica e quindi della socializzazione: la famiglia. Essa, nel corso degli anni '70 (soprattutto la famiglia della fascia urbana, ristretta, orientata al consumo, isolata), perde la capacità di socializzare nella forma dei pubblico, e quindi di allargare la soggettività dei suoi membri in un confronto arricchente con la socialità organizzata; diventa unicamente luogo di consumo privato, repertorio di servizi, e finisce con il far diventare l'isolamento dai rapporti sociali anche isolamento sociale dei rapporti dentro la famiglia stessa.
Le conseguenze della crisi della scuola e della famiglia, per quanto riguarda il mondo giovanile, sono di enorme portata, e si assommano producendo una trasformazione globale dei processi di socializzazione dei giovani.
La socializzazione spontanea e dal basso
La prima conseguenza può essere intravista nella costituzione di forme di socializzazione spontanea: «Si forma tutta una serie di programmi dell'agire (il senso dell'avventura, il disimpegno verso il futuro, l'atteggiamento strumentale verso la socialità organizzata vista essenzialmente come deposito di risorse cui attingere) che prescindono dall'influenza e dai vincoli delle organizzazioni...
La soggettività, con i processi di autocostruzione, di socializzazione selvaggia, cresce d'importanza, si gonfia, ma è una crescita malata, nutrita di miseria organizzativa, non di ricchezza sociale».
La seconda caratteristica dei nuovo tipo di socializzazione è di essere «dal basso», di radicarsi in circuiti non istituzionali, di organizzare la soggettività in forme diverse che dal passato. Volendo si possono tracciare due linee di sviluppo, due versanti di versi in cui vengono canalizzate le soggettività: un primo versante che si integra a forze sociali organizzate, caratterizzate da una lunga tradizione di formazione sociale (sindacato, partiti, comunità religiose) e un secondo versante che rifiuta la mediazione delle forme sociali e sceglie di svilupparsi secondo modi autonomi dentro circuiti sociali di più ristrette dimensioni: il gruppo in un primo tempo, le diverse forme di associazione poi dopo la svolta dei '74'75. «Nel primo caso una socializzazione non istituzionale ma organizzata entro tradizioni profonde, definita da valori e vincoli sedimentati da un'estesa storia collettiva; nel secondo caso una socializzazione spontanea, estranea alla tradizione, che cerca di costruire da se il proprio sistema organizzativo, selezionando direttamente nell'agire valori e vincoli».
La trasformazione dei processi di socializzazione apre l'interrogativo sui modi di formazione della soggettività: essa infatti deve principalmente confrontarsi con gli impegni della determinazione dei modi di impiego dei tempo individuale, con la definizione di forme di rapporto sociale tra ì membri del gruppo e gli esterni, con la costituzione di un'identità culturale capace di unificare il mondo giovanile, le sue opzioni e comportamenti.
Il ritmo del desiderio e dei bisogni
Negli anni '70 prevale allora l'uso del tempo modulato non più dalle richieste sociali fissate dall'esterno, ma sulla base della scelta individuale (e al ritmo della responsabilità si sostituisce quello dei desiderio, un tempo ritmato sulla concretezza dissociata dal progetto, sulla dissipazione). Prevalgono ancora una forma di individualismo nei rapporti sociali, fatto di narcisismo o di rassicurazione nei confronti dei gruppo o di fuga; una perdita dei quadro di valore capace di dare identità culturale, pur nella spasmodica ricerca di un linguaggio comune imposto come terreno di scambio e di integrazione tra i diversi gruppi,
Per un periodo non breve i diversi processi di socializzazione dal basso rimangono privi di un punto di riferimento culturale unitario.
Al massimo, alcuni spezzoni di cultura sembrano essere unificati, se pur in ambito ristretto, dalla cultura pop e, in ambito più propriamente politico, dalla cultura dei maoismo.
Lungo il '76 comincia ad imporsi come linguaggio comune la teoria dei bisogni, che riesce ad unificare, entro un medesimo linguaggio, esiti di provenienza eterogenea (proletariato giovanile, movimento femminista, di ambito studentesco, l'area dell'autonomia).
Essa m sostanza afferma che nella disgregazione della socialità che il soggetto avverte come radicale negazione della sua esistenza, il desiderio è il fondamento di valore che gli rimane, e si traduce in una volontà di realizzarlo, di portare a compimento il bisogno, non nei termini di una trasformazione dei rapporto sociale, ma dei mondo interno.
La teoria dei bisogni diviene la teoria dei riconoscimento della soggettività, l'autoriflessione della socializzazione dal basso, la teoria che ricostruisce nuovi percorsi di vita, di forme dell'esistenza.
1.2.3. Italia anni '80: nuovi luoghi e modi di socializzazione
Finora abbiamo considerato il processo di socializzazione «secondaria» non in astratto, ma storicizzandolo, cioè collocandolo nel periodo degli anni settanta: e soprattutto visto come variabile a diretto contatto con la situazione strutturale e culturale della società italiana.
Ma già alla fine degli anni settanta si notava una certa inversione di tendenza, o meglio una nuova modalità delle forme della socializzazione e un nuovo tipo di aggregazionismo, non più modellato, come precedentemente, su una forma selvaggia ed eccessivamente spontaneistica.
Notano infatti le ricerche sociologiche, come quella di Ricolfi - Sciolla (Senza padri ne maestri, De Donato, Bari, 1980), che i nuovi luoghi e modi della socializzazione, mentre si confermano essere al di fuori della famiglia, e di tipo orizzontale, non si attuano però nelle forme spontaneistiche precedenti.
«Alla famiglia come centro dei processi di socializzazione si è andata progressivamente sostituendo una struttura policentrica di cui la scuola e le diverse forme di aggregazione di tipo generazionale dalle più fluide e informali alle più istituzionalizzate costituiscono gli elementi portanti...
Ma il cambiamento investe anche i modi, oltre che i luoghi, della socializzazione, cioè i meccanismi attraverso cui i modelli culturali si costituiscono: ad una trasmissione di tipo verticale dai padri ai figli, da generazione a generazione - tende a sostituirsi un altro tipo di trasmissione, che procede per linee orizzontali, da una leva giovanile all'altra. Anzi, più che di 'trasmissione', a questo punto, occorrerebbe parlare di 'interazione': il fatto che la trasmissione avvenga lungo linee orizzontali, in cui prevalgono le relazioni tra pari, fa sì che la trasmissione stessa non sia più riducibile a mera riproduzione di modelli dati, ma possa anche funzionare come produzione di contenuti nuovi».
Un'annotazione merita di essere fatta circa la posizione della famiglia nella socializzazione dei giovani.
I giovani effettivamente hanno attuato un riavvicinamento alla famiglia, così che essa non può essere considerata, come anni fa, luogo della conflittualità permanente, luogo di contrattazione e repertorio di servizi, fabbrica preposta al ricambio organico.
La famiglia per i giovani oggi torna ad essere rivalutata per la sua funzione affettiva, per la stabilità che essa offre.
Non si tratta però di un rapporto di tipo tradizionale nel quale la famiglia riprende la sua funzione di trasmissione dei valori in cui i giovani si identificano. Di fatto ora i giovani sperimentano molteplici appartenenze sociali, e il luogo forte, considerato lo spazio specifico di identità e di appartenenza, non è più il rapporto familiare, ma si sposta su spazi aggregativi, come il gruppo degli amici, dei pari.
In tale modo nel processo di formazione dei valori, e in definitiva dell'identità dei giovani, assumono importanza sempre più cruciale elementi come l'associazione scolastica, le forme associative esterne alla scuola, l'esperienza lavorativa, che individuano rapporti e reti di relazioni relativamente autonome dalla famiglia e più in generale dai dati d'origine.
Le ricerche di questi anni sottolineano sempre quello che era sembrato un tratto nuovo e caratteristico degli anni precedenti, e cioè la socializzazione dal basso.
Questa però ora non agisce più in senso spontaneistico, troppo legato alla soggettività e individualità, ma appare maggiormente legata al movimento associativo e aggregazionistico nelle sue forme più diversificate, di tipo ecclesiale e non (culturale, sportivo, ricreativo, sociale), organizzato, cioè in qualche modo portatore di istanze capaci di mediare la soggettività verso la complessità sociale e istituzionale.
L'associazionismo si presenta allora, oltre che come esigenza naturale della socializzazione di sempre dei giovani, anche con la caratteristica di essere meno imposto e subito, cioè meno legato ad una socializzazione condotta secondo modelli impositivi, ma più come laboratorio di valori, di forme e stili di vita nuovi, più libero, condotto secondo modelli di tipo educativo, cioè di formazione libera e di scelta della propria identità e stile di vita. Esso diventa il luogo dove non solo vengono sperimentati i valori imposti, ma dove si cercano, si inventano e sperimentano valori nuovi, attorno a cui costruire se stessi e la propria identità.
Il mondo sperimentato si allarga sempre più; attraverso nuovi contatti e rapporti il piccolo mondo diventa più grande, e quindi portatore di conferme o disconferme, in ogni caso arricchente.
2. I GRUPPI E I MOVIMENTI GIOVANILI ECCLESIALI
2.1. L'associazionismo ecclesiale: una forte ripresa
Si notava precedentemente, come di passaggio, la forte ripresa, l'espansione dei gruppi e movimenti che operano in ambito ecclesiale. Questo non significa ovviamente non riconoscere la consistenza dell’ associazionismo non confessionale, di gruppi operanti in ambiti non religiosi. Tuttavia i gruppi religiosi (non tutti) paiono presentare una singolare vitalità che, se è certamente amplificata dalla situazione di stallo o di crisi delle proposte associative dell'area laica o di sinistra, non può non essere rilevata come degna di nota.
2.1.1 Le caratteristiche della ripresa
Questo risulta tanto più notevole quando si guarda il panorama dell’ associazionismo in prospettiva diacronica, storica.
Al crollo dell’associazionismo confessionale istituzionale riscontrato alla fine degli anni '60 fino alla metà degli anni ’70 , dopo il lungo periodo di egemonia associativa dell'area confessionale (periodo caratterizzato da un contesto di grande integrazione sociale e identità culturale) segue, infatti nei nostri anni, un periodo di forte ripresa e consolidamento dei gruppi religiosi a livello giovanile. Una ripresa però non di tipo totalizza come trent'anni fa, perché oggi il giovane è esposto a una grande pluralità di proposte, di esperienze. Infatti l'esperienza sociale (anche dei giovani) appare essere conseguenza di una pluralizzazione dei mondi di vita, come di cono i sociologi, o una interiorizzazione dello stato complesso e differenziato della società odierna. E da notare comunque una caratteristica, che qualifica ulteriormente il quadro associativo ecclesiale, e che deve essere in qualche modo interpretata. La diversità è circa la forte polarizzazione odierna su contenuti religiosi. E ovvio che le tematiche religiose sono centrali in gruppi di tipo religioso/ecclesiale; ma mentre nel passato la dimensione sociale appariva preminente(gruppi terzomondisti, sociali, assistenziali) o aperta a dimensioni politiche e di contestazione ecclesiale (gruppi dei dissenso, comunità di base, cristiani per il socialismo), appaiono oggi in espansione soprattutto i gruppi in cui il problema religioso, l’ interesse educativo,è strettamente collegato al bisogno di relazione, di solidarietà a problemi circa l'identificazione e la socializzazione. Questo sia attraverso la priorità attribuita alla vita interna dei gruppo, sia riscoprendo esplicita mente il riferimento religioso quale fattore formativo (preghiera, formazione religiosa, riproposta rituale, catechesi). Ciò è da mettere in relazione sia alla centralità delle tematiche dell'area dei personale, sia alle attuali condizioni sociali. Queste infatti richiedono l'elaborazione di risorse in grado di far fronte ai problemi dell'identità. Ciò spiega come oggi l'associazionismo giovanile ecclesiale si focalizzi maggiormente su problemi (di tipo religioso, ad esempio) capaci di ottenere da un lato una maggior selettività nell'appartenenza e dall'altro una maggior interiorizzazione dei contenuti. Un'ultima caratteristica da osservare è che non tutti i gruppimovimenti ecclesiali sono in ripresa, tua soltanto quelli dell'area neoistituzionale cioè quelli che si identificano con l'istituzione ecclesiale e che operano al suo interno. La ripresa infatti non sembra interessare i gruppi dei dissenso e della contestazione ecclesiale, che fino a qualche anno fa sembravano gli unici ad avere una qualche probabilità di successo e di sopravvivenza nell'arca ecclesiale. Oggi invece essi appaiono in grossa crisi, investiti come sono da problemi di identità e di funzione sociale. Ma nemmeno tutti i gruppi in raccordo con l'istituzione ecclesiale sono in ripresa: abbiamo accennato che tale ripresa non sembra interessare i gruppimovimenti di azione sociale e di impegno (nel campo della emarginazione, dei Terzo mondo, dell'assistenza ). Sono piuttosto i gruppimovimenti a specifica identità quelli che risultano in espansione, nel costituire uno spaziomomento in cui i giovani possono ridefinire la loro identità personale e sociale. Si notano tuttavia oggi nuovi segni di apertura all'azione nel sociale: come se la specifica identità dovesse ora ricercare anche al di fuori i suoi criteri distintivi.
2.1.2. Una prima interpretazione
Le caratteristiche della ripresa dell'associazionismo ecclesiale che abbiamo visto (la diversità dal passato, la polarizzazione su contenuti religiosi specifici, gruppi a specifica identità) non sono puri dati descrittivi: essi contengono già una loro spiegazione e interpretazione, che deve essere esplicitata.
Lo facciamo attraverso uno studio recente sull'associazionismo cattolico dalla seconda metà degli anni '70 (Franco Garelli, Gruppi giovanili ecclesiali: tra personale e politico, tra funzione educativa e azione sociale, in «Quaderni di Sociologia», 26 (1977), pp. 275-320).
Il punto di partenza è ancora l'analisi della realtà sociale e culturale: essa offre ai gruppi ecclesiali (a certi gruppi ecclesiali) la possibilità di proporsi come «area di ricomposizione» dell'esperienza dei giovani.
«In una realtà disgregata in cui sono presenti diverse e contraddittorie proposte culturali, in cui si riscontrano diversificati modelli di vita, in cui c'è carenza di valori assoluti, in cui la crisi di consenso sociale e la caduta delle speranze collettive pongono problemi di stabilità e di sicurezza, i gruppi ecclesiali possono rappresentare per molti giovani l'area in cui ricomporre la propria esperienza, ritrovare una identità, maturare un senso di appartenenza, scoprire un luogo in cui radicarsi». O, come asserisce Milanesi nel suo studio sulla domanda religiosa dei giovani italiani, «l'associazionismo cattolico sembra indicare una più accentuata (ma non esclusiva) capacità di esso di rispondere ad aliquote minoritarie ma consistenti di consumatori (molti dei quali giovani) che ravvisano nei messaggi religiosi (e nei beni religiosi con essi scambiati) un fattore capace di restituire identità a chi subisce una crisi di valori radicale e a chi non è in grado di recuperare una minima razionalità entro le condizioni di vita odierne».
Per cui appare quanto mai plausibile il fatto che «nel pluralismo di forme associative che si presentano ai giovani come concorrenziali tra di loro, assumono particolare rilevanza quei gruppi/movimenti che nella proposta e nell'organizzazione che li contraddistinguono evidenziano il carattere di una "specifica identità", fattore questo che permette ai giovani di ridefinire attorno a tale identità la loro esperienza di soggetti sociali e la loro collocazione nel contesto socioculturale».
Tali gruppi/movimenti infatti, per le caratteristiche che presentano, aiutano i giovani all'orientamento tra le varie proposte in cui sono immersi.
Essi anzitutto sono in grado di costituire una «proposta forte» per il giovane in un contesto in cui il pluralismo culturale predispone al relativismo e allo scetticismo. In qualche modo essi sono totalizzanti, in grado di porsi all'attenzione dei giovani per il loro carattere fortemente propositivo, emergendo in tal modo di fronte alle molte altre proposte che il giovane ha di fronte. La loro forte propositività è individuabile nel fatto che essi fanno leva su alcuni obiettivi o valori espressi in modo netto, chiaro, inequivocabile, talvolta radicale, che li rendono specifici e diversificati rispetto ad altre proposte: siano essi l'istanza educativa, o religiosa, o il richiamo allo specifico cristiano, o al carattere profetico e spirituale della presenza nel mondo.
Nel modo diverso di distinguersi e di specificarsi, e talora di contrapporsi alla società, questi gruppi/movimenti rappresentano un luogo momento in grado di offrire ai giovani la possibilità di ridefinirsi e di ritrovare identità e stabilità.
Un altro motivo è che essi sono organizzati in modo da far pervenire la loro proposta a quanti più soggetti riescono ad avvicinare: essi allargano alle masse il raggio di proposta del messaggio e delle finalità che li caratterizzano, senza rinchiudersi in una logica d'élite, senza limitare la loro attenzione a particolari strati e gruppi giovanili. Sulla capacità di riposta ai problemi del personale si è già accennato.
Essi poi appaiono a misura del giovane in quanto rivelano quel carattere educativo che è sempre stato distintivo dell'associazionismo ecclesiale istituzionale: in esso i giovani possono trovare alcuni impegni graduali rispondenti alla loro esigenza di formazione e di orientamento, di progressiva assunzione di responsabilità, e nei quali possono far fronte agli impegni rispondendo anche a quelle legittime istanze di socializzazione tipiche della condizione giovanile (interazione tra i sessi, gruppo dei pari, rapporti primari gratificanti).
Essi inoltre non si limitano a offrire proposte «razionalmente» significative ma, nell'offrire la possibilità di fare un'esperienza, rappresentano un luogo in cui i concreti problemi dei giovani possono essere avviati a soluzione.
2.2. Alcune distinzioni sociologiche
Finora abbiamo parlato quasi in differentemente di gruppi, movimenti, associazioni, raggruppando tutto sotto lo stesso fenomeno del l'associazionismo.
Occorre ora passare ad una differenziazione specifica, perché il loro uso non ingeneri confusioni e non vengano ulteriormente intesi come sinonimi. Appunto perché essi propongono diversi modelli di appartenenza, di cui alcuni si escludono reciprocamente (associazione e movimento), altri possono coesistere nello stesso soggetto a diversi livelli (gruppo e associazioni, gruppo e movimenti).
La definizione proposta è di tipo sociologico.
2.2.1. Gruppo, associazione, movimento
Riprendiamo da un quaderno precedente le seguenti distinzioni. L'associazione presenta ordinariamente le seguenti caratteristiche:
- struttura organica e «istituzionale», definita da uno «statuto»;
- adesione dei membri, che avviene per condivisione degli scopi e degli impegni statutari;
- adesione formale da parte dei membri, in base alle norme statutarie;
- stabilità e autonomia (relativa) dell'associazione in quanto istituzione, al di là del variare dei membri;
- attribuzione delle cariche associative in base a criteri formali prestabiliti dallo statuto.
Il movimento è in genere così caratterizzato:
- alcune «ideeforza» e uno «Spirito comune» fanno da elementi aggreganti più delle strutture istituzionali;
- spesso l'aggregazione avviene o almeno inizia attorno alla figura e alla proposta di un leader;
- più che in uno statuto, ci si riconosce in una «dottrina» e in una «prassi», fortemente caratterizzanti, che tendono a diventare una «spiritualità»;
- l'adesione non è formale ma vitale: il movimento sta sull'adesione continuamente rinnovata dei membri, senza iscrizioni o tessere.
Il gruppo è di solito qualificato da:
- una certa «spontaneità» di adesione e di permanenza da parte dei membri;
- una certa omogeneità anche«affettiva»;
- grande libertà di autoconfigurazione quanto a scopi, struttura, attività del gruppo, e quindi tendenziale non uniformità tra gruppo e gruppo;
- dimensioni relativamente ridotte e diffusione piuttosto limitata;
- talora un certo riferimento comune a una «figura» o a un «valore» identici. Cfr Riccardo Tonelli, Q931 gruppo giovanile come esperienza di chiesa.
2.2.2. Gruppo di appartenenza e gruppo di riferimento
Un'ulteriore suddivisione, secondo diverse modalità organizzative del gruppo, può essere un primo criterio per la costruzione di una tipologia dei gruppi stessi.
La accenniamo solamente, perché la si troverà sviluppata in altri contesti, in altri quaderni dell'animatore.
Il gruppo di appartenenza: è un gruppo basato sui rapporti primari, sull'affettività, omogeneo per quanto riguarda l'età e le problematiche degli appartenenti, che impegna per lo più i membri ad un'assidua compresenza secondo una continuità che identifica l'appartenenza al gruppo con lo stare, l'esserci, il condividere spazio e tempo, il farsi compagnia.
I membri risultano allora fortemente coinvolti in termini di tempo, di rapporti, di risorse nella realtà associativa di cui fanno parte, vissuta come realtà totalizzante o fortemente impegnativa, in grado di dare senso al resto dell'esperienza personale e sociale.
È ovviamente un gruppo particolarmente adeguato per l'età adolescenziale, la quale sempre più avverte nel tempo presente l'esigenza di maturare una propria identità all'interno però del soddisfacimento di bisogni affettivi, relazionali, espressivi, amicali.
Il gruppo di riferimento: è un gruppo centrato sui rapporti di tipo «secondario», nel quale l'adesione poggia su aspetti, valori, largamente condivisi e interiorizzati dai membri, su una comune identità sociale e religiosa, su una sensibilità «affine». La specificità di un gruppo di riferimento è data anche dalla esigenza di confronto, di revisione comunitaria.
Esso sembra, oggi, il più plausibile da un punto di vista sociale, per la possibilità che offre di essere momento indispensabile di maturazione e di crescita, al di là di tutti i processi dissociativi a cui è esposta l'esperienza del giovane, e di maturazione anche di un'identità religiosa.
2.3. Verso una tipologia
Arrivati a questo punto del cammino, potremmo continuare lo studio intrapreso, utilizzando le categorie sociologiche appena riferite, in una descrizione dei vari gruppimovimentiassociazioni presenti oggi nella chiesa.
Si potrebbero presentare svariate schede, che offrano inquadramenti storici, fondamenti dottrinali, itinerari spirituali e tratti caratteristici, le linee metodologiche, e anche una valutazione critica.
E quanto è stato fatto per esempio dall'opera citata di Favale.
Si avrebbe così certamente un quadro organico, una mappa dell'associazionismo sul territorio nazionale, magari integrandola con altri studi a disposizione (per esempio Milanesi).
Sembra tuttavia più utile e più proficuo, sia da un punto di vista sociologico, che dell'animatore a cui sono diretti questi quaderni, tentare invece una tipologia capace di orientare dentro il mondo variegato e complesso dell'associazionismo ecclesiale.
Fare una tipologia vuol dire classificare un fenomeno in maniera sistematica basandosi sull'evidenziazione e sulla distribuzione di una combinazione di attributi che vengono prioritariamente tenuti in considerazione.
Basta pensare per esempio alla tipologia dei caratteri della persona umana, costruita sull'analisi combinata e differenziata di tre variabili (emotività, azione, risonanza). Il risultato è uno strumento utilissimo all'analisi, anche se, come tutti gli strumenti metodologici e concettuali, è da usare con un certo criterio: nessun movimento o gruppo rispecchia esattamente il «tipo» costruito, dal momento che la tipologia, per forza di cose, opera molte semplificazioni della realtà.
Ma centrare l'attenzione su alcune variabili che si vogliono considerare, e su cui si costruisce lo strumento, se da una parte non rende ragione della ricchezza di vita e di espressione di un movimento, dall'altra però permette di individuare i fattori che sono ritenuti capaci di interpretare e spiegare la realtà. E quindi in parte anche di prevederla.
2.3.1. Qualche criterio per la costruzione di una tipologia
Le notevoli difficoltà metodologiche legate alla costruzione di una tipologia sono in gran parte riconducibili alla scelta delle variabili ritenute così significative da spiegare il fenomeno in questione, e da rapportarlo ad altri eventuali fattori presenti nell'ambito sociale e culturale più ampio.
Esse infatti possono essere legate alla differenziazione di finalità, di contenuti trasmessi, di metodologie di reclutamento e formazione, di dinamiche di gruppo, composizione sociale, collocazione culturale e sociopolitica.
In ambito molto generale, e di prima descrizione (più che interpretazione) dell'intero fenomeno associativo, si può ricorrere, almeno inizialmente, ad un'unica variabile, attorno a cui suddividere il fenomeno: essa può essere «il motivo di aggregazione».
Esso creerebbe una tipologia suddivisa secondo i seguenti caratteri dell'associ azione: religiosa, politica, culturale, sportiva, sociale, educativa.
Si potrebbe ancora suddividere ulteriormente i gruppi, ottenendo un casellario più ampio, inserendo nuove suddivisioni secondo le seguenti caratteristiche:
- ispirazione (cristiana, laica, mista);
- struttura gerarchica (responsabili a vari livelli, eletti o nominati o riconosciuti senza procedure formali);
- organizzazione di base (a sviluppo nazionale, pluriregionale, regionale o locale);
- forma di adesione all'associazione (tesseramento o no, tipo di partecipazione ... ).

2.3.2. Una tipologia «descrittiva»
La tipologia che ora proponiamo è ricavata dalla ricerca Milanesi, precedentemente citata, sulla domanda religiosa dei giovani italiani.
Essa si articola in riferimento alla diversa concezione della realtà, ai rapporti con l'istituzione ecclesiale e ai motivi di aggregazione.
Tre variabili, dunque.
L'insieme di esse viene offerto in una tabella, che però è più di tipo descrittivo che interpretativo. Cioè non si chiede il perché, ma dice il come e il che cosa di questi gruppi movimenti.
Essa tuttavia è di grande utilità e offre una visione d'insieme organica e certamente interessante.
Circa la diversa concezione della realtà, quella personalistica (tipica di movimenti come i Gen, i Carismatici, i Neocatecumentali) si esplica da un lato nel primato della conversione individuale (il cambio sociale dipende da un processo di conversione personale), e dall'altro nella prevalenza di rapporti primari (risposta ai bisogni di identità, di integrazione sociale, affettiva, psicologica dei soggetti appartenenti al gruppo).
La necessità di un rapporto dialettico tra le istanze dei «personale» e le istanze del «sociale» è il fondamento su cui si basa la concezione mediazionistica della realtà: in questa direzione sono impegnati gruppi quali Comunione e Liberazione, l'Azione Cattolica, la FUCI, l'AGESCI.
Collettivistica è invece l'impostazione della riflessione di quei gruppi (Comunità di base, ecc.) che appartengono e si collocano nel Movimento sociale e, più in particolare, operaio, attuando una scelta di classe e un incontro con il marxismo, con i suoi strumenti di analisi e/o di «scienza» del cambiamento sociale.
Infine, nella concezione umanitariosolidaristica, la realtà viene vissuta e analizzata attraverso la verifica, nella società, della validità della propria ispirazione cristiana, in risposta ai bisogni dell'uomo emarginato e sofferente o di alcune categorie di emarginati, senza operare collettivamente una scelta di classe o un'analisi politica del fenomeno su cui si interviene in supplenza o in appoggio alle strutture pubbliche.
Diverso è quindi anche il rapporto dei singoli gruppi con l'istituzione ecclesiale (nel suo aspetto burocratico-formale).
Si può parlare di integrazione qualora il gruppo sia direttamente controllato o dipendente dalla gerarchia ecclesiastica, ed è il caso di grandi associazioni cattoliche come l'Azione Cattolica, la FUCI, Comunione e Liberazione, ma anche di altri tipi di aggregazione come i gruppi Gen, i Carismatici, i Neocatecumenali, la Lega Missionaria Studenti, i Ragazzi nuovi, il Movimento Eucaristico Giovanile. Più autonome sono invece quelle formazioni che, pur essendo inserite nell'area ecclesiale, non hanno un riconoscimento ufficiale da parte dell'istituzione Chiesa, che non determina perciò, con i suoi delegati, la vita dell'associazione. Ci si riferisce a gruppi come l'AGESCI, il Gruppo Abele, il CEIS, le varie organizzazioni terzomondiste.
L'isolamento caratterizza, infine, quelle aggregazioni in cui il riferimento religioso contribuisce a determinare un ulteriore motivo di divisione e di diversità, più che un fattore di unità, con la Chiesaistituzione. Riguarda soprattutto i gruppi dell'area del dissenso, in rapporto dialetticoconflittuale con la Chiesa.
Circa i motivi di aggregazione, possono essere ritenuti sufficientemente indicativi quelli individuati in precedenza.
L'insieme degli elementi che sono stati considerati possono essere raggruppati in una tabella che qui proponiamo (vedi pag. 14).
2.3.3. Una tipologia «interpretativa»
Proponiamo ora una tipologia (elaborata da Garelli nello studio citato) che, pur necessitando di qualche modifica e integrazione, si presenta ancor oggi particolarmente valida.
Essa, a differenza delle altre più sopra presentate, oltre che descrittiva è di tipo interpretativo, perché le variabili considerate pongono in relazione (e in una certa relazione) il contesto sociale, quello ecclesiale (istituzionale) e la soggettività dei membri,
Non occorre sottolineare che anche in questo caso la tipologia in parte comprime e riduce la realtà, schematizzandola eccessivamente, non tenendo conto degli aspetti di omogeneità al di là delle differenziazioni, della dinamica storica e della globalità dei processi di mutamento sociale in cui i gruppi/movimenti sono inseriti.
I«tipi» che emergono in qualche modo coprono l'intero arco dell'associazionismo giovanile ecclesiale, almeno di quello reale.
I tre «tipi» proposti da Garelli vengono integrati con un quarto tipo, ricavato da un'analisi delle nuove forme associative odierne.
1. Gruppi (appartenenti all'area ecclesiale) tra i quali sorge un consenso sui valori della sfera privata e che si caratterizzano per una subcultura che isola i membri dal contesto sociale.
Si caratterizzano per un riferimento religioso o la finalità solidaristica che «rispondendo ai bisogni di identità e di integrazione sociale dei membri, favoriscono il loro isolamento sociale in subculture e in esperienze autonome e totalizzanti, senza offrire la possibilità di un inserimento attivo e critico nel contesto sociale quale espressione di una tendenza alla partecipazione sociale».
Essi privilegiano una concezione personalista della realtà, che si esprime nel primato della conversione individuale e nella prevalenza dei rapporti primari.
Emerge in questi una prevalenza di atteggiamenti e comportamenti che privilegiano lo status quo.
Circa la dinamica interna, risulta forte il senso di appartenenza, la presenza di un forte leaderismo, il prevalere dei rapporti faccia a faccia, il frequente ricorso a esperienze rituali dense di significati simbolici e di stati emotivi grazie a cui viene riconfermato il consenso e l'appartenenza.
La realtà sociale esterna costituisce un elemento negativo, il che tende a rinsaldare i rapporti di gruppo.
La relazione con l'istituzione ecclesiale è caratterizzata da ottimi rapporti.
E riferimento religioso (non sempre esplicito) risulta assai funzionale sia all'integrazione psicologica e sociale dei membri, sia all'isolamento distinzione dal contesto sociale.
La subcultura che essi esprimono tende sempre più all'isolamento, e quindi ad un maggior rafforzamento dei vincoli interni di coesione e appartenenza.
2. Gruppi che (con riferimento religioso più o meno esplicito e operando nell'ambito dell'istituzione ecclesiale) si contraddistinguono per una funzione «educativa» e per un'azione sociale di carattere «prepolitico».
Essi si caratterizzano per un'aggregazione giovanile attorno a qualche interesse o azione sociale, fattori considerati come totalizzanti, ma con la tendenza a favorire un processo di sensibilizzazione e di coscienza sociale e di graduale inserimento attivo e critico nel contesto esterno. Si innesca quindi un processo di definizione della realtà nei componenti che tenta una integrazione tra i problemi e istanze di tipo sociale e problemi e istanze di tipo personale.
Intorno al carattere prevalente del gruppo (sociale, educativo, giovanile, religioso...) si innesca pertanto un complesso e graduale processo di «formazione» dei componenti, che si esplica «nella pratica di una vita collettiva (di gruppo), nella verifica della vita quotidiana di credenze e valori, nella creazione di atteggiamenti di partecipazione, nell'assunzione graduale di responsabilità, nell'analisi della realtà sociale, nel progressivo inserimento sociale e raccordo con le forze sociali emergenti».
La caratterizzazione tipica dei gruppo è pertanto sulla finalità educativa dei propri membri, in vista della quale si favorisce una mobilitazione attorno ad un tema o interesse o carattere in grado di mediare l'istanza educativa.
La loro azione sociale non è una vera e propria azione volta a modificare la realtà: troppo grande è la coscienza della complessità, delle implicanze, delle competenze. t però un'azione di sensibilizzazione, di formazione di atteggiamenti e comportamenti partecipativi.
Il riferimento istituzionale dei gruppo stesso permette di avere un'ampia base sociale di riferimento e di sensibilizzazione, permette cioè un ambito in cui operare.
A ciò aiuta anche la struttura interna e le modalità di azione del gruppo (strutture di aggregazione di base, gradualità delle tappe educative, attenzione al proselitismo).
3. Gruppi che, con un riferimento religioso esplicito e in dissenso nei confronti della struttura ecclesiale, si collocano all' interno del movimento collettivo mediante una diretta azione politica e sindacale.
Questo tipo si caratterizza inizialmente per un'esperienza nell'ambito dell'istituzione ecclesiale, ma poi «trova in seguito la sua identità in un processo di differenziazione ideologica, religiosa, di prassi sociale, rispetto all'esperienza originaria fatta all'interno della struttura ecclesiale... Mentre nei confronti della chiesa tale tipo di gruppo rivela i caratteri di setta (contrapposta, distinta, isolata dall'istituzione ecclesiale), nei confronti della realtà sociale esso appare distintamente inserito nel movimento sociale innovativo.
Tuttavia esso sembra sempre più perdere il contatto con la base sociale da cui è originata la sua esperienza, e distinguersi per una struttura di élite che risulta in conclusione scarsamente propositiva nei confronti delle masse.
Sono gruppi, questi, che non hanno più grossa rilevanza o incidenza.
4. Gruppi che, con un riferimento religioso critico/costruttivo nei confronti dell’ istituzione ecclesiale, operano attraverso forme di azione di volontariato.
Sono gruppi che si vanno sempre più estendendo, e raccolgono i vecchi contestatori delle strutture (e gruppi) parrocchiali tradizionali, accusati di inconcludenza e intimismo, e giovani che provengono da comunità cristiane o di quartiere.
Si possono catalogare in essi le esperienze di volontariato, di servizio civile, di obiezione, con una grande sensibilizzazione verso le situazioni di marginalità (handicappati, drogati...).
Attorno a questi gruppi è facile che sorgano comunità di ricupero o cooperative, come garanzia di continuità e per possedere un'immagine sociale riconosciuta anche dalle strutture civili.
Sembrano queste le nuove forme aggregative che si diffondono sempre di più, anche se permangono alcuni problemi di fondo non totalmente analizzati o risolti verso la loro azione e identità.
Come per esempio: quale tipo di volontariato? quale rapporto con le altre istituzioni? quale funzione specifica della loro attività?
È questo soprattutto il nodo la cui soluzione definisce la maturità dei volontariato stesso: e cioè la ricerca di una forma a metà tra l'intervento privatocaritativo, e la supplenza, nell'accentuazione sia di un'opera di sensibilizzazione alle nuove povertà, sia di sollecitazione ad un intervento pubblico adeguato, sia nell'attenzione ai bisogni che restano non individuati e non coperti da qualunque tipo di intervento. Insomma, il volontariato come«terza via» tra pubblico e privato.
2.4. Una storia dell'associazionismo ecclesiale
Sulla base dell'ultima tipologia presentata, quella «interpretativa», possiamo ripercorrere le trasformazioni della realtà associativa giovanile ecclesiale dalla fine degli anni '60 ad oggi.
Lo faremo per brevissimi cenni, cercando di individuare le diverse ridefinizioni dell'identità e della funzione sociale evidenziata dai più importanti gruppi/movimenti, per valutare appunto la capacità di descrizione e di interpretazione che la tipologia proposta possiede. Potrebbe sembrare, dall'insieme, che sia l'analisi storica che quella sociologica si collochino unicamente dal versante della «domanda», cioè dal basso dei fenomeno aggregativo stesso, come esigenza dei giovani di socializzazione, di esperienza religiosa e sociale, di partecipazione (e creazione) culturale.
Come se non esistesse anche il versante dell'«offerta», di ciò che l'istituzione (in questo caso la Chiesa) ha saputo offrire e proporre.
Ma appare ovvio che l'analisi deve essere integrata da entrambe le prospettive, pur ritenendo, come si è visto, prioritario il punto di partenza «dal basso», cioè dall'analisi dei giovani.
Sapendo che la realtà è in definitiva una risultante di molte forze in gioco: sia da parte della domanda che dell'offerta, che esse si determinano e influiscono a vicenda, e mai in astratto, ma sempre attraverso concrete esperienze.
Questo non toglie che sarebbe molto interessante, anche da un punto di vista sociologico, l'esame delle proposte associative differenziate che sono state elaborate, sia per valutare l'interpretazione e la rielaborazione che l'istituzione ha avuto delle richieste e dei bisogni giovanili, sia per determinare il peso dato ai singoli elementi dell'esperienza cristiana, sia per valutare in modo complessivo la «sintesi» elaborata e proposta.
2.4.1. Legittimazione ideologica ed emergere dei dissenso
I mutamenti strutturali e culturali che hanno contrassegnato la società italiana degli anni '60 e le istanze del Concilio sui problemi sociali, su una maggior partecipazione all'interno della struttura ecclesiale, hanno certamente costituito le precondizioni esterne e interne che sembrano essere alla base dei processi di rinnovamento di una larga fascia di gruppi e movimenti giovanili ecclesiali. L'essere sfociati in movimenti di rottura e gruppi di dissenso e di contestazione verso la struttura ecclesiale è certamente da riferirsi alla presa di coscienza che l'esperienza ecclesiale, il riferimento religioso, non appariva in grado di offrire strumenti adeguati di analisi dei processi di mutamento della realtà sociale, e di essere globalmente fuori della storia, arroccata su posizioni di tradizionalismo o di supporto ideologico e legittimazione al sistema sociale, incapace di cogliere il senso dei mutamento sociale in corso.
Era in gioco la ridefinizione della propria identità religiosa e della collocazione sociale dell'associazionismo giovanile ecclesiale. L'emergere delle istanze dei politico (all'epoca della contestazione e delle lotte operaie) ha permesso di concretizzare scelte e sbocchi determinati e ha rappresentato un processo globale di ricomposizione di tutto l'ambito associativo giovanile ecclesiale, innescando anche un progressivo decadere di un certo associazionismo cattolico vecchio tipo.
Quali gli esiti di questo processo? Un momento fecondo di elaborazione ideologica, di azione politica, di esperienza sociale, che si traduce in un sorgere e svilupparsi di molteplici forme di gruppi spontanei, di gruppi dei dissenso, delle comunità di base e dei movimenti di contestazione ecclesiale. In essi confluiscono anche gruppi (come Gioventù Aclista) prima operanti nell'ambito istituzionale, che pur volendo mantenere il riferimento religioso, non si riconoscono più in una interpretazione tradizionale.
Sul versante dell'associazionismo legato all'area istituzionale, la crisi investe in pieno l'Azione Cattolica, i cui membri non sentono sufficientemente appagante la «scelta religiosa», e che comunque vengono investiti dalla crisi globale dell'associazionismo. Da questo processo emerge un'AC notevolmente ridimensionata nel numero, che si avvia a una nuova fase organizzativa e riformula la propria proposta religiosa ed educativa caratterizzandola coll'istanza dei prepolitico, venendo quindi fondamentalmente incontro alle esigenze di ridefinizione dell'identità a cui erano sollecitati i membri.
Questo indirizzo è anche quello che caratterizza il movimento Scout, che ridefinisce le sue finalità alla luce delle istanze dei politico: esso appare così capace di reinterpretare i caratteri più specifici della propria esperienza o tradizione alla luce delle nuove istanze emergenti, e di inserirsi in un processo di trasformazione sociale. Questa è certamente la causa non ultima della non contrazione del movimento alla fine degli anni '60 e negli anni '70.
Un altro esito è offerto dai gruppi caratterizzati prevalentemente dall'azione sociale, volti cioè ad una soluzione immediata e ad una sensibilizzazione ai problemi derivanti dall'ingiustizia e dalla marginalità sociale, intesa come azione di supplenza sociale iniziale rispetto all'intervento politico. Si tratta dei gruppi e movimenti terzo mondisti, di quelli impegnati nel settore dell'emarginazione sociale (droga, prostituzione), nell'assistenza degli anziani ed handicappati: un'area assai articolata.
Non sempre in essi era presente un riferimento religioso o un senso di appartenenza ecclesiale: e pure sono accettati dalla chiesa sia per non alienarsi una grossa fetta di giovani, sia per il processo di autoridefinizione attuato dalla gerarchia stessa, in senso meno intransingente e tendente ad evitare ulteriori spazi di conflittualità.
2.4.2. Contrazione dei gruppi ad azione sociale
In questi anni appare in declino la grande stagione dei gruppi giovanili ecclesiali di «azione sociale». I motivi sono principalmente due: la crescita ideologica e l'esigenza di partecipazione politica maturata dai membri dei gruppi durante la loro militanza. Ciò li spinge ad uscire dalla generica analisi e intervento sociale tipica dei gruppi a cui finora erano appartenuti, e a porre come condizione dell'appartenenza al gruppo la qualificazione dell'azione e il raccordo con le forze sociali politicamente organizzate, unita alla critica della struttura stessa dei gruppo e alla gestione dei potere. Il secondo fattore è da individuarsi nelle nuove condizioni storico-culturali della società: esso da una parte permette di constatare la esiguità dell'azione generica condotta dai gruppi stessi, e dall'altra non offre adeguate possibilità alla risoluzione di problemi circa la collocazione socio-professionale, l'identità sociale, la ridefinizione dell'appartenenza sociale e dei quadro culturale di riferimento.
I gruppi dell'area dei dissenso in questi anni sono su posizioni di stasi o di leggera contrazione. li loro apporto per la maturazione dei giovani stessi, per aver innescato nella stessa istituzione ecclesiale un processo di ridefinizione della sua identità e funzione sociale, è davvero notevole. Tuttavia una grossa serie di problemi li tocca da vicino: il rischio di fondare sulla fede la lotta di classe e quindi un certo integrismo di sinistra, il pericolo di distacco dalla base, l'oscillazione tra la propria qualificazione come movimento ecclesiale e l'affermazione di una scelta politica rivoluzionaria.
Tali gruppi avvertono sempre più e in modo accentuato il problema della loro identità e funzione sociale, e il carattere settario che finiscono con l'assumere, evidenziando alla lunga problemi di nuove aggregazioni. Saranno problemi decisivi per il loro futuro.
La stessa Gioventù Aclista reinterpreta in questo periodo, e lo sposta su tematiche di tipo educativo e di raccordo con le strutture ecclesiali esistenti, il proprio ruolo e la propria funzione.
2.4.3. L'espansione dei gruppi a specifica identità
La crisi (processo di ridefinizione interna, rilevanza sociale, capacità di aggregazione) non sembra invece toccare altre associazioni o movimenti, come gli Scout, Comunione e Liberazione, l'Azione Cattolica (anche se in misura minore), come mostrano i dati quantitativi globali e la forte ripresa dei gruppi a carattere locale e diocesano in cui si esprimono.
Quali ipotesi possono essere considerate esplicative di questi due fenomeni di segno opposto, la contrazione (o stasi) dei gruppi impegnati in azioni sociali e politiche, e l'espansione e dinamismo dei gruppi di cui sopra?
L'ipotesi, già sopra riportata, sottolinea la rilevanza e globale significatività che gruppi a specifica identità assumono nel pluralismo di forme associative che si presentano ai giovani (com'è tipico nelle società ad alta differenziazione sociale e di proposte culturali e aggregative) come concorrenziali tra loro.
In una parola, l'appartenenza a tali gruppi e movimenti offre la possibilità agli aderenti di ridefinire la loro identità, come soggetti sociali, in termini rispettosi della nuova soggettività in un nuovo contesto socioculturale.
Tale struttura inoltre esercita una funzione di «filtro» che attutisce e compone l'angoscia e le frustrazioni derivanti dalle esperienze per lo più contraddittorie che i giovani vivono e in cui sono immersi, offrendo nello stesso tempo un luogo che risponde al bisogno di integrazione sociale.
L'emergere di questa istanza dei «personale» da una parte è l'ultima possibilità di riprendere in mano la propria esistenza, di fronte alla situazione di dispersione e disorientamento sociale, e d'altra parte è la risposta giovanile, fatta di atteggiamento realista, di ricerca di obiettivi intermedi, a quel bisogno di progettualità più a medio termine e meno idealistica che richiedono la scena politica e i soggetti sociali a metà anni settanta.
L'importanza di questa osservazione sta nel fatto che tale sottolineatura ha assunto un carattere di massa, anche se poi è concretizzato nelle forme più differenziate a seconda delle categorie sociali e delle situazioni.
Ancor più significativo è il fatto che la nuova modalità aggregativa viene avvertita non solo per comprendere il senso della propria collocazione e identità sociale (e quindi per interpretarla), ma in certo modo per maturare azioni e comportamenti che possano avviare alla soluzione dei condizionamenti e della marginalizzazione che investe l'intera condizione giovanile.
I tre gruppi/movimenti citati non hanno allora solamente una ragione d'essere (e di ripresa) di ordine religioso, ma anche una ragione sociale, dal momento che rivelano caratteri in linea coi bisogni evidenziati dalla massa giovanile in quel periodo storico.
Si possono ulteriormente individuare i fattori che permettono a tali gruppi di esercitare una rilevante funzione di aggregazione. Essi possono essere globalmente indicati nella capacità di mediazione che essi possiedono tra le istanze del personale e quelle del sociale (in una possibilità di composizione della totalità dell'esperienza, dei bisogni personali e dell'identità sociale); nella struttura associativa aperta alle masse, in quanto operanti in raccordo con l'istituzione ecclesiale; nell'offerta all'identità di un contenuto specifico attorno a cui raggruppare bisogni, desideri, quadro di valori.
E ovviamente la proposta «religiosa» dell'AC, «educativa» degli Scout, «religioso-educativo-politica» di CL, continuamente qualificate e specificate, attorno a cui si ridefinisce (e si riscopre) l'identità personale e sociale.
La rilevanza che essi assumono nell'ambito italiano e che li rende interessanti e innovativi, è che tali movimenti/gruppi, nella loro struttura, proposta, valori, non esprimono globalmente ne una funzione di isolamento sociale degli aggregati, né una funzione di conservazione sociale; dal momento che la partecipazione al gruppo sembra essere funzionale ad una collocazione attiva e critica dei membri nel contesto sociale e nella vita quotidiana. Carattere che, se da una parte rende ragione della loro diffusione, dall'altra permette di prevedere la loro stabilità e durata.
3. L'ASSOCIAZIONE INVISIBILE
Ci vogliamo ora riferire ad una realtà molto diffusa anche se poco considerata nella chiesa italiana: l'aggregazione dei giovani cattolici in gruppi di base, non legati ad associazioni o movimenti di tipo nazionale, e quindi apparentemente isolati dall'ambito dell'associazionismo religioso tradizionale.
Essa è una realtà molto composita eppure altrettanto presente ed operante nella realtà viva, soprattutto nelle parrocchie.
Si tratta di gruppi che si possono chiamare extraassociativi, di difficile quantificazione e valutazione, soprattutto per la mancanza di dati ed informazioni su di essi.
Una recente ricerca (Giancarlo Quaranta, L'associazionismo invisibile, Sansoni, Firenze, 1982 ) fa il punto sulla situazione di tali gruppi. Ne presentiamo i risultati sia per l’interesse globale di essi, sia per coprire almeno in parte l’ area associativa che non si riferisce a movimenti e associazioni tradizionali, quelli finora esaminati e di cui abbiamo esposto alcune tipologie.
3.1. Annotazioni di metodo e dati dell'indagine «Quaranta»
Si tratta ovviamente di un primo momento metodologico di decisiva importanza. Per il ischio implicito di considerare solo urna forma molto chiaramente strutturata, o al contrario un'aggregazione occasionale di persone.
3.1.1. Quali gruppi?
La definizione operazionale di gruppo, che ha guidata l'intera ricerca e che è necessario esplicitare, è: «ogni forma di aggregazione stabile di più individui che avesse una rilevanza sul piano culturale, politico, pastorale, ecc., tale da renderla percepibile nell'ambito dei microambiente locale come aggregazione di giovani cattolici». Evidentemente nella ricerca sono stati considerati solo i gruppi di base, cioè quelle forme di esperienze locali senza legami organizzativi più ampi.
Il gruppo si presenta allora con tali caratteristiche che permettono di considerarlo portatore di una determinata cultura (in senso antropologico) e come fattore di dinamismi sociali: e quindi come facente parte di una specifica subcultura giovanile (all'interno di una più vasta area culturale cattolica), e come soggetto attivo di grandi processi di codificazione istituzionale dei comportamenti individuali e collettivi (cioè come istituzioni in miniatura).
L'aggettivo qualificante «cattolico» è stato invece assegnato in base alla presenza di certi criteri empirici, assumendo come indici i seguenti fatti: pratica della liturgia cattolica, presenza di leaders o assistenti appartenenti al clero, la presenza di religiose, il nome del gruppo (se riferito alla parrocchia ospite), relazioni in atto con la gerarchia ecclesiastica, fama nell'opinione pubblica: qualora sussistessero almeno tre degli indici stessi.
Il censimento ha portato ai seguenti risultati.
3.1.2. Alcuni dati
In tutte e venti le regioni italiane, nel periodo della ricerca effettuata tra il 1977 ed il 1980, sono stati censiti 8010 gruppi giovanili. Tenendo conto di un errore di circa il 10 % per difetto (censimento di gruppi appartenenti ad associazioni nazionali, «dimenticanza» di alcuni gruppi, inserimento di gruppi poi sciolti, o di aggregazioni instabili o di sottogruppi), si può presumere che la realtà aggregativa cattolica di base comprende globalmente circa 8800 gruppi di base, il che costituisce la metà dell'intero fenomeno associativo cattolico giovanile, sia quanto a numero di gruppi che quanto a numero di soggetti.
Il numero medio degli appartenenti a tali gruppi è di 37, e quindi il numero complessivo dei membri di tali gruppi è 325.000, più o meno quanto i giovani «aggregati» nelle associazioni e movimenti nazionali secondo i censimenti del 1978.
Altri dati interessanti sono i seguenti : il fenomeno dei l'aggregazione di base è più rilevante nelle regioni del Nord Italia (60,8 % dei gruppi), mentre nell'Italia centrale i gruppi sono il 18,4 % del totale, e nel Sud ed isole sono il 20,8 %.
Rispetto al numero delle parrocchie, al Nord c'è un gruppo ogni 3 parrocchie, al Centro un gruppo ogni 5 parrocchie, e al Sud un gruppo ogni 4 parrocchie circa.
I gruppi residenti nelle parrocchie sono l'81,7 % del totale. Le parrocchie sono quindi un fattore importante per la nascita e l'esistenza dei gruppi, fornendo loro sedi, strumenti tecnici, assistenza e legittimazione al loro lavoro pastorale.
Per quanto riguarda la distribuzione secondo criteri urbanistici, si può notare che l'aggregazione giovanile di base nell'area cattolica è legata prevalentemente a strutture urbanistiche di piccole dimensioni (comuni inferiori ai 30 mila abitanti, fenomeno particolarmente evidente al Nord), che può spiegarsi con la forte resistenza alla diffusione della cultura cattolica nei centri medi e grandi; mentre invece nelle regioni centrali del Paese i gruppi di base sono prevalentemente diffusi nei centri urbani.
La media degli appartenenti è pressoché identica in tutta Italia: 37, secondo le seguenti caratteristiche socio-anagrafiche: il 55% di essi sono maschi, il 45% femmine, con una progressiva diminuzione di queste ultime a mano a mano che si scende verso il Sud, dove però c'è una prevalenza percentuale maggiore di leader di sesso femminile: fenomeno probabilmente legato alla possibilità che i gruppi cattolici di base offrano maggiori spinte di emancipazione della donna al Sud, causa la minor consistenza dei gruppi dei movimento femminile.
Circa l'età, il 55% ha un'età superiore ai 18 anni: non è tuttavia da sottacere che il 45% dei componenti il gruppo è tra i 14 e i 17 anni. Si può quindi comprendere la pressante richiesta di sicurezza e affermazione personale dei soggetti, una certa ricerca di identità.
Il livello di istruzione è notevole e superiore all'istruzione media della popolazione giovanile globale italiana per le stesse fasce d'età.
La composizione di classe è all'incirca la seguente: 40% ceto medio, 40% classe operaia, il rimanente è suddiviso tra borghesia e classi subalterne.
3.2. Quale cultura e quali modelli di interazione?
Conoscere i dati quantitativi è già utile e permette di prendere visione della consistenza e significatività dei fenomeno.
Ma non è sufficiente per valutarne appieno la portata.
Quello che è più interessante indagare è infatti ciò che riguarda la vita e la cultura dei gruppi, e il tipo di interazione tra i gruppi stessi e la realtà sociale.
E in particolare: al di là dei loro carattere apparentemente effimero e frammentario; tali gruppi di base costituiscono un vero e proprio sistema integrato e coerente? E cosa avviene all'interno di esso?
Si può presupporre che si svolgano processi di socializzazione e di inculturazione dei giovani, dal momento che essi riguardano sia valori che ruoli espressi e sperimentati ad alta densità emotiva e religiosa. E ancora ci si può chiedere se tali gruppi di base hanno una cultura propria, formata attraverso i processi, che in essi sono attuati, di assimilazione, scambio e creazione culturale.
Anche qui si può presupporre, ma è da indagare ulteriormente, che i gruppi hanno una notevole permeabilità sia nei confronti dei messaggi emessi dall'area cattolica nel suo insieme (gerarchia, intellettuali, editoria, ecc.), sia nei confronti di quelli provenienti da altre aree culturali o culture.
Se questo è vero, allora i gruppi possono costituire una fonte di novità per la chiesa italiana, dal momento che essi sono un possibile luogo di incontro e di sintesi religiosa e culturale.
3.2.1. Perché il gruppo di base?
Per dare un inizio di risposta agli interrogativi di cui sopra, occorre premettere alcune annotazioni sul contesto in cui sono sorti, e hanno avuto un grande sviluppo, i gruppi di base.
Fino alle soglie degli anni '60, nel mondo cattolico era preponderante una organizzazione della base giovanile secondo strutture associative di dimensione nazionale (l'Azione Cattolica ne era un esempio). All'inizio degli anni '60 si sviluppò proprio all'interno dell'Azione Cattolica un dibattito circa le formule organizzative mediante le quali si sarebbe dovuto dare forma all'aggregazione di base. L'opposizione che venne poi effettuata, cioè quella della forma «gruppo» locale al posto della precedente «associazione», condusse a conseguenze di notevole portata. Infatti, la forma «gruppo» sembrava la più adatta ad esprimere la scelta conciliare in favore di una maggiore responsabilizzazione delle chiese locali e le recenti istanze teologiche e culturali legate a nuove domande di soggettività individuale e comunitaria.
Le nuove domande infatti non riguardavano soltanto, sull'onda della ventata di rinnovamento e «aggiornamento» del mondo cattolico ad opera dei Concilio, una forma di partecipazione più attiva nell'ambito di vita ecclesiale (donde il sorgere di gruppi liturgici e di catechisti), o di nuovo modo di aggregazione (di tipo più informale, non diretta dall'alto), come conseguenza della polemica anti-istituzionale dei '68, ma anche un mutamento di religiosità, che fosse più vicina alle forme culturali tipiche delle società neocapitaliste a sviluppo industriale avanzato.
Il dato più sorprendente è che tale sistema organizzativo non solo si è rivelato molto «adattativo» nei confronti dei nuovo mondo socioculturale italiano, ma anche, contrariamente alle aspettative di frantumazione e disgregazione, un sistema.
Il che significa che i gruppi sono in qualche modo («invisibile») legati gli uni agli altri (come nuova «associazione») in un'area dei nuovo consenso alla cosiddetta chiesa istituzionale, da una cultura che appare immediatamente, e per tutti, una sintesi tra la cultura della modernizzazione e la cultura cattolica.
Questo fenomeno, una specie di «sincretismo culturale», è molto evidente nei gruppi di base. Sarebbe interessante vedere quanto ciò vale anche per i gruppimovimenti esaminati più sopra, nonostante questi siano meno direttamente influenzati «ideologicamente» dalla cultura «esterna».
3.2.2. Una cultura nuova e omogenea
L'elemento di sorpresa, come si è detto, sta dunque in quel cosiddetto «sincretismo culturale», che tenta di legare insieme elementi e valori proveniente sia dalla cultura cattolica, che da quella più propria della secolarizzazione e modernizzazione.
E questo non soltanto nei centri urbani, più facilmente esposti al «fascino» della cultura moderna, ma anche in un ambiente che si poteva considerare «lontano» e abbastanza «al sicuro». Infatti, rileva la citata ricerca, anche i gruppi osservati nei centri rurali più sperduti presentavano una comune caratteristica, che li rendeva disomogenei rispetto alla cultura locale, quasi una sistematica attitudine a contrastare le forme religiose della cultura rurale, e a esprimere il proprio essere religioso in nuovi modelli comportamentali, con un linguaggio che non aveva quasi nulla in comune con quello della tradizione. Nello stesso tempo, quei gruppi sembravano essere percepiti, dai rispettivi ambienti, «diversi» sotto molti punti di vista, quali la liturgia praticata, la promiscuità sessuale, la libertà nei rapporti interpersonali, il linguaggio incomprensibile e sofisticato, l'allontanamento dalla tradizione, non solo religiosa, tua anche laica della vita. Alcuni di questi tratti erano comuni a giovani della stessa fascia di età non cattolici o non appartenenti a gruppi di base.
Il fenomeno più sconcertante, però, era costituito non tanto dall'uso di modi e costumi cittadini dallo scontato effetto secolarizzante, quanto piuttosto dalla imprevedibile sintesi tra elementi della cultura urbana e della religione cristiana. Nei piccoli paesi si assisteva dunque al manifestarsi di forme religiose dei tutto simili a quelle espresse nei centri urbani. 1 gruppi e i giovani in essi aggregati apparivano i portatori, entusiastici e coscienti, di nuovi riti, di nuove idee, prevalentemente tratte dai testi conciliari e, infine, di nuovi valori, tutti legati a una concezione dinamica dell'uomo e delle sue relazioni, nello stesso tempo individualistica e socializzante, caratterizzata essenzialmente dalla prospettiva della spontaneità e della realizzazione di se stessi, nel rifiuto di status e ruoli ascritti e con una decisa predilezione per l'azione elettiva rispetto a quella prescrittiva.
Ora, che una qualche omogeneità possa esistere all'interno di una grande associazione nazionale, che dispone di grandi strumenti di unificazione, non è una novità; ma che gruppi non collegati ad associazioni nazionali, inseriti prevalentemente nell'ambito locale e parrocchiale, presentassero le medesime caratteristiche, non poteva che valutarsi, appunto, come sorprendente. Parimenti interessante era poi il fatto che tali omogeneità non si riferivano a ovvi tratti culturali esclusivamente religiosi. Non solo la cultura cattolica risultava in qualche modo mutata, ma la stessa società italiana stava sviluppando in se stessa, anche grazie alla presenza di questi gruppi o di gruppi analoghi, processi di trasformazione di grande ampiezza.
La stessa omogeneità poteva essere riscontrata attraverso una massa imponente di dati: sulla struttura dei gruppi di base (il campo di percezione dei gruppi, cioè le attività svolte, i valori vissuti, i temi trattati, le pubblicazioni, gli interessi politici, le letture fatte; le dinamiche connesse con la leadership; la composizione dei gruppo secondo i fattori sociografici; la densità dei rapporti interpersonali all'interno dei gruppi) e nell'analisi linguistica dei lemmi più usati e delle strutture gergali. Le fonti dell'omogeneità della subcultura sincretica emergente si possono ricercare anzitutto nella similarità dell'atteggiamento generale nei confronti della vita, fondata su una comune «esperienza» sociale e culturale, e inoltre dell'accesso selettivo a elementi culturali diffusi dai «mass media» di emittenza cattolica (tale da poter a buona ragione parlare di arca comunicativa cattolica) e rielaborati e reinterpretati all'interno di ogni gruppo.
Il sincretismo ottenuto offre la prova di una non incompatibilità tra modernizzazione e religione; come nel caso dei gruppi giovanili, dove accanto ad esperienze di tipo individualistico, soggettivistico, moderno, riemergono forme di vita religiosa di tipo più tradizionale. L'intensificazione poi del fenomeno dei gruppi di base negli anni 197678 (in concomitanza con l'acutizzarsi della disoccupazione giovanile) ha fatto supporre che i gruppi stessi siano il luogo privilegiato dove i giovani tentano di ricostruire un proprio «mondo vitale», con valori, status, ruoli diversi da quelli proposti da altre istituzioni socializzanti come la scuola.
3.3. I modelli interpretativi
L'importanza della strutturazione dei gruppo di base, la sua diffusione su tutto il territorio nazionale, la forma che la cultura «sincretica» assume, possono essere interpretati attraverso vari modelli. Essi non si escludono a vicenda, ma possono anche essere validi contemporaneamente, anche se ognuno tenta di interpretare la realtà da punti di vista diversi.
I modelli che ora vengono proposti possono essere anche utilmente assunti come modelli esplicativi delle forme culturali che assumono i gruppi e movimenti istituzionalizzati, quelli esaminati nelle pagine precedenti.
In entrambi i casi, i processi che avvengono all'interno di essi possono essere considerati sia quanto all'origine che alla funzione che essi assumono. Probabilmente anche in misura latente. E cioè, i modelli di aggregazione, i processi educativi, la cultura assimilata, i valori sperimentati e condivisi, possono essere vissuti o come forma di reazione religiosa, o come processo di risocializzazione, o come espressione di sincretismo religioso.
Sono i modelli che ora esaminiamo.
3.3.1. Modello della «reazione religiosa»
Esso è costruito sui concetti di prospettiva totalizzante, di anomia e di reazione religiosa: per eliminare l'anomia il giovane ricerca qualcosa di diverso da quello che offre una società laicizzata, secolarizzata, ad alto sviluppo industriale: egli cerca cioè nuovi status e nuovi ruoli che, come tali, gli possono essere offerti esclusivamente nella dimensione totalizzante della religione e soprattutto dei gruppo religioso. Tale modello può essere utilizzato come criterio per verificare se all'origine dei movimento che ha dato luogo alla nascita dei gruppi ci sia quella reazione religiosa ormai tipica delle società in via di modernizzazione. Ora i dati della ricerca «dimostrano la fondatezza della tesi secondo la quale una delle concause, forse la più importante, dell'aggregazione giovanile cattolica di base, è quel revival di vita religiosa che caratterizza le società ad alto sviluppo industriale, ovvero dell'altra tesi secondo la quale attraverso i gruppi si sia realizzata una risposta soddisfacente, almeno in apparenza, della Chiesa Cattolica alla sfida della società moderna, ovvero ancora, dell'ipotesi secondo la quale in tali gruppi si tenterebbe di recuperare un'identità individuale in termini religiosi attraverso il gruppo che, in tal modo, viene sacralizzato come unico dato sostanzialmente e incondizionatamente religioso».
3.3.2. Modello della «risocializzazione»
Come fanno i gruppi a essere capaci di rispondere positivamente alla reazione religiosa di fronte alle crisi prodotte dal senso di anomia? Sono in grado di rimettere in moto processi di socializzazione primaria, processi cioè capaci di mutare il vecchio campo di percezione, le vecchie gerarchie di valori? E se riescono a realizzare tali obiettivi, quali forme di sistemi di valori propongono nei loro processi di risocializzazione e di reinculturazione?
Una risposta potrà essere data attraverso il modello della risocializzazione, utilizzabile quindi per comprendere la natura dell'azione sociale svolta dai gruppi.
Ora, i dati mostrano che i giovani che aderiscono ai gruppi vengono in un certo senso risocializzati attraverso la gestione di masse di emotività tali da far mutare il loro precedente campo di percezione. La risocializzazione viene orientata specialmente attorno ai valori dell'amicizia e dei realizzare se stessi. Su questa base, gli status e i ruoli introiettati dai giovani nei gruppi sono differenziati e mutevoli, in conformità con il modello moderno che predilige l'informalità dei rapporti e la fluidità delle prestazioni degli individui.
È da notare che in questo modo i giovani assimilano sia valori moderni dei lavoro, della sessualità, dei rapporti interpersonali quotidiani, sia valori di cattolicesimo, in un contesto che li fa percepire e convivere in un modo soprendentemente nonconflittuale.
Che questa linea sia stata efficace è indubbio. Resta da riflettere, però, intorno a una serie di suoi effetti collaterali che, anche se forse involontariamente, sono stati prodotti: come la progressiva scomparsa di molte significative istanze di radicalità evangelica.
3.3.3. Modello dei «sincretismo religioso»
Il terzo modello interpretativo si riferisce al sistema con il quale i gruppi gestiscono le forme religiose che sono la chiave della loro interpretazione dei mondo e della loro interpretazione dell'essere sociale dei gruppo.
Tale modello è costituito dal processo mediante il quale vengono prima assorbite e poi espresse forme religiose diverse nello stesso tempo, senza percepire alcun disagio (come è nel caso dei contrasto tra etica sessuale praticata e magistero ecclesiastico) e senza che questo incida sulla conflittualità dei rapporti tra gruppi di base e gerarchia.
L'analisi mostra che i valori della Chiesa postconciliare costituiscono il punto di riferimento formale, simbolico, rituale dei gruppi, una specie di involucro all'interno dei quale la religione (extraecclesiale) della modernità (quella dell'amicizia, dei realizzare se stessi, ecc.) svolge invece un ruolo dinamico, di orientamento anche pratico della vita dei gruppi stessi.
Così, mentre la religione ecclesiale sembra avere la funzione di consentire una permanenza nel tempo, nonostante le trasformazioni culturali, di una identità cattolica dei gruppi di base (essendo il modo coi quale i gruppi si rappresentano soprattutto all'esterno), la religione della modernità incide profondamente sul campo di percezione, sul modo stesso di selezionare proposte e programmi, anche della religione gestita ecclesiasticamente.
«L'effetto più macroscopico di questo processo di acculturazione è rappresentato dalla frammentazione del movimento cattolico in una costellazione di gruppi, ognuno dei quali, legato alla propria parrocchia, ha assunto un campo di percezione particolaristico. Di qui la nascita di una realtà complessa come quella dell'aggregazione di base, ancora unita o unitaria, ma in maniera invisibile, come se fosse un'associazione perché di fatto i legami istituzionali esistono tra gruppo e gruppo su tutto il territorio nazionale che non sapesse di essere tale, che ha assunto complessivamente nei confronti della gerarchia cattolica un atteggiamento di indifferenza».
Nonostante il rischio che la religione della modernità, attuata nel sincretismo religioso dei gruppi di base, offra un notevole scarto rispetto all'universo di significato della fede cristiana e fino alla possibile cancellazione dell'identità cattolica dei giovani dei gruppi, tuttavia l'intero fenomeno garantisce indubbiamente una continuità di presenza della Chiesa cattolica tra i giovani. Inoltre, i gruppi costituiscono un esperimento «riuscito» di modernizzazione. Infatti essi hanno dimostrato la possibilità effettiva di avviare processi di mutamento socioculturale in funzione dello sviluppo in Italia, a patto di conservare nel nuovo contesto elementi della cultura tradizionale. Infine, proprio per la loro apertura a correnti culturali diverse, i gruppi possono costituire una vera e propria fonte di novità, che adesso non si è in grado di prevedere completamente.
4. PROBLEMATIZZAZIONE EDUCATIVA
Una riflessione educativa sui processi che si svolgono nell'ambito della vita dei gruppi, e sui risultati osservabili, non può certamente essere dedotta da un'analisi sociologica (e neanche storica).
Quest'ultima si preoccupa, come abbiamo visto, sia di descrivere una situazione, sia di tentarne un'interpretazione in collegamento con variabili di contesto; al massimo può spingersi ad una previsione su un futuro abbastanza immediato, sulla realizzabilità (funzionalità) o meno di certi mezzi rispetto al fine.
Tuttavia un'analisi sociologica (e storica) può offrire un materiale non indifferente alla riflessione educativa: la quale ovviamente si colloca su un altro piano.
Essa infatti si preoccupa anzitutto di vedere se il modo di vita dei gruppi/movimenti abilita o no, e a quali condizioni, alla maturazione (anche nella fede) della persona, se l'esperienza in essi vissuta e prodotta è funzionale alla crescita umana (e cristiana) dei membri.
Come si vede, lo scopo finale da raggiungere è differente.
Non si può fare una sociologia educativa, ma la sociologia può essere un aiuto a scoprire se le dinamiche vissute e interiorizzate da chi vive associativamente sono «valide» per un discorso educativo.
Usciamo pertanto dalla sociologia, ed entriamo in un altro campo: o meglio, riflettiamo «educativamente» su quanto offerto dalla disciplina scientifica che finora abbiamo considerato.
4.1. I problemi educativi di fondo
È un problema di sempre perché sta alla base di ogni tipo di gruppo o movimento il cui scopo non è soltanto di fungere da aggregato acritico di supporto ai vertici ecclesiastici, o da maggioranza silenziosa, o da gruppo «rifugio».
4.1.1. La possibilità educativa
Le domande di fondo sono sempre le stesse: a quali condizioni, attraverso quali esperienze, con quali procedimenti il gruppo/associazione/movimento è un fatto educativo?
I rischi sono infatti quelli della possibilità che essi offrano di essere unicamente luogo di rifugio e securizzazione per deboli, di inibizione della creatività e del protagonismo, di conformità, di una leadership totalizzante.
Si è detto nel corso dell'analisi che la forte ripresa dei gruppi ecclesiali è in gran parte dovuta al fatto che essi sanno coniugare le istanze provenienti dal mondo giovanile (tematiche legate al personale) e dal contesto sociale (bisogno di rapporti gratificanti, ricerca di significato), con una proposta forte, di tipo esperienziale, che si offre come capace di unificare le diverse istanze all'interno dell'esperienza soggettiva.
In altre parole, essi sanno offrirsi come mediazione tra le istanze dei personale e quelle del sociale.
Il fatto che essi si presentino in tal modo è certamente la forza di questi gruppi, ma anche il loro limite e il loro possibile rischio. Che è in una parola quello di sostituirsi alle persone stesse, di offrire un centro di unificazione al di fuori dell'identità personale e soggettiva, di essere troppo «forte» e di giocare tutte le energie di cui dispone per gli scopi del gruppo stesso. Potrebbero essere una sottile forma di manipolazione che usufruisce del consenso ottenuto per scopi di conservazione del gruppo stesso, delle sue strutture, della sua rilevanza sociale.
O, più ancora, risultare soltanto funzionali ad una specie di oasi beata e pacifica, di riparo e difesa, una sorta di «rifugio atomico» che rassicura, protegge e difende. Non che la rassicurazione psicologica sia da rinnegare, soprattutto tenendo presente il carattere emotivo che rivestono per pre e adolescenti i rapporti interpersonali: a patto che non diventi fine a se stessa, o che tutto venga giocato unicamente a livello di funzione emotiva.
Oppure potrebbero finire con il dimenticare che l'esperienza di gruppo o di movimento non deve essere talmente totalizzante da far dimenticare il senso di appartenenza ad una realtà più ampia.
Questo non vuol dire che la funzione del gruppo è unicamente di essere mediatore di un'altra realtà, che devono essere unicamente «propedeutici» rispetto al mondo, all'esperienza di chiesa, dal momento che una certa appartenenza al gruppo è già esperienza di mondo e di chiesa. Vuote unicamente dire che essi non possono proporsi come l'unica realtà, anche se per certi versi è la realtà che appare più significativa per gli appartenenti.
Questo obbliga a ripensare la capacità dei gruppo/movimento di essere contemporaneamente luogo di vita e di esperienza, e preparazione alla vita ed esperienza più ampie. Questo obbliga a ripensare alla formazione che essi offrono, tenendo conto dei cammino progressivo che i membri devono compiere, attraverso esperienze interessanti e significative.
E infine, dovrebbe essere sempre rimessa sotto esame la capacità di mediare sia le istanze del personale, che quelle dei sociale, anche se talvolta le circostanze possono portare a sottolineare (o celebrare) i momenti più importanti e significativi.
Possiamo riprendere il tema della capacità formatrice dei gruppi/movimenti, misurando concretamente l'azione svolta attraverso l'offerta di un progetto.
Non discutiamo sulla «propositività» e significatività, ai diversi livelli di età e ambientali, dei progetto stesso, ma sulla presentazione di esso in un itinerario organico, strutturato, dinamico, in cui sono previsti obiettivi finali e intermedi, competenze da ottenere, processi attraverso cui raggiungerli, e in cui viene prevista la possibilità di una valutazione sia sugli obiettivi che sul metodo stesso.
E infine, riprendendo quello che appare ormai come momento essenziale della formazione, la capacità educativa si misura anche sulla possibilità di formare i formatori, di puntare non solo sulla buona volontà o impegno dei singoli, ma sulla professionalità di essi. Su questo pensiamo si gioca buona parte del futuro dei gruppi e movimenti stessi.
4.1.2. Il problema della maturità cristiana
Il secondo problema di fondo raccoglie, sotto un unico titolo, dei nodi educativi molto grossi.
Essi si possono esplicitare nella seguente domanda: a quali condizioni il gruppo/movimento è esperienza di chiesa?
E in particolare è necessario riflettere sui criteri di ecclesialità che sono utilizzati, il riferimento istituzionale (il rapporto con la Chiesa istituzione) e il rapporto con la comunità più ampia. E ancora, il modo in cui viene espressa, motivata e vissuta la fede, la capacità che essa possiede o meno di risignificare la vita dei gruppo, la prassi che ne viene ispirata, fino alla considerazione del risultato che viene offerto quanto a «identità cristiana». Un ulteriore confronto deve essere attuato circa le modalità concrete con cui tutto ciò viene vissuto: e ciò riguarda anche i modelli di preghiera che vengono offerti e sperimentati, la prassi liturgicosacramentale, la forma di accostamento alla Parola.
Il rischio è che tutto ciò si sovrapponga alla reale esperienza del giovane, magari imponendo modelli che non sanno rinnovarsi e rispondere alle nuove esigenze e sensibilità, o un modello di riferimento istituzionale ad una Chiesa preconciliare...
(Su questi temi rimandiamo al quaderno di Riccardo Tonelli, Q9/ Il gruppo giovanile come esperienza di chiesa).
4.2. I problemi educativi «funzionali»
Ci riferiamo in questo paragrafo a quelli che pensiamo come problemi che periodicamente ritornano e che fanno da base ad un buon funzionamento e funzionalità dei gruppo, anche se talora non vengono affatto considerati, o perché non importanti al momento, o perché ritenuti già risolti.
Li accenniamo solamente, con poche battute.
- Stare insieme o impegnarsi? Non si tratta ovviamente di una scelta per una prospettiva o per l'altra, ma di essere attenti a esorcizzare la possibilità effettiva dei gruppo/movimento di vivere alternativamente i due momenti come separati. La soluzione è sempre da ricercarsi nell'unificazione di entrambe le esigenze, sotto il tema dell'identità personale in crescita e della maturazione umana e di fede.
Il problema resta quello di come fare.
- Giovani e adulti. Non si tratta di riproporre temi antichi e superati, ma di valutare le funzioni e il senso della presenza degli adulti in seno al gruppo: se nel senso dell'esperienza di «comunità», o unicamente di guida direttiva garante dell'«ortodossia» o dei carisma.
Collegamento o isolamento? il fatto grosso sembra essere una nuova tendenza a confrontarsi (e combattersi) unicamente sulle ideologie, cioè sulle diverse concezioni di base circa la fede, la chiesa, il modello di uomo, di relazione con la cultura, di presenza nel mondo ... più che non un collegamento unitario su problemi concreti.
Possiamo prevedere che questo sarà il nodo più rilevante degli anni che verranno, e su cui si giocherà la credibilità e la capacità di essi di essere espressione di chiesa.
- Operazione sbocco. Come ci si prepara all'uscita dal gruppo?
Anche se ogni associazione e movimento tende a prolungare con nuove strutture e motivazioni la presenza del giovane all'interno, (e questo pone già interrogativi educativi di rilievo), resta il fatto che essi non potranno continuare a presentarsi, come direbbero i sociologi, come unica «base sociale» o «struttura di attendibilità» della scelta cristiana delle persone.
Proprio le recenti ricerche sociologiche mettono maggiormente in guardia rispetto al problema dello sbocco.
I modi di soluzione finora adottati, grosso modo, possono essere ridotti a due: o un mantenimento all'interno, creando nuovi gruppi di età sempre maggiore e legati all'associazione/movimento come a un cordone ombelicale (in una possibile crescente adolescentizzazione), o un esodo scontato e definitivo che fa sentire l'esperienza vissuta nell'aggregazione come una parentesi nella propria vita. La necessità avvertita è ovviamente quella di una modalità di riferimento al gruppo (per la conservazione di un'identità religiosa) senza l'appartenenza allo stesso.
- La selettività. Le indagini rilevano che gli appartenenti al movimento aggregativo cattolico sono perlopiù studenti, mentre esso risulta scollegato rispetto alle problematiche e condizioni dei giovani già inseriti nel mercato dei lavoro o disoccupati, che pure sono il 45% circa dei giovani.
L'analisi del linguaggio utilizzato e dei riferimenti culturali rileva inoltre una disattenzione alle culture giovanili che non siano quella studentesca.
Ci si chiede se tale selettività risulti costitutiva dell'associazionismo stesso, e se esso non perda così, nonostante poche lodevoli eccezioni, la possibilità di essere aperto alle varie forme di esperienza giovanile, nella ricchezza e diversità che esse offrono.
4.3. I problemi educativi di oggi
Essi ci paiono essere soprattutto tre.
4.3.1. Il rapporto gruppo/persona/istituzioni
E evidente che tutto il rapporto educativo viene giocato, oltre che sulla dimensione del contenuto del rapporto, che abbiamo tentato di mettere in evidenza nel paragrafo precedente, anche sulla relazione.
E questo sembra oggi essere diventato predominante, dal momento che i contenuti (o la scelta dei contenuti specifici dell'esperienza cristiana e della visione del mondo) passano ordinariamente attraverso un certo modello di relazione.
Non ci si può troppo dilungare, se non accennando ai tre rapporti che si vengono a creare:
- rapporto gruppo (movimento) persona: bisognerebbe valutare il modo con cui è giocato il rapporto tra dimensione formativa e pressione di conformità, tra unità e differenziazioni operative, e la coesione come gioco tra attese personali e risposte di gruppo;
- rapporto gruppo (movimento) società: se è vissuto come rafforzamento di coesione contro l'esterno minaccioso, o come presenzaazione, cioè con costante attenzione educativa e maturante attraverso azioni giocate nel prepolitico e con tensione a diventare sempre di più gruppo di riferimento;
- rapporto gruppo (movimento) chiesa: con particolare attenzione a quanto di normativo viene proposto all'esperienza di fede dell'appartenente al gruppo. Valutare il modo più maturante presuppone di rispondere alla domanda sulla funzione solo strumentale, o propedeutica, o alternativa, o «di mediazione» del gruppo stesso.
Potremmo considerare un altro tipo di rapporto, questa volta centrato sulla relazione gruppo (spontaneo) movimento. Il problema di collegamento sta diventando sempre più grosso. Sembra che sia in corso infatti una specie di forza centrifuga che tende a dare maggior peso alla «spontaneità», alla stessa individualità di gruppo, a scapito delle forze che invece tenderebbero a riunificare. Il movimento (e associazione) sembrano quasi diventare incapaci di porsi come punto di collegamento e di riunificazione, anche attorno a «idee forti».
4.3.2. L'identità personale e collettiva
È un problema che indirettamente è già stato toccato precedentemente, nelle altre attenzioni educative, ma che merita di essere ripreso e focalizzato.
Soprattutto perché è su questo tema che si gioca l'intera esperienza sia della persona che del gruppo stesso. E come rivedere tutti i problemi precedenti dal punto di vista dell'identità.
Detto molto brevemente, quale identità viene costruita e sostenuta? quale rapporto si crea tra identità personale e identità collettiva? Ciò è tanto più significativo se si riflette che ogni discorso educativo, di maturazione, di esperienza cristiana e di fede passa attraverso la crescita e il consolidamento dell'identità personale. Bisognerebbe aggiungere: anche di quella sociale. Qui però la specifichiamo come identità collettiva, cioè l'identità che viene elaborata e sostenuta per il fatto stesso di partecipare ad un gruppo/movimento. Dovrebbe essere tenuto presente il fatto che l'identità per,sonale noti è mai costruita (o non dovrebbe esserlo) dal recepimento di un'identità collettiva; e che d'altra parte più identità collettive (maturate magari da diversi ambiti di appartenenza) possono entrare come elementi costitutivi della soggettività personale.
Il rischio ovvio è della disintegrazione o dell'incoerenza.
Ricordando sempre che la soggettività delle persone riceve già un suo indirizzo peculiare dal contesto socioculturale che, come si rileva in altri quaderni, è determinato da tematiche tra l'individualistico e il personale, e il consumistico. Bisogna vedere come queste vengono assunte e coniugate con le altre istanze di cui il gruppo/movimento è portatore.
4.3.3. Quale presenza sul territorio?
Si accennava precedentemente, nel tentativo di una adeguata tipologia interpretativa, alla presenza sempre più viva di un quarto tipo di gruppo: quello volto ad azioni di volontariato, specie in comunità di ricupero. E si annotavano problemi non ancora risolti di identificazione e di senso della loro presenza e opera, di rapporto con le istituzioni.
I nodi problematici che vi stanno alla base, e che globalmente possono giocare come termine di riferimento per la maturità di questi gruppi, possono essere a loro volta sfide al movimento aggregativo cattolico nella sua globalità.
E cioè, ridefinendo i problemi, si può cogliere come grossa sfida o problema educativo, il rapporto tra i gruppi/movimenti e il territorio. li che vuol dire ovviamente non solo il territorio «ecclesiale», la parrocchia o la diocesi, ma quello geografico, di quartiere, e globalmente sociale. Si tratta in altri termini di prendere sul serio la sfida che i nuovi bisogni, le nuove povertà, i nuovi giovani rivolgono ai gruppi ecclesiali stessi, invitandoli a farsi carico della nuova situazione.
Queste sfide già iniziano a determinare, come si notava, un esodo, per ora ristretto, di individui dai gruppi tradizionali; e in ogni caso costringono a una revisione dell'azione dei gruppi stessi.
IL CANOVACCIO
Per una scuola di giovani animatori
Giancarlo De Nicolò - Domenico Sigalini
Il materiale di lavoro offerto in questo canovaccio si occupa dei seguenti tre argomenti:
- la definizione dell'obiettivo del quaderno;
- l'esplicitazione dei punti nodali in esso contenuti;
- un'indicazione del metodo per affrontarli (e possibilmente risolverli).
L'OBIETTIVO DEL QUADERNO
I presupposti di base (o se si vuole, i postulati) che hanno guidato l'esposizione delle tematiche sono essenzialmente due:
- il gruppo (associazione, movimento) è una delle proposte privilegiate di pastorale giovanile. Anzi, tenendo conto dei fatto che i partecipanti sono adolescenti/giovani, e quindi che fondamentalmente la loro socializzazione avviene entro tali esperienze, i gruppi sono insostituibili, almeno da una prospettiva psicologica;
- l'animatore gioca il suo ruolo (si può definirlo «strutturale», in quanto definisce il contenuto proprio della sua funzione) non in astratto o in un rapporto con i singoli (egli non fa «direzione spirituale», non è il consigliere privato, lo psicologo), ma dentro il gruppo, attraverso svariate dinamiche reciproche.
Sono evidenti allora le conseguenze (e gli obiettivi). Occorre fornirsi degli strumenti necessari per collocarsi come animatore nel gruppo.
Però questo è un quaderno «storicosociologico», come si diceva nell'introduzione. li che vuoi dire che gli strumenti sono offerti attraverso una lettura interpretativa storica (un resoconto degli ultimi vent'anni delle aggregazioni giovanili ecclesiali) e sociologica (un'esplicitazione delle tipologie di esse). Sono strumenti importanti, perché permettono da una parte di «collocarsi», di avere una coscienza storica, che serve a rendersi conto che non si inizia sempre da capo, ma che il proprio modo di essere e di fare animazione e gruppo si inserisce dentro ciò che altri hanno elaborato; che le esperienze passate sono risposte a domande di aggregazione collocate in un periodo ben preciso, di fronte ad esigenze ben precise; e in fondo anche a rendersi conto della «relatività» delle proprie scelte: quello che va bene adesso può non rispondere più, domani, a nuove esigenze. E dall'altra parte, una adeguata conoscenza «sociologica» permette di «riconoscere» il gruppo in cui si lavora, di vedere come si gioca l'appartenenza, come si intrecciano identità, azione, riferimento ecclesiale... e infine di vedere se i mezzi utilizzati possono ragionevolmente e funzionalmente indirizzare ad un fine.
l PUNTI NODALI
Quelli attorno a cui è stato costruito il quaderno, sembrano essere essenzialmente i seguenti:
- un vocabolario di base; una storia dell'aggregazionismo: sia di tipo laico che religioso; e all'interno di quest'ultimo, la sottolineatura di quella che è stata chiamata «associazione invisibile», accanto agli altri vari gruppi e movimenti o associazioni;
- una serie di tipologie con cui affrontare lo studio dell'associazionismo, soprattutto ecclesiale
- una problematizzazione educativa (in genere, ed educativa nei confronti della fede).
Se questi sono essenzialmente i nuclei dei quaderno, occorre ora vedere con quali metodi possono essere accostati e (possibilmente) risolti.
QUALI STRUMENTI UTILIZZARE
Un vocabolario di base
Bisogna anzitutto individuare i termini «tecnici» usati, quelli che sono raramente usati nel linguaggio ordinario, o che assumono significati speciali usati «scientificamente».
Si può fare un elenco, cominciando per esempio da: socializzazione (primaria e secondaria), interiorizzazione, identificazione, trasmissione orizzontale e verticale, ruoli, associazionismo selvaggio, e dal basso...
Una definizione può essere ricavata dal quaderno stesso, tenendo conto che in esso i termini vengono usati secondo una prospettiva sociologia particolare (per chi è interessato: è una prospettiva che si rifà in parte all'interazionismo simbolico americano Mead, Cooley e alla sociologia della conoscenza di prospettiva fenomenologica Schutz, Berger, Luckmann + ovvio che in altre prospettive sociologiche, o anche psicologiche, le definizioni cambierebbero, o meglio cambierebbero i contesti e le sottolineature. Suggeriamo comunque come strumento di consultazione il Dizionario di Sociologia (a cura di F. Demarchi e A. Ellena), Edizioni Paoline, 1976.
La storia dell'associazionismo
Elementi di storia sono detti esplicitamente nel quaderno al paragrafo 1.2. soprattutto per valutare le trasformazioni dei processo di socializzazione (è da tenere presente che se anche mancano riferimenti specifici agli anni '50 e al fatidico '68, essi sono tenuti ben presenti sullo sfondo del discorso), e al paragrafo 2.4, soprattutto per valutare la capacità di descrizione «storica» della tipologia presentata.
Questi elementi storici sono da valutare e confrontare non solo con altri testi di storia civile e religiosa, ma soprattutto con il «racconto» di persone che hanno vissuto quei periodi.
E allora si possono invitare persone sui 3540 anni che hanno Vissuto il periodo per lo meno dal '68 in poi, perché raccontino la loro esperienza, perché riferiscano del contesto storico (politico, economico, religioso), del modo con cui gruppi e associazioni hanno nsposto alle sfide, come erano avvertiti i problemi all'interno, un giudizio sul loro «esodo» dai gruppi o sul «ritorno».
Le persone invitate dovrebbero rispecchiare il più fedelmente possibile le diverse esperienze associative: è meglio se è presente anche il parroco (di quei tempi), che in qualche modo rappresenti l'istituzione «chiesa».
Il metodo di incontro potrebbe essere una tavola rotonda.
Un censimento dei gruppi
Anzitutto può essere fatto un censimento dei gruppi (associazioni, movimenti) presenti nel proprio quartiere (o parrocchia o città).
È abbastanza facile farlo, a patto che non ci si lasci attrarre solo da quelli più famosi o conosciuti. Si può scoprire una miriade di gruppuscoli (sempre però tenendo presente che il gruppo non è una semplice aggregazione, ma ha una sua certa strutturazione almeno iniziale) anche stando attenti a ciò che succede nella propria esperienza di scuola o di lavoro, o anche solo sentendone parlare. Per ora la raccolta sarà disordinata, mancando un criterio di «selezione». Comunque questo serve se non altro per rendersi conto della variegata esperienza aggregativa esistente, e anche per comprendere come la propria esperienza di gruppo non è certo l'unica, né l'unico modello possibile di tutti i gruppi.
La raccolta di informazioni deve essere estesa a tutte le forme di gruppo, sia ecclesiale che non. E oltre al nome dei gruppo (indicativo per tanti versi) devono essere raccolte informazioni sul numero medio, età, percentuali di sesso, dati sull'istruzione, classe sociale di appartenenza, esperienza di scuola / lavoro, «affiliazione» o meno a gruppi o associazioni più ampie, chi è il leader, arca di azione, strumenti di comunicazione (fogli di collegamento, giornalini ... ). Tutti dati che permetterebbero una piccola ricerca «locale», utile perlomeno per imparare a trattare con una realtà «sociologica».
Le tipologie
Anzitutto in campo non ecclesiale. Si può prendere la tipologia «descrittiva» Milanesi (a pag. 14), soprattutto sulla base dei «motivo di aggregazione» (religioso, educativo, sociale, politico, culturale, sportivo, caritativo ... ) e cominciare a «sistemare» sotto ogni categoria tutti i gruppi censiti.
Si vedrà che non sempre è così facile come può sembrare.
Comunque non dovrebbe risultare impossibile giungere a una catalogazione almeno generica.
Questa non è ancora una tipologia «sociologica», la quale dovrebbe poter considerare almeno un paio di variabili, e non solo una, come il «motivo di aggregazione».
Questo rimanderebbe all'esame di come si costruisce una tipologia (e uno spazio di attributi), cosa che qui non può essere affrontata.
Rimandiamo ad un libro molto utile (e facile): R. Boudon, Metodologia della ricerca sociologica, Bologna, fi Mulino, 1970).
Passiamo ora ai gruppi ecclesiali.
Si può cominciare con il chiarire le distinzioni tra gruppo, associazione, movimento, vedendo in cosa si differenziano, per esempio rispetto alle cinque dimensioni che emergono dalle domande indicate nella tabella.
In un secondo momento, attraverso una raccolta di foglietti, documenti, ricordi, testimonianze, si può fare la storia dei proprio gruppo e dei gruppi giovanili nella propria parrocchia, dagli anni '60 in avanti.
Oppure, utilizzando la tipologia di cui al numero 2.3.3_ valutare la posizione del proprio gruppo rispetto alle variabili:
- concezione della realtà,
- motivo di aggregazione,
- rapporto con l'istituzione ecclesiale,
- (e se si vuole, in aggiunta) posizione rispetto all'ambiente sociale.
La tipologia «interpretativa» offerta al paragrafo 2.3.4. può anche essere utilizzata utilmente, soprattutto se si vuole valutare la posizione di gruppi e movimenti conosciuti (attraverso l'esperienza personale, o documenti vari, o testimonianze, o studi), soprattutto tenendo conto delle variabili indicate, e cioè il riferimento ecclesiale, il riferimento culturale, e quindi il senso della loro azione.
A questo può essere utile il riferimento alla griglia di analisi (vedi finestra alle pp. 2729) che qui viene offerta, e che può servire come traccia (tenendo conto solo dei punti che interessano), sia per l'analisi del proprio gruppo che di altri movimenti.
Come si vede, le variabili in gioco sono molte; essa tuttavia permette di raccogliere e ordinare molte delle conoscenze che si hanno a proposito della realtà aggregativa giovanile ecclesiali, punto di partenza indispensabile per una valutazione complessiva di tipo interpretativo.
Questo schema è stato elaborato in un corso di scuola animatori.


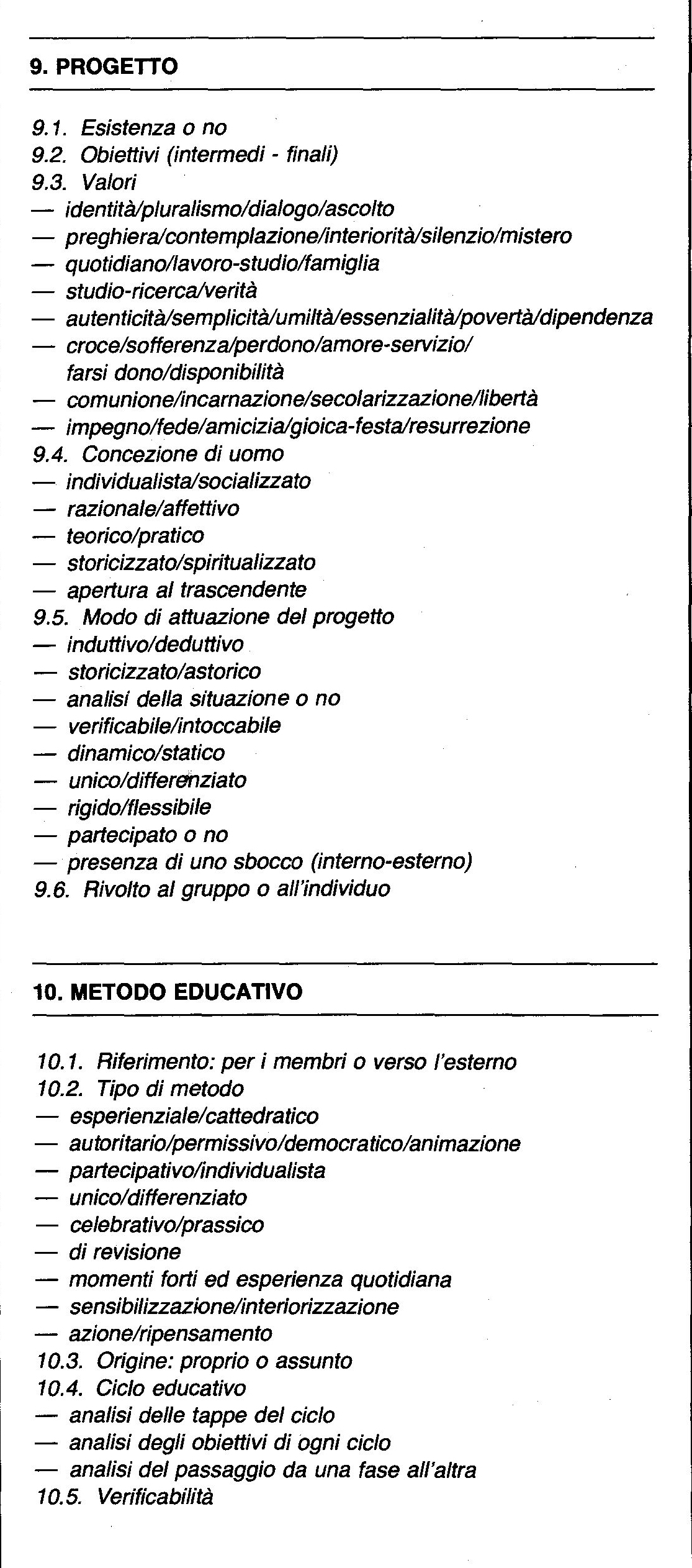
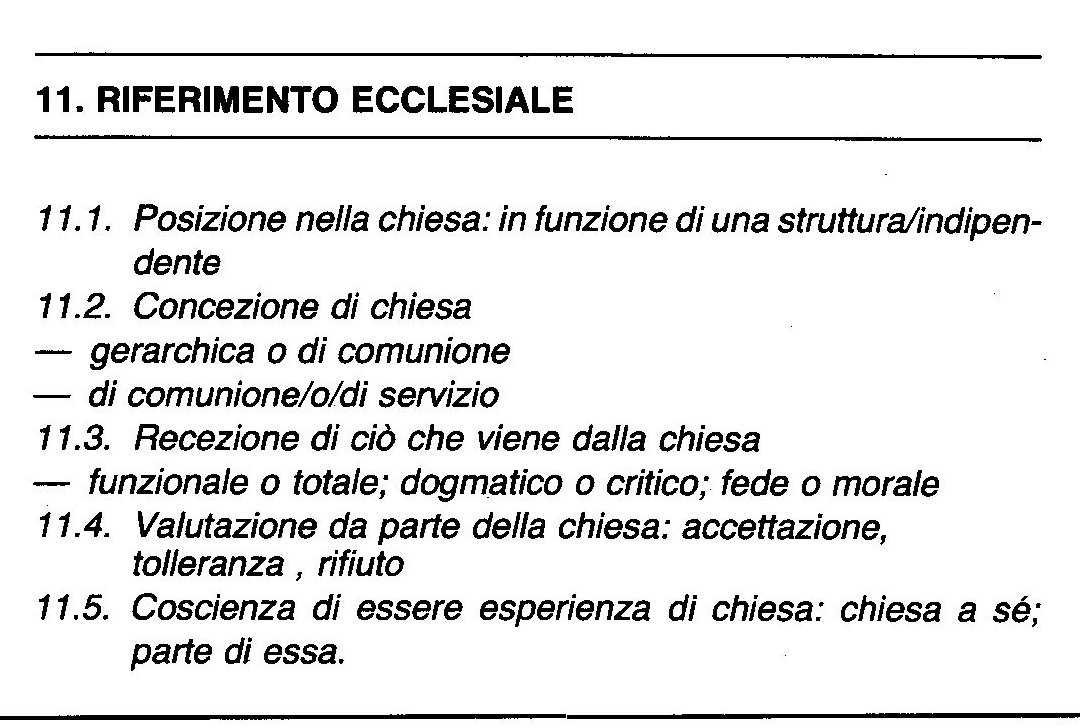

L'associazione invisibile
Dal momento che è probabile che molti gruppi operanti nell'ambiente ecclesiale siano in qualche modo scollegati rispetto alle associazioni e movimenti nazionali, crediamo utile sia per il gruppo che per gli animatori far riferimento a quella realtà che abbiamo chiamato «associazione invisibile».
Può essere utile fare una ricerca dapprima personale (di gruppo) e poi un confronto con le tabelle che seguono, e che sono ricavate dalla ricerca Quaranta, sui seguenti punti.

Dalla prima tabella è facile immaginare che. anche il gruppo che sta lavorando abbia un assistente ecclesiastico, non eletto dai membri, (e ovviamente maschio). Dalla tabella 2 risulta che per lopiù il gruppo farà servizio parrocchiale (o che questo servizio occupa circa due terzi del tempo).

Prima di vedere la tabella 3 per un confronto, si può esaminare nel proprio gruppo la frequenza dei temi trattati nelle riunioni, o nell'arco di un anno, o da quando si è al gruppo, o per un periodo più ristretto. La tabella 4 è utile per verificare sia la frequenza delle parole maggiormente usate nei gruppi, sia per un confronto con quelle usate invece nei documenti sia ecclesiali istituzionali, che dei libri, foglietti, ecc. dei movimenti e associazioni nazionali «ufficiali».

Per verificare la «verità» di questa tabella, si può registrare una riunione dei gruppo, o far rispondere ai componenti dei gruppo sul senso che la vita di gruppo ha per la loro esperienza (e poi fare una somma delle parole... almeno per vedere la graduatoria di quelle più usate); e poi fare lo stesso su libri o documenti vari. Ma la validità principale di quest'ultima tabella è dì far riflettere su alcune risultanze (o domande):
- la graduatoria tra le due tabelle corrisponde?
- cosa significa la presenza di certe parole nel linguaggio cattolico?
- cosa fa intuire la tabella relativa al linguaggio dei gruppi (circa i valori, i processi di socializzazione, di crescita personale e trasformazione culturale ... )?

I problemi educativi
Dopo aver verificato, attraverso l'uso appropriato della griglia di analisi, la «vita» dei proprio gruppo, vedere come i problemi educativi accennati nel quaderno sono riscontrabili, e con quale intensità, e ipotizzare delle vie di uscita.













































