I Quaderni dell'animatore
7. LA SCELTA
DELL'ANIMAZIONE
NELL'EDUCAZIONE
ALLA FEDE
Riccardo Tonelli
INDICE
1. IL PROBLEMA: SI PUO EDUCARE ALLA FEDE NELLO STILE DELLANIMAZIONE?
2. LA DIMENSIONE EDUCATIVA DELLA EVANGELIZZAZIONE
2. 1. La prospettiva incarnazionista
L'evento Gesù Cristo
Fedeltà a Dio nella fedeltà all'uomo
Due importanti distinzioni
2.2. La prospettiva «gerarchica» e quella «dialettica»
Il modello gerarchico
Il modello dialettico
2.3. L'educabilità della fede nella logica della sacramentalità
2.4. Dove e come si realizza l'educazione alla fede
Separazione e dipendenza
La sacramentalità
3. CHE NE FACCIAMO ALLORA DELL'ANIMAZIONE
3.1. L'animazione come modello ideale per l'educazione alla fede
3.2. Una conclusione che è prefazione
4. RIPENSIAMO LA PASTORALE NELLA LOGICA DELL'ANIMAZIONE
4. 1. «L'amore vita» come orizzonte della pastorale giovanile
Prima scommessa: l'uomo è già l'uomo nuovo
Seconda scommessa: l'uomo è capace di autoliberarsi
Terza scommessa: la passione per la vita
In sintesi: la scommessa dell'educazione
4.2. La relazione educativa: come esercitare l'autorità pastorale
Accoglienza incondizionata
I valori per nome Un'esistenza che si fa messaggio
Le condizioni culturali e strutturali
4.3. Educare alla fede comporta offerto di contenuti oggettivi?
In che senso «contenuti oggettivi
Un evangelo come racconto di una storia a tre storie
Un progetto da realizzare «assieme»
4.4. Chi vivo di fede un solitario che siede e mensa con tutti
Vivere di fede: leggere dentro le cose con «fantasia»
La solitudine del credente
4.5. / punti di riferimento di ogni progetto
5. LA CONCLUSIONE: ANIMAZIONE E PERSONAL COMPUTER
Bibliografia
Il presente quaderno non tratta immediatamente di animazione culturale e non è scritto da un esperto di tale disciplina, ma da un esperto di pastorale giovanile per chiarire i rapporti tra il mondo dell'animazione e il mondo dell'educazione alla fede.
^ Riccardo Tonelli ha riletto i quaderni 5 e 6 di Mario Pollo sull'animazione culturale e li ha ripensati dal suo punto di vista: elaborare un modello di educazione alla fede ispirato all'animazione.
La domanda di fondo è: l'animazione, come modello educativo attraverso cui «dare vita» alla formazione dei giovani, può essere anche un modello educativo per «dare vita» all'educazione della fede?
^ Il problema è delicato e cruciale per più motivi.
Incominciamo ad osservarlo dal punto di vista dell'animazione. E proprio la «pretesa» dell'animazione culturale a complicare le cose...
L'animazione culturale, e il modello educativo che ne deriva, se introdotti ad esempio in un centro giovanile, rifiutano di essere confinati a un insieme di tecniche e strumenti per «vivacizzare» il tempo libero o anche per «animare la liturgia», e «pretendono» di essere un modo preciso per riformulare tutta la vita dei centro giovanile. Compresa l'educazione alla fede.
Il problema non è meno delicato dal punto di vista della educazione alla fede.
Molti operatori pastorali sono ben disposti verso un'animazione che si occupi dei tempo libero e dei come dar vita alla liturgia e alla preghiera...
Le perplessità cominciano di fronte alla pretesa dell'animazione di aver delle cose da dire proprio nell'educare alla fede. Come possono le «scienze umane» sulle quali si fonda l'animazione aver qualcosa da insegnare su come educare alla fede?
^ Una risposta va cercata nella «memoria ecclesiale» che percorre la storia da Gesù Cristo ad oggi.
È questo il punto nevralgico dei quaderno.
La risposta viene data in due tempi.
In un primo tempo R. Tonelli, riflettendo sull'evento dell'incarnazione, arriva a giustificare la «presenza» delle scienze dell'educazione nel fare la proposta di fede.
Una volta compiuto questo passo ne compie un altro, non meno delicato.
Se l'educazione alla fede «assume» un modello educativo, non lo fa indifferentemente: ha delle «condizioni» da porre e delle esigenze da salvaguardare.
Ecco il secondo passo: l'animazione è in grado di rispettare queste esigenze?
Anche a questa domanda la risposta è positiva. Anzi l'animazione è un modello educativo oggi decisivo per l'educazione alla fede.
^ Si era partiti dall'interrogativo: l'educazione alla fede può «fare spazio» al suo interno all'animazione? e si è giunti alla conclusione che non solo l'educazione alla fede può «accogliere» al suo interno lo stile educativo dell'animazione, ma è anzi sollecitata a riformulare antropologie educative, obiettivi generali e specifici, strategie e interventi. Cosa comporta in concreto questa «scelta dell'animazione» nell'educare i giovani alla fede? A questo interrogativo R. Tonelli risponde in due tempi.
In un primo tempo si sofferma su alcuni «esempi» di pastorale giovanile ispirata all'animazione: l'orizzonte della passione per la vita, l'autorità pastorale ed il modo di esercitarla, come proporre i «contenuti» della fede, indicazioni per determinare l'obiettivo generale della pastorale giovanile.
In un secondo tempo esplicita alcuni «orientamenti» per avviarsi ad un progetto di pastorale giovanile ispirato all'animazione.
1. IL PROBLEMA: SI PUÒ EDUCARE ALLA FEDE NELLO STILE DELL’ANIMAZIONE?
Questa ricerca parte da un problema preciso e concreto.
Lo esprimiamo in sintesi. E poi lo approfondiremo in modo più analitico.
Il problema è serio e importante. Molti se lo pongono in termini riflessi. Spesso però fa solo da fondale delle piccole o grosse discussioni che si scatenano, nelle comunità ecclesiali, quando si fanno le programmazioni pastorali. Ce lo sentiamo rimbalzare addosso quando parliamo di questo nostro progetto in corsi e convegni.
Per non restare imprigionati nella rete di un nemico misterioso, ma, soprattutto, per fare scelte consapevoli e riflesse, in un ambito vitale come è quello in cui operiamo, è importantissimo rendersi conto criticamente del problema e delle sue possibili soluzioni.
Qual è dunque questo impegnativo problema?
In breve, eccolo: si può educare alla fede secondo il modello educativo dell'animazione? O, se si preferisce con altre parole, quando operiamo nell'ambito specificamente ecclesiale, quando ci preoccupiamo di far crescere la fede, la speranza, la carità, il modello educativo dell'animazione serve, funziona, è adeguato, oppure è stonato, inutile, dannoso? Qualcuno può sorridere: tutto qui?
Nella prassi concreta, molti hanno già risolto la faccenda, dando una risposta piena: sì, eccome! Se però sono sollecitati a dare le motivazioni, entrano un poco in crisi o naufragano in una superficialità spaventosa. E così aumentano ragioni di conflitto tra posizioni pastorali opposte.
Cosa lascia intravedere il problema?
Per procedere assieme nell'affrontare e risolvere questo problema, dobbiamo precisare meglio la sua portata.
^ L'animazione non è uno strumento indifferenziato, pronto ai mille usi: come un martello che, bene o male, può servire a piantare qualsiasi genere di chiodi su qualsiasi superficie. L'animazione è un modello di reazione educativa, come è stato indicato negli altri quaderni.
Essa rappresenta quindi uno stile di presenza dell'educatore, un tipo di processo formativo, un determinato rapporto adultogiovane e si porta dentro un suo modello d'uomo. Due cose (lo stile di presenza-rapporto e il modello d'uomo) che sono tutt'altro che indifferenti rispetto ai processi caratteristici dell'educazione alla fede.
^ L'educazione alla fede esige, infatti, una precisa funzione evangelizzatrice: richiede cioè una presenza che propaga un progetto dì vita. Senza questa offerta non si può crescere nell'esistenza cristiana, perché la fede è dono che irrompe nella storia personale, grazie all'annuncio dì una buona notizia gratuita e imprevedibile.
L'educazione alla fede è inoltre finalizzata a far nascere un uomo nuovo. Lavora cioè per far «nuovo» l'uomo: nuovo non a caso, come viene, ma secondo la radicale novità che è Gesù Cristo.
L'uomo nuovo è perciò caratterizzato da alcuni tratti di personalità, normativi per la personale autoprogettazione. Pensiamo, per esempio, alla capacità di sconfiggere il male perdonando, all'autorealizzazione costruita sulla decisione di morire per vivere.
Se l'animazione si porta dentro un suo progetto d'uomo, ci potrebbe essere un conflitto insanabile tra questi due modelli. Immaginiamo, solo per fare un esempio, al conflitto che si scatenerebbe tra animazione ed educazione alla fede, se animazione volesse dire permissivismo o rifiuto dì ogni proposta diversa da quello che piace. In questo caso, dovremmo arrivare alla conclusione di non poter utilizzare l'animazione nell'educazione alla fede, per evitare queste pericolose dissonanze.
Se questa fosse l'ipotesi definitiva, la conclusione si farebbe ancora più pesante: non solo non possiamo educare alla fede con il modello dell'animazione, ma dobbiamo abbandonare velocemente l'animazione anche nella prassi educativa, se intendiamo, presto o tardi, aprirla verso la pienezza di una esperienza di vita cristiana. Come si vede, il problema è tutt'altro che irrilevante e non è per niente teorico.
La nostra proposta globale
Coloro che contestano la scelta dell'animazione, non lo fanno per partito preso. Essi sono condizionati, più o meno riflessamente, dalla soluzione che si dà a questo problema.
La nostra risposta è molto diversa, come si può ben immaginare. Crediamo nell'animazione non solo nell'ambito educativo; la stimiamo preziosa e indispensabile anche in campo di educazione alla fede, pur sottolineando un suo limite strutturale, come vedremo.
Questa è la nostra posizione.
Per mostrare il suo significato, iniziamo un lungo cammino. Dobbiamo partire da lontano ma, passo dopo passo, speriamo di arrivare presto al cuore del nostro problema.
2. LA DIMENSIONE EDUCATIVA DELLA EVANGELIZZAZIONE
Se analizziamo a fondo i termini chiarito in che senso e fino a che dei problema, ci accorgiamo che punto intendiamo prendere sul può essere risolto solo dopo aver serio la voce «educazione» nella formula «educazione alla fede». Dicendo «educazione alla fede» pensiamo ai processi catechistici e a quelli pastorali, agli interventi specifici dell'azione ecclesiale in ordine alla crescita della fede.
In questo contesto, «educazione» è un modo di dire che c'entra poco con l'ambito normale dell'educazione (quello studiato dalle scienze dell'educazione e descritto, ad esempio, dal Q5 e Q6) o, invece, la pastorale possiede una sua reale dimensione educativa, tanto da poter parlare di «educabilità» della fede?
«Educabilità» della fede è una formula complessa: va precisata per comprendere bene il problema che siamo affrontando.
Educabilità vuoi dire possibilità di intervenire attraverso processi di educazione. Qui parliamo di educabilità della fede: possiamo intervenire sulla fede?
Ci sono due elementi in dialogo: fede, che sappiamo tutti essere un dono di Dio, segno della sua bontà e dei suo amore che supera ogni nostro impegno e progetto, e educazione, che esprime invece lo sforzo attraverso cui l'uomo aiuta sé e gli altri a costruirsi progressivamente.
A prima vista, i due elementi non vanno proprio d'accordo: si escludono a vicenda o si influenzano tanto da «rovinarsi». Se insistiamo troppo sull'educazione, salta la gratuità della fede; se insistiamo troppo sulla fede. l'educazione perde la sua carica di competenza umana e di progettualità e responsabilità personale.
Impostazioni insufficienti
Nella storia dell'azione pastorale, non poche volte ci si è trovati ingolfati in questi pasticci pratici. Pensiamo, per esempio, ai rapporto tra evangelizzazione (su cosa intendere per «evangelizzazione» cf il «documento/1») che investe l'ambito della fede e interventi come la scuola, la cultura, lo sport in cui c'entra l'educazione.
Quando prevale un modello funzionalista, che non rispetta cioè l'autonomia dei valori umani ma li strumentalizza, in vista di fini religiosi, si fa educazione solo per poter evangelizzare. E quindi l'interesse alla scuola, allo sport, alle «cose che piacciono ai giovani», c'è solo come momento di passaggio all'evangelizzazione.
Quando invece prevale un modello riduzionista, che fa cioè coincidere tout court l'umano con cristiano e riduce il compito della Chiesa alla sola promozione sociale e politica dell'uomo, l'educazione è fine a se stessa; in essa si conclude la missione apostolica e ci si rifiuta di progettare altri interventi più esplicitamente evangelizzatori.
Ci sono altri modelli inadeguati. Per esempio, il modello dualista, che distingue ambiti e competenze. La comunità educante soffre così di una specie di «divisione del lavoro»: c'è chi fa educazione e non si impiccia di altre cose, chi ha mansioni di tipo tecnico, chi invece ha la responsabilità evangelizzatrice. L'armonia tra queste persone è salvata dal fatto che nessuno mette il naso nel giardino dell'altro.
E c'è infine un modello esasperatamente soprannaturalista, che vorrebbe ridurre l'evangelizzazione all'annuncio puro, senza alcuna contaminazione antropologica: pieni di fiducia nella sconvolgente potenza della grazia, ci si rifiuta di fare ì conti con le mediazioni umane.
Coloro che si riconoscono in questo modello, sono contrari ad ogni intervento nell'ambito educativo, sociale o politico, affermando che non è compito della Chiesa. Questi compiti sono profani e vanno lasciati ad altri.
Dicendo «educabilità della fede» vogliamo superare questi modelli e tentare una operazione alternativa.
Per dire «quale» sia dobbiamo approfondire la fede stessa, per scoprire cosa vuol dire che è «dono».
Ripartiamo dalla Rivelazione
Consideriamo l'evento che dà origine alla decisione di fede: la Rivelazione.
Essa rappresenta il punto nodale per sapere se si può parlare di educabilità della fede ed eventualmente in che senso.
Il contenuto della Rivelazione è Gesù Cristo: il mistero di Dio in Gesù Cristo.
Questo annuncio presenta un carattere trascendente. Ciò che l'occhio non ha mai visto, l'orecchio mai udito, ciò che nessun linguaggio può esprimere perfettamente: questo è il vero contenuto della Rivelazione.
Considerata la natura, indiscutibile, di questo fatto, si può ancora parlare di dimensione educativa della pastorale?
DOCUMENTO/1
QUANDO SI PARLA DI «EVANGELIZZAZIONE»
In ogni progetto di pastorale il primato spetta all'annuncio del dono di Dio all'uomo, Gesù Cristo il salvatore. Esso è educazione della fede perché afferma la priorità dell'evangelizzazione.
In cosa consiste questa «evangelizzazione»? Quali dimensioni vanno realizzate per rispettarne la priorità? Cosa significa annunciare il dono di Dio?
Una risposta, significativa ed autorevole, la si trova nella esortazione apostolica di Paolo VI Evangelii Nuntiandi (1975).
Una definizione di evangelizzazione
Evangelii Nuntiandi si propone di rispondere a tre brucianti interrogativi: «Che ne è oggi di questa energia nascosta della buona novella, capace di colpire profondamente la coscienza dell'uomo? Fino e che punto e come questa forza evangelica è In grado di trasformare veramente l'uomo di questo secolo? Quali metodi bisogna seguire nel trasformare il Vangelo, affinché la sua potenza posso raggiungere i suoi effetti». (n. 4) Queste domande esprimono in modo articolato un unico interrogativo fondamentale: che cosa è “evangelizzazione”.
Nella meditazione del documento si può maturare una definizione di evangelizzazione. L'evangelizzazione è essenzialmente una testimonianza annuncio dell'evento salvifico di Dio nel Cristo e del messaggio In esso contenuto. Nello stesso tempo essa è pure interpretazione della realtà e della vita, alla luce di tale evento. Finalità specifica dell'evangelizzazione è di suscitare e di far maturare nell'uomo la risposta di fede, cioè un'opzione di vita, libera, responsabile, totalizzante per Gesù Cristo salvatore. Una fede pervasa di speranza e animata da un impegno di amore verso Dio, rivelatosi in Cristo, e verso gli uomini, amati da Dio e fratelli nel Cristo. L'amore ai fratelli implica necessariamente un impegno di umanizzazione e di liberazione.
Testimonianza e annuncio: le due dimensioni dell'evangelizzazione
La proclamazione della buona novella, e quindi l'evangelizzazione, viene realizzata attraverso due processi complementari: la testimonianza di vita e l'annuncio esplicito.
Prima di tutto si richiede la testimonianza. «Ecco: un cristiano o un gruppo di cristiani, in seno alla comunità d'uomini nella quale vivono, manifestano capacità di comprensione e di accoglimento, comunione di vita e di destino con gli altri, solidarietà negli sforzi di tutti per ciò che è buono e nobile, Ecco: essi irradiano, inoltre, in maniera molto semplice e spontanea, la fede in alcuni valori che sono la di là dei valori correnti, e la speranza in qualche cosa che non si vede e che non si oserebbe immaginare. Allora con tale testimonianza senza parole, questi cristiani fanno salire nel cuore di coloro che li vedono vivere, domande irresistibili. perché sono così? Perché vivono in tal modo? Che cosa o chi li ispira? Perché sono in mezzo a noi? Ebbene, una tale testimonianza è già una proclamazione silenziosa, ma molto forte ed efficace della buona novella» (n. 2 1).
Ma la testimonianza non è sufficiente. Essa va interpretata e chiarificata nell'annuncio esplicito. «Anche la più bella testimonianza si rivelerà a lungo impotente, se non è illuminata, giustificata ciò che Pietro chiamava «dare ragione della propria speranza» , esplicitata da un annuncio chiaro e inequivocabile del Signore Gesù. La buona novella, proclamata dalla testimonianza di vita, dovrà dunque essere presto o tardi annunziata dalla parola di vita» (n. 22).
Come si nota dalle espressioni del documento citato, la testimonianza è un fatto profano, legato cioè alla quotidianità e profanità di ogni esistenza storica. Dà testimonianza colui che vive la vita di sempre e di tutti, in un orizzonte di impegno e di valorizzazione tale, da provocare i fratelli in umanità. Dà testimonianza la comunità ecclesiale che costruisce, con tutti gli uomini di buona volontà, un mondo e una storia più umana.
La testimonianza è quindi fondamentalmente legata alla capacità di farsi carico di tutta l'umanità, per promuovere la reciproca umanizzazione, creando le condizioni di vita adeguate (n. 4 1).
Nello stesso tempo la testimonianza è anticipazione reale della salvezza di Gesù Cristo: per questo è già momento di evangelizzazione (e non solo pre-evangelizzazione).
L'annuncio esplicito consiste nell'interpretare questo impegno storico nella sua significatività trascendente, collegando questi processi con il farsi dei Regno. E cioè rivelare Gesù Cristo, che di questa compenetrazione è la fonte e la norma: annunciare l'evento definitivo di salvezza. L'accoglienza di quest'annuncio non è però un semplice fare proprie delle «informazioni» «L'annuncio, in effetti, non acquista tutta la sua dimensione, se non quando è inteso, accolto, assimilato e allorché fa sorgere in colui che l'ha ricevuto un'adesione dei cuore. Adesione alle verità che, per misericordia, il Signore ha rivelato. Ma più ancora, adesione al programma di vita vita ormai trasformata che esso propone. Adesione, in una parola, al Regno, cioè al mondo nuovo, al nuovo stato di cose, alla nuova maniera di essere, di vivere, di vivere insieme, che il Vangelo inaugura.
Una tale adesione, che non può restare astratta e disincarnata, si rivela concretamente mediante un ingresso visibile nella comunità dei fedeli» (n. 23).
A sua volta, quindi, l'annuncio fonda la testimonianza. Infatti l'evento di salvezza spinge a vivere la vita quotidiana in termini di autenticità umana, perché Cristo è rivelazione della verità dell'uomo e quindi di ogni progetto di umanizzazione. Cristo ci propone un modo di essere uomini che, vissuto coraggiosamente, provoca. E quindi si fa testimonianza.
(R. Tonelli)
2.1. La prospettiva incarnazionistica
Non possiamo rispondere in astratto, dimenticando le modalità storiche mediante le quali Dio ha voluto realizzare la Rivelazione.
La Tradizione ci costringe a pensare alla Rivelazione alla luce e nel mistero dell'Incarnazione, perché l'eventoGesù ne rappresenta il contenuto e il modello più radicale.
2.1.1. L'evento Gesù Cristo
L’«eventoGesù» è prima di tutto Gesù stesso, la sua persona, la sua dottrina, la sua vita trascinata fino a sperimentare la morte umana, proposta d'una speranza stabile alla vita nella sua vittoria contro la morte. Noi sappiamo, però, che le parole e le azioni di Gesù non ci sono giunte direttamente, allo stato puro. Esse sono state trasmesse attraverso la testimonianza apostolica.
I discepoli e le prime comunità cristiane, animate dallo Spirito, hanno colto il senso del mistero di Gesù. «EventoGesù» è anche questa comprensione della Chiesa primitiva, espressa nella proposta scritta (i testi scritturistici) e nella sua prassi (le attività e istituzioni della comunità ecclesiale). Per cogliere il significato salvifico dei mistero di Gesù, dobbiamo perciò orientare la nostra ricerca nella direzione della comunità apostolica.
^ I discepoli di Gesù avevano capito di essere amati e pensati da lui. Essi sperimentavano che in Gesù la vita umana trovava un senso: la loro situazione senza speranza e senza sbocco, carica di problemi, diventava in Gesù importante, interessante, affascinante. Era «parte» del Gesù storico con cui dialogavano. Assunta in Gesù, la vita umana era restituita ai discepoli piena di significato. Essi poi compresero che tutto ciò Gesù lo diceva e lo faceva nel nome di quel Dio che chiamava «Padre». Nella bontà che gli uomini sperimentavano in Gesù, nel suo perdono, nella sua proposta di libertà e di gioia, di senso alla vita, c'era il Padre.
In Gesù, Dio era accanto all'uomo. Gli apostoli hanno capito di Gesù una grande cosa, tanto importante che hanno impegnato la loro vita fino alla morte, per annunciarla a tutti gli uomini: quel Dio che Gesù chiamava suo Padre è un Dio «vicino», che accoglie e salva.
Non è solo un Dio che salva... questo lo promettono tutti. Il Dio di Gesù si è fatto «vicino»: tanto in compagnia con l'uomo da farsi uomo. La novità sta qui: Dio salva nella solidarietà. Riempie l'umanità dell'uomo di una grazia così sconvolgente e inattesa da far diventare ogni uomo il Signore della sua vita e della sua storia. La solidarietà di Dio con l'uomo è così profonda e compenetrante, che l'uomo, che ha un bisogno sconfinato di salvezza, diventa capace di salvarsi.
^Dopo la morte e la risurrezione di Gesù la comunità ecclesiale si raccoglie attorno alla persona del Signore risorto, ora presente in un modo nuovo. Animata dal suo Spirito, essa si costituisce, agisce e proclama l'evento di salvezza che ha sperimentato.
Fonda così una sua prassi per continuare l'opera della salvezza: tra le tante alternative possibili con cui rispondere agli interrogativi della storia, la Chiesa ha sempre cercato quelle decisioni che permettevano ad ogni uomo di sentirsi amato da Dio, quelle capaci di consolidare la speranza e la fiducia nella vita oltre la morte: quelle che realizzavano la promozione dei poveri, dei piccoli, di quelli che «non contano», per ricordare loro che di essi è il Regno dei cieli
La comunità ecclesiale ha fatto questo, perché ha capito e annunciato che Gesù stesso aveva vissuto tutto ciò in modo radicale.
2.1.2. Fedeltà a Dio nella fedeltà all'uomo
La meditazione dell'eventoGesù ci fa scoprire una realtà grandissima: nella pastorale siamo sollecitati verso l'assunzione vera e profonda di tutto l'umano, per imitare la prassi di Gesù e quello che di lui hanno compreso e vissuto le comunità apostoliche.
^ Nell'Incarnazione, Dio si è rivelato all'uomo in modo umano; il suo ineffabile mistero è diventato comprensibile ed esperimentabile, perché espresso in mediazioni umane. In Gesù di Nazareth, Dio ha assunto un volto umano non come ci si serve di uno strumento esterno (che in nulla modifica ciò che uno è), per comunicare qualcosa di sé quando si è nella impossibilità di farlo personalmente e direttamente. L'umanità di Gesù è invece ciò che Dio stesso, rimanendo Dio, ha voluto diventare per incontrare e salvare l'uomo.
Gesù manifesta, nella sua umanità, gli aspetti invisibili dei Dio vivente.
^ L'Incarnazione non è solo questo: proprio perché manifestazione di Dio nell'umanità di Gesù, essa è anche la rivelazione più piena sull'uomo. L'Incarnazione definisce che è l'uomo.
Gesù è un uomo, di una umanità come la nostra: è uomo come lo siamo tutti noi. La sua umanità manifesta ed esprime Dio, perché l'umanità dell'uomo è stata fatta (per il dono salvifico della creazione) radicalmente capace di essere manifestazione di Dio. Se l'uomo non fosse l'essere capace di trascendenza, l'essere così aperto da poter essere l'altrodasé, Gesù di Nazareth non potrebbe essere Dioconnoi, perché la sua umanità sarebbe incapace di «offrire una tenda» a Dio.
Oppure si potrebbe fare l'ipotesi contraria: se Gesù è Dio, allora di certo non è uomo come noi; la sua umanità è solo apparente. mente simile alla nostra mentre in realtà è diversissìma, come la luce non ha niente da spartire con le tenebre.
Nella storia c'è stata gente che ha proposto la prima ipotesi (Gesù non è Dio) o la seconda (Gesù è Dio, ma non è un vero uomo). La fede della Chiesa ha difeso serripre con forza e con fierezza che Gesù è uomo, profondamente e veramente uomo e, nello stesso tempo, “Dioconnoi”.
^ Questa grande affermazione ci assicura che la nostra umanità è più grande di quello che possiamo immaginare: è, almeno potenzialmente, autoespressione di Dio.
Gesù è il caso supremo, unico e irrepetibile, dell'attuazione della natura umana. Egli è colui che realizza tutte le potenzialità dell'uomo, raggiungendo in pienezza l'abbandono totale al mistero di Dio. Gesù lo è di fatto; noi lo siamo solo potenzialmente (anche se troppe volte realizziamo la nostra capacità negando ciò che dovremmo esprimere). In questo sta la diversità abissale tra noi e Gesù. Ma la natura umana, che esprime questa possibile manifestazione di Dio, è la stessa, per noi e per Gesù.
^ Non solo non ci può essere conflittualità tra la fedeltà a Dio e la fedeltà all'uomo, ma, in Gesù Cristo, la fedeltà all'uomo (quella fedeltà che opera per fare meno opaca la capacità di essere autoespressione di Dio, quella cioè che salva l'umanità dell'uomo e lo libera dall'alienazione dei peccato) è sempre fedeltà a Dio. Le azioni dell'uomo (lavorare, mangiare, affrontare le difficoltà quotidiane...) hanno acquistato definitivamente un valore supremo e una dignità trascendente, proprio nella loro apparente banalità.
2.1.3. Due importanti distinzioni
La ricomprensione della Rivelazione alla luce dell'Incarnazione ci porta a distinguere tra il suo contenuto (il mistero ineffabile di Dio in Gesù Cristo) e il segno storico in cui esso si incarna (le diverse «parole» umane che hanno la funzione di esprimere questo mistero: prima fra tutte l'umanità di Gesù di Nazareth e, in lui, la nostra umanità).
Possiamo ancora distinguere, sul piano del processo salvifico, tra l'appello ad una decisione personale, libera e totalizzante (che investe il dialogo diretto e immediato tra Dio e ogni uomo e tocca quelle profondità dell'esistenza umana che sfuggono ad ogni processo educativo) e le modalità concrete in cui si realizza il rapporto appellorisposta (modalità educativocomunicative, oggetto quindi anche delle scienze dell'educazione e, in generale, dell'approccio antropologico).
Queste distinzioni sono importanti, perché dal loro esito scaturisce la risposta al problema dell'educabilità della fede: se la Rivelazione assume la vita quotidiana e i suoi dinamismi come suo strumento espressivo, il rapporto tra educazione e fede risulta molto stretto.
DOCUMENTO/2
ACCETTARE SE STESSI È ACCOGLIERE DIO
L'uomo vorrebbe essere libero e poter sperare, comprendere e riconoscere che egli è affidato alla propria libertà, la quale si realizza nel corso della sua vita e lo fa diventare ciò che egli è sotto forma di progetto: un uomo della fedeltà, dell'amore e della responsabilità. Tale storia della libertà fatta di genuina autodeterminazione, si svolge di fatto in mezzo a tutte le piccole cose opache, problematiche, assurde, inadeguate, senza uno scopo tangibile che riempiono la nostra vita.
Io mi accetto
I filosofi e gli altri pensatori possono naturalmente continuare a riflettere senza fine su concetti come quello di libertà, responsabilità, amore, disinteresse, ecc. Tali concetti non sono del tutto chiari e perspicui neppure a noi; ciononostante però essi posseggono già un senso e indicano una direzione alla decisione in mezzo alle mille bagatelle della vita quotidiana. Si potrebbe avere l'impressione che queste parole siano risolvibili psicanaliticamente, biologicamente o sociologicamente e che si rivelino come una sovrastruttura inevitabile di dati molto più primitivi, che rappresentano in fondo la vera realtà della vita umana. Però è sempre l'unico e medesimo soggetto che compie tutti questi tentativi, e in maniera responsabile. Di conseguenza tali distruzioni dell'uomo in fondo risultano false. L'uomo non può e non vuole sfuggire alla libertà responsabile di soggetto genuino; io mi accetto.
Mi accetto nella speranza
Questo sì detto a se stesso viene pronunciato senza un'ultima protesta, però con la piena consapevolezza dei condizionamenti e delle casualità dell'esistenza biologica e storica, anche se, ovviamente, con la coscienza del diritto e del dovere di modificare e di migliorare quanto v'è di opprimente in tali condizionamenti. Comunque non è mai possibile migliorare tutto, in maniera tale che tutto quello ch'io debbo essere sia soltanto il risultato della mia propria decisione. Questa mia realtà rimane sempre punteggiata di dolori e di assurdità. E tuttavia la posso accettare nella speranza, poiché la speranza che tutto abbraccia e sorregge, anche se non ci dà mai la sicurezza definitiva.
Il fondamento della speranza
È possibile convincere qualcuno che tale speranza è un'utopia errata e vile, che è peggiore del lasciarsi andare a uno scetticismo radicale? Tale ultima fiducia originaria nel senso pieno e comprensivo dell'esistenza umana non è un ideologia aleggiante nell'aria. Essa non solo sorregge tutto, ma viene anche sorretta da tutto quel che incontriamo nella vita umana. Quale libero atto fondamentale dell'esistenza umana che possiamo esprimere solo balbettando, essa in fondo si dirige a colui che chiamiamo Dio. La parola «Dio» è sicuramente oscura, però quel che essa indica è presente, o perlomeno può essere presente, anche nella vita di un uomo in cui tale vocabolo non ricorre. L'atto con cui accettiamo con fiducia e con speranza l'esistenza, se non fraintende se stesso, consiste in un abbandonarsi al mistero incomprensibile.
Il cristiano davanti al mistero dell'incontro Dio-uomo
Partendo dal centro più intimo della sua esperienza il cristiano si sa sorretto dal mistero stesso nel suo fidarsi originario e nel suo sperare il compimento della propria esistenza. Così egli chiama questo movimento interiore verso Dio. Il cristiano deve riconoscere che questo movimento interiore esiste ad opera di Dio in ogni uomo che è fedele al dettame della sua coscienza, anche se costui non lo considera ancora movimento verso Dio e non ha ancora colto, in una fede esplicitamente cristiana, la sua comparizione storica in Gesù Cristo.
(da Kari Rahner, Teologia dall'esperienza dello Spirito, Ed. Paoline 1978, pp. 33-37).
2.2. La prospettiva «gerarchica» e quella «dialettica»
La prospettiva della Incarnazione è, allo stato attuale della ricerca pastorale, la prospettiva più affermata.
Non è l'unica però.
Accenniamo ad altri due modelli, con i quali gli educatori sono chiamati a confrontarsi criticamente, sia perché a volte nella comunità educativa alcuni si ispirano al modello incarnazionista ed altri ad uno dei due modelli che ora vedremo, sia perché capita che nelle comunità ecclesiali si arrivi ad uno strano ecclettismo dei tre modelli creando confusione nei giovani.
2.2.1. Il modello gerarchico
Esiste anzitutto un modello gerarchico. È il modello tradizionale. Chi segue questo modello si interessa concretamente della educazione dei giovani, e dunque crea per loro gruppi e centri giovanili, tempi di formazione umana e di discussione sui problemi e attese dei giovani. Ma questo interesse per le «cose dei giovani» è solo occasione o preparazione per una educazione alla fede. Educazione umana ed educazione alla fede vengono accostate, si svolgono negli stessi ambienti, ma non si integrano.
In questo modello si parla molto di educazione della fede e si insiste sugli interventi necessari per attuarla. La voce «educazione» è assunta però in modo analogico rispetto all'uso prospettato dalle scienze dell'educazione. Il contenuto non è infatti elaborato in una ricerca antropologica autonoma, ma viene derivato dalla riflessione teologica.
L'idea di educazione alla fede è infatti derivata da alcuni temi biblici, come, per esempio, la pedagogia di Dio, l'imitazione di Cristo, l'azione della grazia, la figliolanza divina... Dalla meditazione teologica di questi temi vengono determinati deduttivamente i modelli operativi di educazione alla fede.
Le conseguenze sono pesanti. Quando la teologia e la pastorale svuotano di autonomia e di spessore le scienze dell'educazione, si privano del contributo che queste scienze possono offrire nei processi pastorali. Così, in ultima analisi, viene concretamente minimizzata la dimensione educativa della pastorale.
Non solo viene misconosciuta l'autonomia della educazione, ma, come già si accennava, rimane una disintegrazione tra educazione umana ed educazione della fede. E, inoltre, si riduce l'educazione umana che si svolge nei gruppi, nei centri giovanili e nelle scuole cattoliche a «occasione» e «preparazione» ad una evangelizzazione ridotta a puro annuncio e a pratiche religiose.
2.2.2. Il modello dialettico
Accanto al modello tradizionale e a quello incarnazionistico sono presenti alcuni stili educativopastorali riconducibili ad un modello dialettico.
Le origini di questo modello sono complesse. A livello pastorale esso è sorto attorno agli anni '30 come reazione ad un'azione catechistica che tendeva a superare il salto tra giovani ed esperienza cristiana inventando sempre nuove «tecniche» catechistiche. Come reazione a questa eccessiva fiducia nelle tecniche pastorali, si accentuò l'importanza dell'incontro senza mediazioni tra giovani ed esperienza cristiana attraverso lo «studio» e la interiorizzazione della parola dì Dio, la catechesi sistematica, la presenza alle celebrazioni. È la cosiddetta svolta kerigmatica della catechesi.
Tale «reazione» venne successivamente ad alimentarsi alla cosiddetta teologica «dialettica» che, rifacendosi più o meno direttamente alla teologia di K. Barth, considerava il mondo del divino irraggiungibile attraverso qualsiasi mediazione di tipo umano. In conclusione, questo modello rifiuta ogni possibilità di poter intervenire educativamente nell’ambito della educazione e celebrazione della fede.
Questo modello, probabilmente a causa del trapasso culturale che la società moderna sta attraversando e quindi dell'atteggiamento in fondo negativista con cui si vede l'evolversi della condizione umana, il modello dialettico è ben radicato anche nel presente e si esprime in posizioni pastorali che si richiamano a istanze di tipo carismatico; che tendono a creare spazi e comunità di salvezza dentro la società (e dentro la stessa chiesa); a istanze di tipo meditativo orientaleggianti che vedono il futuro della fede nei «rendersi assenti» dall'esperienza storica e fare esperienza di Dio nelle profondità dell'io; a istanze di tipo integrista tese a «redimere» la società non senza riconoscerle autonomia.
2.3. L'educabilità della fede nella logica della sacramentalità
Abbiamo presentato tre modelli: li abbiamo chiamati, con formule un po' schematiche, gerarchico, dialettico, incarnazionistico.
Le persone intelligenti vogliono capire bene dove stanno le differenze, perché è troppo facile distinguere per il semplice gusto di scoprire di essere gli unici ad avere ragione...
Dobbiamo riflettere attentamente sulle cose dette.
E Nell'esperienza cristiana che i tre modelli cercano di descrivere, sono tutti d'accordo nel riconoscere che bisogna distinguere tra i contenuti e i segni che li esprimono.
Quando scriviamo «Dio è un padre buono e accogliente», produciamo dei segni grafici, utilizzando un alfabeto e la sua articolazione nella lingua italiana. La stessa cosa la possiamo dire o scrivere in cinese o nel linguaggio dei calcolatori.
I segni variano; il contenuto resta.
Contenuto è quel grande mistero di amore che è Dio per ogni uomo. Segni sono le parole e i gesti che lo rendono presente.
Abbiamo con l'esempio richiamato quella distinzione tra contenuti e segno di cui abbiamo già parlato.
Assodato questo, possiamo chiederci: in che rapporto sta il contenuto al segno e viceversa? E più importante il contenuto o il segno? Si può arrivare al contenuto passando attraverso al segno o il contenuto è così inaccessibile che non c'è segno capace di svelarlo? I diversi modelli si differenziano proprio qui: nel dare risposte diverse a queste domande.
2.3.1. Separazione o dipendenza
Nel modello gerarchico prevale la logica della dipendenza: dalla comprensione teologica dei contenuto vengono derivate le regole della sua comunicazione e definite le strutture educative di mediazione. In qualche modo, il «mistero» travolge il «visibile» che lo veicola, per la fiducia incondizionata deposta nell'efficacia intrinseca dell'evento.
Nel modello dialettico prevale la distinzione: la separazione degli ambiti risolve a suo modo il difficile problema dei rapporti. L'ambito educativo possiede una sua pregnanza autonoma; ma esso è considerato radicalmente inadeguato ad esprimere l'ineffabile e inadatto a far avvicinare all'inaccessibile.
2.3.2. La sacramentalità
Il modello incarnazionistico introduce invece la categoria della sacramentalità, come schema cristologico di riconciliazione tra visibile e mistero.
Approfondiamo questa affermazione.
Noi sappiamo che l'esistenza di ogni uomo è tutta segnata dalla presenza interpellante di Dio. Noi viviamo in Dio, per Gesù Cristo. Anche il mondo profano è già da sempre avvolto e penetra io dalla grazia dell'autocomunicazione divina, in esso presente sempre e dappertutto.
Questa presenza diffusa della salvezza di Dio è ormai il principio costitutivo di ogni esistenza, intimo ad ogni uomo più di se stesso. Si tratta evidentemente di una presenza che è offerta alla libertà, che costituisce la libertà stessa: accettata o rifiutata nel cammino progressivo di ogni personale esistenza, colloca nella salvezza o riduce alla pretesa suicida di una folle autonomia.
In questa prospettiva l'umano è il luogo di presenza di Dio, una presenza che tutto lo avvolge.
L'affermazione esige una ulteriore riflessione per precisare meglio in che senso vada compresa questa diffusa e involvente presenza?
Quale presenza?
Esistono molti e diversificati modelli di presenza. È presente l'amico con cui stiamo conversando. Ed è egualmente presente il ricordo dì una persona cara, quando ci sentiamo travolti dalle difficoltà. La prima presenza è sul piano fisico; la seconda è legata solo alla intenzionalità.
Ci può essere presenza fisica senza condivisione intenzionale; e ci può essere percezione totalmente soggettiva di presenzialità; senza alcun riferimento ad una oggettività fisica e costatabile.
La presenza di Dio nell'umano non è una presenza diretta e immediata da costatare e possedere fisicamente. Non è neppure una semplice convenzione logica, un ricordo nostalgico senza riferimento reale. L'umano ha una sua precisa concretezza, che può essere descritta e manipolata. Esso si porta dentro un evento più grande che è la sua ragion d'essere più intima: Dio, che si è autocomunicato ad ogni uomo, in un gesto di impensabile gratuità.
Dio è presente oggettivamente nell'esistenza umana; ma non la travolge; al contrario, proprio per questa presenza essa esiste come realtà dotata di autonomia e di consistenza.
Per questo, nell'umano ciò che si vede e si manipola non è tutta li sua verità: in questa realtà è sempre presente misteriosamente un evento più grande.
Il gioco sacramentale tra visibile e mistero
Questo misterioso gioco può essere descritto in termini d sacramentalità, di rapporto ciò tra un visibile (l'umanità profana dell'uomo), che costatiamo e descriviamo nella nostra sapienza e accogliamo come evento di libertà e di responsabilità, e un mistero che ogni visibile si porta dentro, costituito dalla presenza salvifica di Dio, che confessiamo nella fede.
Riconosciamo che il mistero di Dio prende l'umana carne del visibile concreto e storico di ogni uomo. Esso è incontrabile solo nello svuotamento dei visibile. Riconosciamo di conseguenza che la verità più profonda dell'umano è data dalla sua costitutiva capacità di far trasparire il mistero di Dio.
È affascinante e impegnativo costatare che la trasparenza di Dio è legata, come in Gesù, alla pienezza di umanità. Dio si fa incontrabile non quando gli uomini abbandonano la loro umanità, ma quando la vivono intensamente.
L'umanità, la vita quotidiana dell'uomo è quindi il grande sacramento di Dio nella nostra storia (cf.«documento/3»).
Ritorniamo all'educazione alla fede
Se il mistero ineffabile di Dio è incontrabile solo nel suo visibile umano (quel visibile che lo incarna, lo esprime, lo rende vicino e comunicabile), tutto ciò che permette al visibile umano di diventare più «trasparente» rispetto al mistero di Dio che si porta dentro, abilita all'accoglienza di Dio stesso.
Si giunge perciò al contenuto (esperienza dell'uomo davanti a Dio) solo passando attraverso il «segno» (esperienza di ciò che è umano).
Il dialogo immediato e diretto di Dio che chiama alla salvezza è normalmente servito e condizionato dalle mediazioni pastorali in cui questo dialogo si esprime. Il segno porta al contenuto in quello spessore umano che è oggetto della ricerca antropologica e degli interventi educativi.
DOCUMENTO/3
LA LOGICA DEL SACRAMENTO
Che cos'è un sacramento?
Ogni volta che una realtà del mondo, senza lasciare il mondo, evoca un'altra realtà diversa da essa, questa assume una funzione sacramentale. Cessa di essere cosa per tramutarsi in segno o in simbolo. Ogni segno è segno di qualcosa o di un certo valore per qualcuno. Come cosa può essere assolutamente irrilevante. Come segno può acquistare un valore incalcolabile e prezioso.
Cos'è che rende un qualcosa sacramento?
È che la visione umana interiore delle cose le trasforma in sacramenti. t la convivenza con le cose che le crea e ricrea simbolicamente. t il tempo che perdiamo con loro, è l'affezionarcisi, è il loro inserimento nelle nostre esperienze che le umanizza. e che gli fa parlare il linguaggio degli uomini. 1 sacramenti rivelano un modo tipico di pensare dell'uomo.
Esiste un vero modo di pensare sacramentale, come c'è un modo di pensare scientifico.
Nel pensiero sacramentale, in un primo momento, tutto rivela l'uomo, le sue esperienze bene o male riuscite, infine, il suo incontro con le molteplicità delle manifestazioni del mondo. In questo incontro l'uomo non si accosta al mondo in maniera neutrale. Egli giudica. Scopre dei valori. Interpreta. Si apre o si chiude alle invocazioni che gli giungono. Quanto più profondamente l'uomo ha un rapporto con il mondo e con le cose del suo mondo, tanto più si rivela fa sacramentalità.
Immanenza, trascendenza. trasparenza
Il sacramento racchiude dentro di sé un'esperienza totale.
Il mondo non è soltanto diviso In immanenza e trascendenza. Esiste un'altra categoria intermedia, la trasparenza, che accoglie in sé sia l'immanenza che la trascendenza. Queste ultime non sono realtà opposte. Una di fronte all'altra. Che si escludono. Ma sono realtà comunicanti e che si incontrano. Esse si permeano, si congiungono, si combinano, si consociano, si collegano, si concatenano, si comunicano e convivono una nell'altra.
Trasparenza significa esattamente questo: il trascendente diventa presente nell'immanente, facendo sì che questi diventi trasparente per la realtà di quello. Il trascendente irrompendo nell'immanente trasfigura l'immanente. Lo trasforma in trasparente.
Comprendere tutto ciò è comprendere il pensiero sacramentale e la struttura del sacramento. Non comprenderlo significa non comprendere niente del mondo dei simboli e dei sacramenti.
Il sacramento (trasparenza), pertanto, è parte di due mondi: del trascendente e dell'immanente. Tutto ciò non è senza tensioni e tentazioni. Il sacramento può farsi immanente escludendo la trascendenza. Allora diventa opaco: senza lo splendore della trascendenza che trasfigura il peso della materia. Il sacramento può farsi trascendente, escludendo l'immanenza. Allora diventa astratto. Perde la concretezza che l'immanenza conferisce alla trascendenza. In tutti e due i casi si è perduta la trasparenza delle cose. Si è corrotto il sacramento.
Visto partendo da Dio, tutto è sacramento
Fino adesso abbiamo considerato i sacramenti umani. Tutte le cose esprimono e simbolizzano l'uomo. Sono sacramenti umani. Quanto più lasciamo che le cose entrino nella nostra vita, tanto più esse manifestano la loro sacramentalità, cioè, diventano significative e uniche per noi. Esse evocano i nostri rapporti con loro.
Ci sono sacramenti divini.
Un uomo possiede una profonda esperienza di Dio. Dio non è un concetto appreso dal catechismo. Nemmeno è il vertice della piramide che chiude, armoniosamente, il nostro sistema di pensiero. Ma è un'esperienza interiore che tocca le radici della sua esistenza. Senza di Lui tutto sarebbe assurdo. Non comprenderebbe neanche se stesso. Tanto meno il mondo. Dio gli appare come un Mistero totalmente assoluto e radicale che si annuncia In tutto, tutto penetra e in tutto risplende. Se Egli è l'unico Assoluto, allora tutto quanto esiste è una rivelazione di Lui. Per chi vive Dio in questa maniera, il mondo immanente diventa trasparente grazie a questa divina e trascendente realtà.
Il mondo rimane diafano. Come diceva Sant’Ireneo: «Di fronte a Dio, nulla è vano. Tutto è un suo segno». Parla di Dio. Della sua bellezza, della sua bontà. Del suo mistero.
L'uomo non è soltanto un uomo. E il più grande sacramento di Dio, del suo intelletto, del suo amore e del suo mistero.
Gesù di Nazaret è qualcosa di più dell'uomo della Gafflea. t il Cri 1 sto,
Il sacramento vivo di Dio, incarnatosi in Lui.
La Chiesa è qualcosa di più della società dei battezzati. È il sacramento di Cristo che si fa presente nella storia.
Per colui che vede tutto partendo da Dio, il mondo tutto è un grande sacramento; ogni cosa, ogni evento storico provengono come sacramenti da Dio e dalla sua divina volontà. Ma questo è possibile soltanto per chi vive Dio. In caso contrario il mondo è opaco, è realtà meramente immanente.
(da L. Boff, I sacramenti della vita, Borla 1979, pp. 2425; 3233; 3638)
2.4. Dove e come si realizza l'educazione della fede
Le motivazioni che ci hanno spinto a definire il criterio dell'Incarnazione orientano logicamente la nostra preferenza per quest'ultima prospettiva. Per questo parliamo di una precisa educabilità della fede e intendiamo «educazione» nel significato tecnico sollecitato dalle scienze dell'educazione.
Esprimiamo questi orientamenti con alcune affermazioni concrete: sono in sintesi il nostro punto di vista sul problema.
^ Prima di tutto è indispensabile affermare che non si dà educazione diretta e immediata della fede. La fede si sviluppa sul piano misterioso dei dialogo tra Dio e ogni uomo. Questo spazio esistenziale sfugge ad ogni approccio antropologico e va riconosciuta in esso la priorità dell'intervento di Dio. La risposta dell'uomo sta in modo costitutivo nell'obbedienza accogliente. La fede è dono dall'alto, nel senso più pregnante. Proviene quindi dall'udire e non dal riflettere, è accoglienza e non elaborazione.
^ Questa immediatezza e radicalità viene servita, sostenuta, condizionata dalle mediazioni umane che hanno la funzione di attivare il dialogo salvifico e di predisporre alla accoglienza.
Questo è l'ambito preciso della educabilità della fede. Essa si colloca sul piano delle mediazioni storiche in cui concretamente si realizza questo dialogo salvifico. Le mediazioni hanno una funzione molto importante: senza di esse non si realizza il processo di salvezza.
L'educazione è quindi una dimensione irrinunciabile della pastorale giovanile.
^ Infine è importante affermare, in una fede confessante, la priorità dell'intervento divino anche nell'ambito educativo più direttamente manipolabile dall'uomo e dalla sua cultura.
La fede dunque riconosce «la grandezza dell'educazione», il fatto cioè che liberando le capacità dell'uomo libera la sua capacità di risposta responsabile e matura a Dio.
Ma la fede riconosce che anche l'educazione rimane, come tutti i fatti umani, sotto il rischio e il segno del peccato. La fede dunque deve esprimere un giudizio sull'educazione dell'uomo in genere ed, in particolare, sul modello educativo umano che può essere utilizzato nel proporre la fede alle nuove generazioni.
Questo, in fondo, non è attentato al dovere di rispettare l'autonomia dei fatti umani.
Significa invece che l'approccio educativo e comunicativo è giudicato dall'evento al cui servizio esso si pone. Nel nostro caso, comporta la constatazione che questo approccio, anche se legato a esigenze tecniche, avviene sempre nel mistero di una potenza di salvezza che tutto involve: la grazia salvifica possiede una sua rilevanza educativa, certa e intensa anche se non misurabile attraverso gli approcci delle scienze dell'educazione.
3. CHE NE FACCIAMO ALLORA DELL’ANIMAZIONE?
Con questo bagaglio nutrito di informazioni, possiamo riprendere in mano il problema concreto da cui siamo partiti: l'animazione è utile o dannosa in campo di educazione alla fede?
La fede è la risposta all'appello di Dio. Si tratta, però, di una risposta umana, segnata dalle dimensioni costitutive dell'esperienza quotidiana, anche se sostenuta ed espressa nello Spirito. Esiste quindi un ambito di educabilità alla fede che coincide con il modo di progettarsi e di esistere: l'opzione di fede diventa tanto più libera, responsabile, matura e autentica, quanto più la persona attua in sé un processo di educazione liberatrice e umanizzante.
Oggi si è sufficientemente concordi nel concepire l'animazione come un originale «stile educativo» in quanto promozione di un processo critico di liberazione e di umanizzazione, che ha lo scopo di maturare le persone e le comunità umane.
Questo processo avviene necessariamente al di dentro di un processo di socializzazione, gestito fondamentalmente dalle forze egemoni dei sistema sociale, economico, politico, culturale, attraverso l'utilizzazione delle differenti agenzie educative. L'animazione per la sua funzione critica nei confronti del semplice processo di socializzazione si qualifica sempre come processo di liberazione, mentre la socializzazione ha una funzione prevalentemente integratrice.
Questo impegno di liberazione avviene soprattutto attraverso una crescente umanizzazione delle singole persone e delle comunità. Sia le une che le altre sono stimolate a scoprire le loro aspirazioni autenticamente umane e a realizzarle liberamente in contrasto con il quadro di valori privilegiato dal sistema dominante. Dire animazione perciò significa dire promozione della capacità critica, per una espressione autentica di creatività, personale e sociale. E quindi significa dire «liberazione umanizzante», in funzione della maturazione di ogni persona nella società concreta dì cui è parte e in cui opera.
3.1. L'animazione come modello ideale per l'educazione alla fede
Certamente è dono di Dio quell'opzione globale di fede, che l'evangelizzazione ha lo scopo di suscitare e su cui interviene l'azione pastorale, per esplicitare, consolidare, sostenere, fino a dare ad essa significato di un'opzione di vita, definitiva e totalizzante. Ma è anche atto umano, soggetto a tutti i condizionamenti umani di ogni scelta libera e responsabile. Perciò, in quanto atto umano, l'opzione di fede maturerà man mano che il giovane attiverà quel processo di animazione umanizzante che lo promuove in quanto persona umana. E troverà consistenza e autenticità esistenziale, in rapporto alla stabilizzazione nella sua struttura di personalità di uno stile di vita e di progettazione di sé, corrispondente alle dimensioni fondamentali del progetto di umanizzazione offerto dal Padre, in Cristo, l'uomo nuovo.
In conclusione lo stile dell'animazione esprime alla perfezione le note pedagogiche con cui abbiamo definito il processo richiesto per l'educazione della fede.
Possiamo così dire a piena voce che l'animazione rappresenta il modello educativo ideale per realizzare le esigenze che scaturiscono dalla dimensione educabile della fede.
Per questo, l'animazione è strumento privilegiato non solo per educare, ma anche per intervenire nell'educazione alla fede.
Certamente l'educazione alla fede non si può ridurre ad animazione: non solo perché essa ha contenuti specifici che possono essere espressi solo per Rivelazione; ma anche perché ci sono interventi che sfuggono misteriosamente alle categorie educative umane.
Si può però fare molto bene l'educazione alla fede se si assume il modello educativo dell'animazione.
In questo senso la catechesi e la pastorale vanno a scuola di animazione, per imparare dai «tecnici» una relazione educativa e comunicativa umanizzatrice e liberatrice.
3.2. Una conclusione che è prefazione
Nelle prime pagine ci siamo chiesti: si può utilizzare il modello educativo dell'animazione anche nei processi che investono l'educazione alla fede?
Dopo un lungo cammino, in cui abbiamo riscoperto l'Incarnazione come evento normativo di ogni progetto pastorale, siamo arrivati ad una decisione: l'animazione rappresenta un modello educativo privilegiato per rispettare quella dimensione educativa che inesorabilmente segna anche l'educazione alla fede. Alla domanda appena ricordata possiamo dare una risposta pienamente affermativa. Non possiamo però concludere qui la nostra ricerca.
Le lunghe riflessioni fatte assieme ci sollecitano ad un salto di qualità.
Nel confronto con l'evento dell'Incarnazione abbiamo riscoperto l'umano come il grande segno dell'amore di Dio.
Questa costatazione non ci serve solo per fare spazio all'animazione nella pastorale. Ci costringe anche a progettare un modello dì pastorale che prenda sul serio la grande dignità dell'umano, superando quei modelli che invece lo svalutano per far meglio posto all'azione di Dio. Per noi prendere sul serio l'umano in campo educativo vuoi dire scegliere l'animazione come stile globale.
Ecco allora il problema che si apre davanti a noi: come fare pastorale assumendo seriamente l'animazione?
Ci siamo chiesti se potevamo usare l'animazione nella pastorale e ci siamo trovati nella necessità di ripensare a fondo la nostra pastorale.
4. RIPENSIAMO LA PASTORALE NELLA LOGICA DELL'ANIMAZIONE
Siamo arrivati al punto più caldo della nostra riflessione: come ripensare la pastorale giovanile nella logica dell'animazione?
La pastorale giovanile ha un suo bagaglio di strumenti per l'azione: alcuni sono pronti all'uso; altri sono più teorici.
Li dobbiamo verificare tutti per vedere se sono adeguati per educare alla fede «animando». Qualcuno va buttato, perché è stato pensato per altri stili (autoritari o troppo permissivi); alcuni possono essere rimodernizzati con qualche colpo di pennello; altri, per fortuna, sono già perfetti
Rimontando poi i diversi strumenti, riformulati nella logica dell'animazione, abbiamo un progetto di pastorale giovanile in stile di animazione. E così, in qualche modo, il processo si chiude: animazione e educazione alla fede si fondano in un unico modello di pastorale.
Operiamo mettendo a confronto le esigenze della pastorale e quelle dell'animazione per cercare un modello operativo che le rispetti pienamente. Non si tratta di tentare strani equilibrismi o, peggio, di strumentalizzare una dimensione all'altra; ma di inventare qualcosa di nuovo rispetto alla prassi corrente che sia fedele nello stesso tempo alla grande tradizione cristiana. Questa «strana» equazione si chiama circolo ermeneutico: circolo, perché si attiva un dialogo fatto di dare e ricevere; ermeneutico, perché si realizza secondo le regole di quella scienza giovane e rivoluzionaria che sì chiama appunto «ermeneutica». Per un approfondimento cf il «documento/4».
Questa è l'impresa che tentiamo di realizzare.
Se volessimo suggerire una proposta organica e adeguata, il discorso diventerebbe lungo. Dovremmo scrivere un trattato di pastorale nella logica dell'animazione.
Facciamo invece una cosa più semplice: proponiamo solo qualche esempio, selezionando i punti nodali di tutto il processo e lasciamo alla fantasia di chi legge l'impegno di continuare la ricerca.
4.1. «L'amore alla vita» come orizzonte della pastorale giovanile
E veniamo al primo «esempio». L'animazione è anzitutto una «antropologia», una visione di uomo carica di speranza che si esprime in una scommessa sull'uomo, al di là di ogni delusione e contraddizione.
Può la pastorale giovanile fare sua questa scommessa antropologica? L una domanda delicata e bruciante. Delicata perché troppo spesso la proposta cristiana è tutt'altro che una scommessa sull'uomo. Come non riconoscere la sfiducia di fondo verso l'umano di cui è intriso il linguaggio ecclesiale?
Bruciante perché questa domanda viene a porsi in un momento di crisi e di trapasso culturale, dove, al contrario degli anni dei Concilio in cui come riconobbe Paolo VI la chiesa «fissò il suo sguardo più sul volto felice che sul volto infelice dell'uomo», sono in troppi a guardare con paura e angoscia al presente e al futuro dell'uomo.
Può dunque la pastorale giovanile riesprimere se stessa come «passione per l'uomo e per la vita»?
La risposta va cercata riconfrontandoci con il grande evento dell'Incarnazione.
L'Incarnazione è, in fondo in fondo, una grande scommessa. In Gesù di Nazareth, Dio scommette follemente sull'uomo.
Rileggiamo la parabola dei vignaioli ribelli.
Il padrone della vigna, quando costata che gli hanno malmenato servi e soldati, «scommette» che le cose cambieranno perché manda suo figlio a trattare con i dipendenti in sciopero.
Fedeli all'Incarnazione, è possibile fare pastorale animando, solo se facciamo anche noi una sconfinata scommessa sull'uomo.
Per essere concreti la proponiamo in tre movimenti:
- l'uomo è già uomo nuovo;
- l'uomo è capace di autoliberarsi;
- la passione per la vita.
Non sono scommesse facili, come non era facile né logico per il padrone della vigna scommettere che mandando suo figlio avrebbe risolto la dura vertenza.
Sono scommesse praticabili solo nella fede e nella speranza.
4.1.1. Prima scommessa: l'uomo è già l'uomo nuovo
L'animazione ha una sua antropologia: definisce l'uomo secondo alcune dimensioni, innovative rispetto a quelle spesso utilizzate nei processi educativi e pastorali. Sono già state ricordate nei precedenti quaderni.
Ci siamo richiamati genericamente ad esse per ricordare che proprio a questo livello sta l'impossibilità o la possibilità di assumere il modello dell'animazione nell'educazione alla fede.
Abbiamo risolto il problema, affermando che bisogna prendere sul serio l'autonomia della ricerca antropologica (senza pretendere di sapere già tutto solo perché confessiamo che Gesù è il Signore).
Aggiungevamo anche, in quel contesto, una nostra convinzione: l'uomo della libertà e della responsabilità è esattamente il modello d'uomo di cui abbiamo bisogno per costruire l'uomo nuovo dell'esperienza cristiana.
Leggendo attentamente quello che abbiamo scritto in proposito è facile accorgersi che ci siamo quasi infilati in un ginepraio e n, siamo usciti solo a suon di affermazioni poco dimostrate.
L'impressione è parzialmente corretta.
Una ragione fondamentale però ci ha spinti a questo salto di qualità.
Ogni antropologia parte da una metafisica. E la metafisica lo sappiamo ormai bene è una scommessa, uno sguardolampo un poco indimostrabile, tanto vero però (almeno soggettivamente) che ciascuno è disposto a costruirci sopra il proprio sistema concettuale.
A monte delle cose dette, stava una nostra «metafisica»: una scommessa sull'uomo tutta giocata nella fede e nella speranza che scaturisce dall'Incarnazione. Questa scommessa fonda il confronto tra l'uomo dell'animazione e l'uomo della fede. E ci autorizza a riconoscere il pieno accordo.
Quale scommessa?
Nel nome di Gesù il Signore, noi affermiamo che l'uomo quotidiano è già l'uomo nuovo. Il presente è segnato germinalmente dal suo futuro.
L'uomo è nuovo perché è stato «ricostruito» così in Gesù. La novità è un dono; ma nello stesso tempo è una chiamata a responsabilità.
La novità è un progetto, consistente, serio e concreto.
Così, l'uomo nuovo si fa progressivamente nuovo nel suo quotidiano attraverso quella fatica di vivere in cui si mette a frutto il dono di novità.
Questa è la nostra scommessa sull'uomo.
Su questa prima scommessa possiamo credere all'animazione anche nell'educazione alla fede.
La grande fiducia nell'uomo che l'animazione richiede è radicata e amplificata dall'evento dell'Incarnazione.
DOCUMENTO/4
IL CIRCOLO «ERMENEUTICO»: UNA FEDE IN DIALOGO CRITICO CON LE CULTURE
Il circolo ermeneutico non investe solo il rapporto tra pastorale e animazione, ma interessa tutta la pastorale. Una pastorale giovanile in stile di animazione è un continuo intreccio di «fede» e «cultura». La quarta assemblea generale del Sinodo del Vescovi ha posto in modo preciso il problema dell'acculturazione della fede: «La diversità della cultura crea alla catechesi un'ampia pluralità di situazioni. Come è stato già indicato dal Conciflo Vaticano Il ed è stato nuovamente ricordato da Paolo VI nell'Esortazione Apostolica «Evangeli! Nuntiandi», il messaggio cristiano deve radicarsi nelle culture umane e deve assumerle e trasformarle. In questo senso è legittimo considerare la catechesi uno degli strumenti di «acculturazione» cioè che sviluppa e nello stesso tempo illumina dall'interno le forme di vita di coloro ai quali si rivolge. La fede cristiana, attraverso la catechesi, deve incarnarsi nelle culture. La vera incarnazione della fede per mezzo della catechesi suppone non soltanto il processo del dare, ma anche quello del ricevere».
Detto in altre parole, l'acculturazione della fede comporta due elementi: da una parte, la fecondazione di una cultura da parte della fede cristiana, mediante lo sforzo degli annunziatori del Vangelo di presentarla incarnata nelle forme e nei termini di quella cultura; dall'altra, la germinazione della fede all'interno di una cultura e lo sforzo e la capacità di questa di riesprimerla, secondo il proprio genio, in forme originali.
Dare e ricevere tra cultura e fede
In effetti la Parola di Dio, contenuta nella Rivelazione e espressa nella evangelizzazione, per poter essere parola per l'uomo, deve esprimersi nelle parole dell'uomo: assume sempre la cultura concreta di un'epoca storica (e, in tempo di pluralismo culturale, una cultura tra le tante), in un processo che realizza la stessa logica dell7ncarnazíone (DV 14
Non è facile distinguere tra contenuto trascendente e rivestimento culturale umano, perché la compenetrazione è profonda, come nell'Incarnazione appunto. La cultura umana, inoltre, non è mai neutrale. Essa sempre connota un'mmagine politica di uomo, di storia, di società. Questa dimensione umana, culturale e politica, segna inesorabilmente la Rivelazione e di conseguenza l'evangelizzazione. Sarebbe cosa grave far passare come Parola di Dio le parole umane che la esprimono. L'ermeneutíca è la scienza che studia questi processi. Nata in ambito profano, è stata presto utilizzata ampiamente anche nella teología.
Circolarità (o circolo, come abbiamo messo nel titolo) ermeneutìca significa che il processo tra fede e cultura si sviluppa in modo circolare, in un «dare» e «ricevere» (come ha ricordato il documento con cui abbiamo iniziato il paragrafo).
Per questo la fede è una potente forza di umanizzazione, nel senso che sollecita ad essere uomini secondo un progetto di «uomo nuovo» rivelato da Dio in Gesù Cristo. Nello stesso tempo, si umanizza, prendendo l'umana carne di una concreta cultura.
Ogni cultura ha la capacità di far emergere dimensioni nuove e insperate della fede.
Essa sottolinea con maggior insistenza alcuni aspetti che prima potevano essere messi in secondo piano e intreccia consequenzialità che introducono una ventata di novità.
La condizione giovanile può «dare» mentre «riceve»
L'insieme degli elementi culturali che segna l'attuale condizione giovanile non è allora solo il luogo di una acculturazione passiva, ma esercita una vera funzione di spinta in avanti. di stimolo al progresso. Costringe la comunità ecclesiale a cogliere, nell'immensa ricchezza dell'evento di salvezza, quelle dimensioni che lo rendono salvifico per questi giovani. 1 giovani non sono perciò solo destinatari dell'evento, ma lo fanno esistere, gli danno quella umana carne per cui «è», qui ora.
La fede però ha sempre una funzione critica e normativa rispetto ai processi di acculturazione.
Non si può pretendere che ogni espressione culturale possa adeguatamente «dire la fede» o che i modelli giovanili siano corretti solo perché corrispondono alla sensibilità e ai bisogni dei giovani Esistono culture e forme di vita giovanili troppo lontane dalla fede e dalla sua logica: esse non possono fornire il supporto al processo di acculturazione. Prima vanno «umanizzate», anche mediante il contributo critico che proviene dalla fede, e poi potranno esprimere l'evento di Dio in modo rinnovato rispetto al passato.
(Riccardo Tonelli)
4.1.2. Seconda scommessa: l'uomo è capace di autoliberarsi
La prima scommessa la possono fare solo persone con i piedi per terra. È strano; sembrerebbe più vero il contrario.
Diciamo che l'uomo è nuovo, perché costatiamo i suoi limiti, le resistenze, le involuzioni, i tradimenti.
L'uomo è povero, incerto, traditore e peccatore. Ma non è solo questo. Egli è già uomo nuovo ' L'uomo nuovo è l'uomo povero, incerto e peccatore.
Può fare la prima scommessa solo chi accetta impietosamente di misurarsi con l'assurdo antropologico della croce di Gesù.
Da questo realismo nasce la seconda scommessa. Essa è risposta all'interrogativo: come diventare progressivamente uomini nuovi?
Affermiamo: diventiamo uomini nuovi liberandoci», portando cioè a maturazione il dono della libertà.
Il dono della libertà ci ha già investito: per questo l'uomo è diventato capace di «autoliberazione». Siamo stati fatti così grandi che bastiamo a noi stessi. Liberazione è autoliberazione.
Questa scommessa è riconoscimento della potenza di salvezza di Dio.
Diventa immediatamente grande, sconfinata fiducia nell'uomo. L'uomo si salva nel tempio intimistico della sua coscienza.
Questo processo è attivato dalla presenza inquietante degli altri. L'altro è dono che mi aiuta a rientrare in me stesso.
La relazione asimmetrica (tra diversi) ha funzione scatenante, attivante, non determinante.
L'animazione è costruita tutta su questa logica: la fiducia incondizionata in ogni persona e, nello stesso tempo, l'esigenza di una presenza educativa, mai rassegnata, per permettere ad ogni persona di riprendere in mano se stesso e la sua storia, fiorendo progressivamente come uomo nuovo.
4.1.3. Terza scommessa: la passione per la vita
Il quotidiano è un gioco continuo e misterioso tra morte e vita. L'animazione scommette per la vita. La vita è la sua passione.
Scommette per la vita, perché si allarghino i confini della vita contro quelli della morte.
Questa è la scommessa: per la vita contro la morte e sulla inesorabile vittoria della vita. L'animazione lotta per la vita, perché è certa della sua vittoria.
Vita e morte sono parole troppo usate; concludendo le affermazioni così, si lascerebbero ancora sul vago.
La scommessa per la vita connota anche un modo di intendere vita e morte.
Vita è dominio delle realtà inferiori all'uomo, creazione di una comunità fraterna, comunione filiale con Dio.
Morte è il suo contrario.
Il dominio della realtà inferiore all'uomo implica, da una parte, arrivare a liberare l'uomo dal suo potere schiavizzante e, dall'altra, impadronirsi delle sue potenzialità.
La creazione della comunità fraterna esige che scompaiano dal mondo gli atteggiamenti, i rapporti e le strutture non fraterne, per crearne altre che siano espressione e sostegno della fraternità.
La comunione filiale con Dio implica, anzitutto, di sradicare dal mondo tutte le forme di paura e di irresponsabilità nel rapporto con lui e ogni tipo di idolatria; inoltre, di far crescere gli adeguati rapporti affettivi e operativi.
Scommettere per «questa» vita è un compito che investe animazione e educazione alla fede; ed è l'orizzonte della speranza operosa in cui il compito viene svolto. Questa scommessa per coinvolgere i giovani deve ulteriormente specificarsi, come ora viene indicato.
4.1.4. La sintesi: la scommessa dell'educazione
Le tre scommesse sono come tre movimenti di un'unica grande sinfonia. La possiamo intitolare globalmente, più concretamente, la scommessa dell'educazione.
La scommessa sull'uomo diventa così servizio per la sua liberazione. Sappiamo di vivere in una situazione di crisi drammatica e complessa. E ci rendiamo conto che l'uomo è al centro di una trama di relazioni politiche, economiche, culturali che lo condizionano e spesso lo soffocano. Credere alla persona significa in questa situazione scommettere che rendere l'uomo felice, restituendogli la gioia di vivere, è una piccola cosa nella mischia delle sopraffazioni, degli intrighi, degli sfruttamenti, della violenza; ma è cosa tanto grande e affascinante, che vale la pena di perdere la propria vita per perseguirla.
Certo, le ragioni della crisi diffusa sono molte e complesse. E richiedono interventi molteplici e articolati. Nell'insieme delle cose da fare, scegliamo la strada dell'educazione.
Non è l'unica cosa da fare. E forse non è neppure quella più efficace.
Ma scommettiamo che può far uscire dalla crisi, se aiuta a vivere e restituisce quel futuro che spesso è defraudato.
Questa nostra scommessa la pronunciamo nel senso più ampio dei termine.
Prima di tutto essa comporta il riconoscimento della forza politica dell'educazione e della sua capacità di rigenerare l'uomo e la società.
La scommessa investe però direttamente anche i processi dell'evangelizzazione.
Si allarga così quel rapporto tra educazione e educazione alla fede di cui abbiamo già parlato: non solo nell'educazione alla fede dobbiamo assumere pienamente la risonanza educativa; ma ci impegniamo a fare dell'educazione il luogo privilegiato dell'educazione alla fede.
4.2. La relazione educativa: come esercitare l'autorità pastorale
Molti educatori e operatori pastorali sono oggi in crisi di identità, perché sono consapevoli dei meccanismi di manipolazione che attraversano le loro funzioni. E così sono tentati di abbandonare i vecchi modelli sicuri e autoritari per rifugiarsi in modelli estremamente rinunciatari e permissivi.
O viceversa, sono tentati, dopo la delusione dei metodi del dialogo, di ritornare a metodi autoritari, magari motivati in un ritorno alla radicalità della fede.
L'animazione suggerisce un modello alternativo di relazione educativa.
Può risultare molto prezioso per riformulare le esigenze irrinunciabili del ministero pastorale dell'autorità (adulti, catechisti e educatori della fede, responsabili pastorali ...), soprattutto se queste funzioni sono state preventivamente liberate da incrostazioni culturali ormai superate.
Possiamo suggerire alcune prospettive.
4.2.1. Accoglienza incondizionata
L'autorità pastorale rende presente, concreto e sperimentabile Dio, il padre buono e accogliente, che aspetta con ansia il ritorno a casa del figlio ribelle e lo copre di baci quando se lo ritrova finalmente tra le braccia.
Per questa ragione, la prima fondamentale funzione dell'autorità consiste nella testimonianza dell'amore incondizionato di Dio Padre, che ci assicura di essere persone «accettevoli», capaci di vivere nella gioia, nonostante la triste quotidiana esperienza della fuga da casa e del tradimento.
In questa accoglienza incondizionata l'autorità pastorale esercita un ministero «religioso», che affonda cioè la sua origine nel grande evento della paternità liberatrice di Dio.
Essa ricorda, in ultima analisi, la priorità dei giudizio dì fede sul giudizio morale, la priorità del dono di Dio che fa nuove le persone sulla fragile e sempre incompleta risposta dell'uomo.
4.2.2. I valori per nome
Accettazione incondizionata non significa però rinuncia a fare proposte, a stimolare, ad offrire valori e significati.
L'accettazione incondizionata sì fa immediatamente impegno promozionale, per essere amore autentico. L'educatore «nomina i valori» per aiutare a vivere. Non lo fa per bruciare l'incenso all'idolo della legge, ma perché ci sia la vita, in pienezza.
Anche in questo egli imita la prassi di Gesù.
Gesù non infrange la legge dei sabato per il gusto adolescenziale di creare turbamento e scompiglio. E neppure lo fa per disprezzo della legge o per affermare una libertà senza legge.
Egli vuole la vita e la gioia. Superando la legge del sabato, rivela il pieno significato della legge: il sabato e la legge sono per l'uomo e non viceversa.
4.2.3. Una esistenza che si fa messaggio
L'educatore nomina i valori prima di tutto nella sua quotidiana esistenza che si fa messaggio.
Chi parla con i fatti, è costretto ad abbassare spesso il tono di voce, evitando l'autoritarismo, le false sicurezze, i proclami da crociata.
In questo modello, povero ma non rassegnato, la relazione educativa non è autoritaria, ma neppure è permissiva: essa è invece «autoritativa».
Non è un gioco di parole.
L'educatore parla e agisce in modo autorevole (e non autoritario) quando fonda la sua autorità non sul rapporto istituzionale, che gli garantisce prestigio perché egli è alle sue dipendenze, ma sulla competenza e sulla coerenza, che gli assicura una proposta di valori culturalmente significativa e testimoniata dalla sua esistenza.
In questa prospettiva, il dialogo educatore-educando è ricercato efficacemente, perché l'educatore non utilizza le differenze per la sopraffazione, ma per un confronto reciprocamente arricchente.
4.2.4. Le condizioni culturali e strutturati
L'autorevolezza dell'educatore, infine, viene giocata nell'impegno rinnovato di creare le condizioni culturali e strutturali perché sia possibile esperimentare nel piccolo del contesto di esistenza la vita nuova di cui le sue parole sono annuncio e promessa.
È una dimensione importante della relazione educativa.
Affonda le sue radici nella necessità di operare in modo rispettoso della sperimentabilità delle proposte, facendo quasi toccare con mano ciò a cui si sollecita. E si sostanzia dell'esigenza, così sottolineata nella prassi messianica, di schierarsi dalla parte della vita, fino alla croce se è necessario: le parole sono credibili solo quando i fatti, anche se poveri e sofferti, offrono la cassa di risonanza.
4.3. Educare alla fede comporta l'offerta di contenuti oggettivi?
Affrontiamo ora uno dei punti più cruciali.
Nessuno si inventa come cristiano e credente, ma accetta gioiosamente l'offerta di ragioni di vita che è Gesù Cristo e il suo messaggio.
Per questo educare alla fede significa abilitare le persone ad entrare in un progetto dai contenuti precisi e oggettivi.
Le comunità ecclesiali propongono questo progetto attraverso quei diversificati interventi in cui esse esprimono la loro costitutiva missione evangelizzatrice: la catechesi, l'ascolto della Parola di Dio, le celebrazioni liturgiche e sacramentali, i momenti di incontro, di studio, di preghiera.
Se in questi momenti di evangelizzazione dobbiamo offrire «contenuti precisi e oggettivi», si può ancora parlare di animazione o non è meglio dire che c'è un tempo per fare animazione e uno per fare catechesi, dal momento che i due interventi hanno esigenze così diverse?
L'obiezione è seria e non può esser cancellata a suon di battute. D'altra parte ci rendiamo conto che non possiamo assumere l'animazione fino ad una soglia, varcata la quale ritorna la logica propositiva e indottrinante.
La domanda che ci poniamo è quindi particolarmente impegnativa: in ordine ai contenuti oggettivi della fede è utilizzabile il metodo dell'animazione?
L'interrogativo potrebbe essere trascinato fino alla sua estensione limite, riproponendo la domanda da cui siamo partiti: si può educare alla fede «animando 0
Maturiamo la risposta (pienamente affermativa), ripensando il significato che dobbiamo dare al vocabolo «oggettività».
Come abbiamo già fatto per gli altri indicatori, chiamiamo in causa la fede e, se in essa troviamo via libera alla ipotesi, riformuliamo l'esigenza di oggettività in questa nuova logica.
Qui l'itinerario si fa un po' più lungo e complesso di quelli appena percorsi, perché, come dicevamo, dobbiamo comprendere bene cosa vuol dire «oggettività». Solo dopo averla compresa fino in fondo e avendo saputo che si tratta di una oggettività tutta particolare, possiamo progettare un modello di evangelizzazione che assume pienamente la logica dell'animazione.
DOCUMENTO/5
IL «TRIANGOLO FONDAMENTALE» DEL LINGUAGGIO UMANO
Vi sono tre piani di relazioni che si intrecciano e si rimandano recíprocamente nello studio del linguaggio umano, compreso quello religioso: il piano dei significanti, il piano dei significati, il piano della realtà.
Il piano dei significanti è costituito dagli elementi sensibili dei segni. In concreto sono significanti: il suono verbale, lo scritto, il gesto attraverso cui si comunica...
Il piano dei significati, invece, è costituito dai contenuti culturali dei segni; in altre parole: l'intera serie di conoscenze, sentimenti e tendenze all'azione evocata da un significante.
Il piano dei referente, infine, è costituito dagli oggetti e dalle situazioni e dai foro reciproci rapporti.
Ogden e Richards, per illustrare le diverse dimensioni del linguaggio, si sono serviti di questo disegno, chiamato «triangolo fondamentale».

Il significante «simboleggia» un significato. Il significato si riferisce ad un referente. li segno è: il significante + il significato. Nell'esempio utillizzato nel testo: «Dio è padre», il significante è il vocabolo grafico, il significato è dato dall'esperienza personale e collettiva di paternità, il referente è Dio.
4.3.1. In che senso «contenuti oggettivi»?
Nella prospettiva dell'Incarnazione, l'evangelizzazione va compresa come avvenimento di natura simbolica.
Le parole pronunciate non sono la realtà evangelizzata, ma manifestano simbolicamente qualcosa di ulteriore rispetto a quello che si ode, un di più presente nella parola stessa che non è immediatamente costatabile.
Come in ogni segno, il significante fa venire in mente un significato non immediatamente costatabile (e per questo in qualche modo «assente») e che a sua volta «si riferisce» a un oggetto o situazione denominato appunto referente (cf «documento/5»).
Quando diciamo «Dio è padre», nel significante «padre» evochiamo quel qualcosa, fisicamente assente nella parola «padre», t dato dalla esperienza di paterni à. Il segno «padre» (parola , esperienza di paternità: significante + significato) manifesta, rende presente simbolicamente l’oggetto reale: Dio come padre.
Segni informativi e segni evocativi
Un'analisi più approfondita del rapporto simbolico mette in evidenza un fatto, molto interessante per verificare in che senso dobbiamo parlare di «contenuti Oggettivi»?
Sono almeno due i modi in cui si può realizzare il rapporto simbolico.
Se, per esempio, cerchiamo un libro in una biblioteca, possiamo lavorare sullo schedario oppure ottenere il permesso di accedere direttamente alla sala deposito.
Se ho tra le mani la scheda del libro richiesto, non ho «quel» libro, ma un suo segno. Il rapporto tra segno e referente è però molto stretto, quasi determinato. la scheda rappresenta una informazione univoca nei confronti de1 libro. Si può quindi dire che la scheda «informa» rispetto al libro. L'informazione deve essere corretta, identica tutte le volte che ricorre nello schedario, per poter reperire esattamente quel libro.
Si tratta di un segno informativo. invece accedo al deposito, posso scatenare la mia fantasia alla ricerca del libro. So che il libro si trova in uno scaffale determinato. Cercandolo, mi imbatto n altri libri, che consulto e che scopro più interessanti del libro che cercavo. In questo caso il segno (lo scaffale, per esempio) non ha offerto informazioni univoche, ma ha sollecitato una capacità evocativa, che arricchisce e frastaglia la mia ricerca. Il rapporto tra segno e referente è aperto a esiti diversi: il segno «evoca» e non informa.
Attraverso quali segni si evangelizza?
Evangelizzando, lanciamo dei segni, che conducono quasi deterministicamente all'oggetto reale, oppure utilizziamo solo dei segni «evocativi»?
La risposta può essere data solo nell'autocomprensione teologica della Rivelazione.
Sul fatto che la Rivelazione è nell'ordine simbolico, non ci sono dubbi. Una riflessione più approfondita ci fa precisare che il rapporto simbolico è più di ordine evocativo che informativo.
Per tornare all'esempio, siamo prevalentemente nella prospettiva di chi cerca un libro direttamente sullo scaffale, giocando la sua creatività, piuttosto che nella situazione di chi ha tra le mani la scheda bibliografica con informazioni precise e dettagliate.
Se l'evangelizzazione fosse una struttura comunicativa di ordine informativo, si richiederebbe la ripetizione costante degli stessi segnali.
Se invece l'evangelizzazione è prevalentemente un segno evocativo di eventi trascendenti, bisogna elaborare una struttura comunicativa capace di attivare e servire questi processi evocativi, coinvolgendo in prima persona gli interlocutori.
In un linguaggio informativo l'oggettività è qualcosa di statico, di definibile una volta per sempre.
In un linguaggio simbolico, l'oggettività assume invece il ritmo della vita: quello che permane, che, è fondante e costitutivo, si fa vicino e concreto nella esperienza umana, sempre fragile e relativa.
I contenuti dell'esperienza cristiana sono oggettivi, anche se sono espressi nella relatività delle parole umane. Oggettivo è l'evento; relativa è la sua espressione. Lo studio attento della Rivelazione e dei processo dell'evangelizzazione, nella logica dell'Incarnazione, ci porta a preferire la seconda ipotesi, almeno in linea generale.
Oggettività e relatività nell'evangelizzazione
Oggettività e relatività sono due esigenze quasi complementari: l'oggettività si fa relativa per essere autentica, e la relatività si lascia normare da eventi oggettivi. La formula può sembrare un gioco di parole. Certamente, se ci fermiamo qui, appare anche molto rischiosa, perché manca un criterio capace di comporre armonicamente le due esigenze e di verificare la validità dei prodotto ottenuto.
Ancora una volta l'incarnazione ci suggerisce la strada da percorrere per trovare questo criterio. L'affermazione conciliare che la Chiesa è «universale sacramento di salvezza» (LG 1,48; GS 45; A G 1), è maturata fino alla consapevolezza di poter essere segno/sacramento solo facendo realmente dell'uomo in situazione la sua prima e fondamentale via (RH 14). La propria identità è diventata fedeltà radicale all'uomo-in-situazione, per poter essere veramente per lui sacramento di salvezza.
L'identità dei segno è quindi strettamente legata alla sua funzione: il segno è autentico nella misura in cui risulta soggettivamente appello: appello, cioè, per il giovane in concreto e in situazione.
L'attenzione ai destinatari concreti e la ricerca di un progetto salvifico che possa risultare comprensibile e credibile per essi (per essere veramente appello), diventano la parola decisiva per essere veramente sacramento di salvezza in situazione.
La Chiesa si fa «relativa» all'uomo, al giovane, per diventare un servizio salvifico a questo concreto uomo.
Qui sta la fedeltà costitutiva. La Chiesa è fedele al suo Signore quando è percepita dal giovane-in-situazione come sacramento di salvezza.
DOCUMENTO/6
EDUCAZIONE ALLA FEDE TRA ESPERIENZE SALVIFICHE E NARRAZIONI EFFICACI
Anzitutto fare esperienza di salvezza
Il dato fondamentale della fede cristiana è la morte e risurrezione di Cristo come evento salvifico, evento, cioè, attraverso il quale Gesù è stato costituito da Dio Messia e Signore (cf At 2,36).
Due aspetti, perciò strutturano la fede: uno passato, pervenutoci attraverso le esperienze salvifiche degli Apostoli, ed uno presente, che riguarda la nostra salvezza.
Confessare Gesù Signore implica riconoscere un fatto presente: egli salva.
Ma per asserire la salvezza che viene da Cristo è necessario verificare in sé o negli altri che, anche oggi, nel suo nome è offerta salvezza agli uomini. Che è possibile, cioè, crescere come persone umane, amare in modo oblativo, realizzare la giustizia, scoprire il senso della sofferenza e della morte.
Finché non avviene qualcosa nel presente, Gesù non può essere proclamato come Cristo e la fede in lui non è possibile. Non è sufficiente, perciò, esporre una dottrina relativa a Gesù, anche perfetta, per essere riconosciuti credenti, è necessario «mostrare la forza dello Spirito», quella che può essere vista e udita (cf At 2,33: «come voi stessi potete vedere e udire»), quella che si traduce in esperienze che non possono essere fatte invano (Gai 3,4).
Creare le condizioni per il fiorire di racconti salvifici
Annunciare perciò la fede è ripetere racconti di salvezza, narrare di un Dio «che dona lo Spirito ed opera meraviglie» (Gai 3,45). L éfficacia della proposta di fede non poggia «su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza» (cf 1 Cor 2,4). Anche le narrazioni sono momenti manifestativi dell'azione salvifica di Dio.
Educare alla fede, perciò, è creare le condizioni nelle quali possano fiorire racconti salvifici.
Ci sono momenti nei quali non è possibile fare altro che raccontare la storia delle meraviglie di Dio. Ma la narrazione deve essere tale da suscitare la fede ed alimentare la speranza, cioè da cambiare la vita.
Modelli culturali armonici in cui dire Dio e la vita
Ma anche le narrazioni e le spiegazioni che le accompagnano possono essere inefficaci.
Ciò avviene quando il presente vitale non è espresso e il narratore non è coinvolto nel racconto. Quando non c'è comunicazione di energia, quando chi racconta non è «testimone x Oppure quando la testimonianza è offerta con modelli culturali che confondono il messaggio e lo rendono inaccettabile.
Queste due condizioni debbono ritrovarsi senza eccezione nei processi di educazione della fede se si desidera ottenere effetti duraturi. L'impegno perciò di una comunità ecclesiale che voglia garantire la sua continuità dovrebbe essere quello di creare spazi di esperienza salvifica, moltiplicare cioè le occasioni di scambi di energia vitale, e nello stesso tempo quello di offrire modelli culturali accettabili da suscitare racconti efficaci.
(Carlo Molari)
4.3.2. Un evangelo come racconto di una storia a tre storie
Possiamo finalmente ricucire la trama delle nostre riflessioni, suggerendo un modello di evangelizzazione dai contenuti oggettivi in pieno stile di animazione. Questo modello serve per dire come andrebbe fatta la catechesi, come andrebbe letta la Parola di Dio, come andrebbe comunicata la fede in Gesù Cristo, come si dovrebbe proporre un nuovo stile di vita...
Ci si chiedeva quale poteva essere il linguaggio per comunicare i contenuti «oggettivi» della fede. Troppo spesso si è ricorso a linguaggi informativi e argomentativi. Oggi ci si rende conto che si evangelizza attraverso linguaggi evocativi che trovano la loro espressione nella «narrazione» e nel contesto esperienziale in cui questa accade.
Anche in questo contesto dovremmo fare un lungo discorso per precisare qual è il modello di evangelizzazione in stile di narrazione.
Non lo facciamo, e rimandiamo alla bibliografia.
Suggeriamo solo i quattro movimenti fondamentali sui quali si costruisce il modello. È facile notare come le caratteristiche educative dell'animazione (obiettivo, asimmetria, coinvolgimento, proposte e esperienze...) lo segnino profondamente.
Ecco, in concreto, un modo di rispettare contemporaneamente i «contenuti oggettivi» (come li abbiamo ricompresi) e lo stile dell'animazione.
^ In primo luogo, l'evangelizzazione esige la comunicazione pratica della esperienza che esprime. Così il narratore e gli ascoltatori sono coinvolti nell'esperienza che narra. Ciò che il narratore racconta lo ricava dall'esperienza che narra. E lo rende di nuovo esperienza per coloro che ascoltano la sua storia. Questa prima sottolineatura è molto importante (cf «documento/6»).
Chi racconta sa di essere competente a narrare solo perché è già stato salvato dalla storia che narra; e questo perché ha ascoltato questa stessa storia da altri. La sua parola è quindi una testimonianza: la storia che narra non riguarda solo eventi o personaggi dei passato, ma anche il narratore. Essa è in qualche modo la sua storia. Egli narra la sua esperienza di uomo salvato, per coinvolgere altri in questa stessa esperienza.
Il racconto evangelizzatore è sempre un'offerta vitale, che vuole suscitare nuove risonanze vitali.
^ In secondo luogo, come conseguenza logica, il racconto si caratterizza per l'intenzione autoimplicativa e non solo dimostrativa. La sua struttura linguistica non è finalizzata a dare delle informazioni, ma a sollecitare ad una decisione di vita. Sono storie che spingono alla sequela.
^ In terzo luogo, il racconto deve possedere in qualche misura la capacità di produrre ciò che significa, per essere segno salvifico. Non si tratta di ricavare dalla memoria di un calcolatore una serie di informazioni fredde o impersonali, ma di liberare la forza critica racchiusa nel racconto.
Il racconto si snoda con un coinvolgimento interpersonale così intenso da vivere nell'oggi quello di cui si fa memoria. Così la storia diventa racconto di speranza. In questo il racconto trova la sua autoverifica: esso infatti non viene giustificato o falsificato da ragioni esterne, ma dalla capacità intrinseca al racconto di produrre efficacemente ciò che narra. a La quarta annotazione riprende e sintetizza quelle precedenti: il racconto è nello stesso tempo memoria e fede: ripresa di un evento della storia e espressione della fede appassionata dei narratore.
Nel racconto si intrecciano molte storie: quella narrata, quella del narratore e quella degli ascoltatori.
Ripetere un racconto non significa riprodurre un evento sempre con le stesse parole, ma riesprimere la storia raccontata dentro la propria esperienza e la propria fede.
Questo coinvolgimento assicura la funzione performativa, cioè la capacità di modificazione della prassi umana, dell'evangelizzazione. Se essa volesse prima di tutto dare informazioni corrette, si richiederebbe la ripetizione delle stesse parole e la riproduzione dei medesimi particolari. Se, invece, il racconto ci chiede una decisione di vita, è più importante suscitare una forte esperienza evocativa e collegare il racconto alla concreta esistenza. Parole e particolari possono variare quando è assicurata la radicale fedeltà all'evento narrato, in cui sta la ragione decisiva della forza salvifica della evangelizzazione.
4.3.3. Un progetto da realizzare «assieme»
Abbiamo cercato di comprendere cosa significhi rispettare l'oggettività nei contenuti del messaggio cristiano. E ci siamo ritrovati in pieno nella scommessa sull'uomo.
Anche nella fede e nel suo annuncio l'uomo è al centro.
Compresa in questa prospettiva l'evangelizzazione diventa un progetto da realizzare assieme, nella comunione e nel confronto.
Tutti hanno qualcosa da proporre in questa ricerca, perché tutti sono già stati afferrati da Gesù il Signore. La nostra comune ricerca è la tensione, non ancora risolta, a conquistare la sua risposta. Siamo ancora in ricerca, tutti, perché afferrati, almeno implicitamente dalla sua risposta, cerchiamo ogni giorno con una attesa più radicale.
Collocare la persona al centro non significa né rinunciare alla dimensione veritativa dei linguaggio di fede, né tanto meno rifiutare la funzione dei magistero in ordine alla elaborazione e al controllo dì questo linguaggio.
Nell'ordine della fede e della salvezza, la solidarietà dei singolo con gli altri è così profonda che il suo personale essere salvo non può venir separato dal suo essere nella comunità.
La centralità della persona nella vita di fede comporta perciò la progressiva capacità (e il relativo processo di educazione) di lasciarsi misurare e giudicare da altre soggettività, riconoscendo la funzione autorevole dei testimoni della fede e della Parola, nel grembo materno di una comunità che dà vita alla nostra fede. La fede della comunità sostiene e custodisce la nostra debole fede, la vivifica e la rigenera.
4.4. Chi vive di vede è un solitario che siede a mensa con tutti
Facciamo un ultimo esempio.
Questa volta pensiamo a lunga distanza: all'obiettivo di una pastorale giovanile ispirata all'animazione.
Sappiamo che l'obiettivo è l'ultima cosa che si realizza in ogni impresa; ma è la prima che si ama o si sogna.
Quando ci si chiede «qual è l'obiettivo della pastorale giovanile», la risposta è pronta e facile: fare dei cristiani.
Se poi si rilancia la domanda «cosa vuoi dire essere cristiani?», le cose si complicano un poco, perché ci sono tanti modi di essere cristiano. Per convincersi, basta guardarsi d'attorno.
Se vogliamo qualificare la pastorale in stile di animazione, è urgente cercare di ritagliare con coraggio una immagine «nuova» di giovane cristiano, utilizzando fino in fondo quelle scommesse antropologiche che caratterizzano l'uomo dell'animazione (cf Q5 e Q6).
Il cristiano è un uomo felice di vivere, perché riconosce che la sua vita è riempita dall'amore accogliente e provocante dei suo Signore.
Questa esperienza è così sconvolgente da farlo diventare un solitario che siede a mensa con tutti.
Questo è l'obiettivo. Su questo obiettivo vanno misurati in concreto tutti i progetti. Studiamolo con calma e attenzione.
4.4.1. Vivere di fede: leggere dentro le cose con «fantasia»
Una esistenza cristiana costruita sulla logica della sacramentalità richiede una profonda esperienza di fede.
Si tratta infatti di «leggere dentro» le cose, gli avvenimenti, le persone, per cogliere in trasparenza quel mistero che esse si portano dentro.
Visibile e mistero non sono due realtà separabili, quasi esistesse l'uno a prescindere dall'altro o sì potessero analizzare in approcci totalmente separati. Visibile e mistero sono le due dimensioni dello stesso oggetto.
Oggetto della fede, speranza e carità è perciò l'esistenza concreta e quotidiana, la storia profana. Esse non hanno un loro oggetto proprio, che le escluda dalla mischia concreta della vita. Fede, speranza, carità sono gli atteggiamenti radicali con cui ogni persona interpreta e esprime l'insieme delle azioni e reazioni, delle circostanze e condizioni, che entrano nell'esperienza del soggetto e contribuiscono direttamente a determinare la modalità d'iniziativa.
Due letture della realtà
Lo stesso oggetto (la vita quotidiana) va però compreso a livelli di intensità diversificati. Lo stesso sguardo si fa più raffinato e più penetrante, mentre mette a fuoco dimensioni diverse della stessa realtà.
Dal momento che il mistero è incontrabile solo nel suo visibile, per vivere di fede si richiede prima di tutto una lettura umanamente corretta dell'oggetto della fede, speranza e carità: una lettura elaborata secondo le logiche autonome dell'approccio tecnico, nei differenti livelli in cui esso si svolge (prescientifici e scientifici). li mistero è però la verità dei visibile. Questa prima lettura va perciò integrata con una seconda, più profonda, che collochi la realtà sul piano dell'assoluto, dove la continua tensione della vita contro la morte emerge in ogni germe di umanità. Questo sguardo attinge al mistero, trasfigura la realtà fino a darci l'esperienza di vivere in un mondo nuovo.
Come in filigrana, sì staglia il volto dei Dio di Gesù Cristo, la sua proposta di vita, il suo amore accogliente e interpellante, l'offerta di se stesso come il senso determinante di ogni esistenza.
Lo specifico della seconda lettura
Il rapporto tra visibile e mistero è sempre imprevedibile, sperimentato e sofferto nello stesso tempo. Ci si sente più impegnati in una scommessa esistenziale, che depositari di informazioni sicure e immutabili.
La seconda lettura possiede perciò strumentazioni proprie, riconducibili alla Parola di Dio, e si esprime in un linguaggio che supera le logiche della sapienza umana, tipiche della prima lettura, per assumere la profezia dell'evangelo. Il linguaggio della seconda lettura è fatto di fantasia, di creatività, di rischio calcolato e accettato.
Solo questo linguaggio rispetta l'imprevedibilità dei mistero.
Il linguaggio troppo elaborato è del primo livello; quando viene trascinato anche nel secondo livello, diventa un linguaggio ateo, perché riduce il mistero alle logiche scientifiche del visibile.
4.4.2. La solitudine del credente
Abbiamo insistito sullo stretto rapporto esistente, nella vita di fede, tra prima e seconda lettura; e abbiamo ricordato la diversità di strumentazioni e di linguaggi. Questo fatto porta ad una importante considerazione: la vita di fede è una vita giocata in piena soggettività.
^ La persona è al centro, nella sua responsabilità e libertà, nella sua fantasia. Essa vive di fede; essa dice la sua fede. L'atto di fede è sempre un evento della responsabilità personale. Nessuno può demandare ad altri una decisione così importante,
Una volta questa decisione era maturata in un ambiente che la sosteneva e la applaudiva. Spesso restava l'impressione che nell'ambito della fede uno venisse sgravato dal peso non delegabile della responsabilità.
Oggi le cose sono profondamente cambiate.
L'atto di fede, quando è riempito operativamente dei progetto di esistenza che è Gesù e il suo messaggio, si scontra con le logiche correnti, le travolge, fino a giocare sulla croce la piena riuscita in umanità.
^Il credente, in forza della sua fede, vuole sedere a tavola con tutti gli uomini, nel nome della comune solidarietà umana. Ma resta un solitario, perché proprio la sua fede lo costringe al coraggio della decisione solitaria contro la pubblica opinione; un coraggio solitario analogo a quello dei martiri dei primi secoli dell'era cristiana; il coraggio della decisione di fede che trova la propria forza in se stessa e non ha bisogno di essere sostenuta dal pubblico consenso.
Vivere dì fede è quindi evento di libertà, un gesto che irrompe nel centro più intimo dell'esistenza. Spesso non siamo in grado di oggettivare in modo adeguato questa esperienza. Ma essa resta, come una decisione ultima di coscienza non più applaudita da alcuno, in una speranza illimitata che supera le delusioni della vita e l'impotenza di fronte alla morte.
4.5. I punti di riferimento di ogni progetto
Dovremmo continuare a fare esempi, riprendendo e riformulando tutte le dimensioni dell'azione pastorale.
Come dicevo, non lo possiamo fare per evidenti ragioni.
Gli esempi riprodotti sono sufficienti a scatenare la fantasia di coloro che vogliono provare a percorrere la strada dell'animazione nella pastorale.
Per aiutare la riflessione e il confronto, una cosa ancora possiamo suggerire: un elenco di esigenze che investono l'educazione alla fede, quando si prende sul serio l'animazione. Sono come i punti di riferimento obbligatori per non uscire di strada quando si è costretti a procedere con creatività e responsabilità.
Servono anche da parametri di verifica per valutare fino a che punto la logica dell'animazione ha influenzato il progetto pastorale.
Evangelizzare «secondo» l'animazione
Prima di tutto, se l'animazione è stile globale, non possiamo assumerla come se fosse solo qualcosa da aggiungere alle altre funzioni. Essa al contrario esprime la modalità complessiva e globale di risolvere tutte le funzioni della evangelizzazione. Così, per esempio, il catechista non fa il catechista e l'animatore, come se la catechesi riguardasse i contenuti e l'animazione solo la relazione. Si è catechisti secondo lo stile dell'animazione: catechisti da animatori (come si può essere catechisti secondo un modello dì educazione integratrice o secondo uno stile permissivo ...).
Contenuti e relazione sono ripensati globalmente in modo da rispettare le esigenze della comunicazione evangelizzatrice e della comunicazione educativa. Il paragrafo sui «contenuti oggettivi» (molto importante, anche se forse un po' difficile) ha offerto un modello di come «fare il catechista da animatore».
Evangelizzare «in gruppo»
Un altro elemento è dato dal gruppo. L'animazione fa del gruppo il suo strumento privilegiato di intervento. Chi crede all'animazione, crede ciecamente al gruppo, lo costruisce, lo desidera, lo potenzia. Senza gruppo non riesce a far niente.
L'educazione alla fede in stile di animazione ha bisogno dei gruppo, come l'aria che respiriamo,
Per questo, da una parte, quando non c'è, si incomincia a costruire gruppo («animando» verso il gruppo le istituzioni fredde e massificanti e le grandi aggregazioni impersonali) e dall'altra si inserisce nel «grembo materno» dei gruppo anche i momenti in cui è necessario assumere i rapporti a «tu per tu».
Evangelizzare rifiutando modelli educativi acritici o autoritari
Se l'animazione vuole aiutare a crescere persone libere, responsabili e critiche, fare educazione alla fede nello stile dell'animazione comporta il rifiuto di tutti i modelli in cui c'è poco spazio per la criticità, la revisione razionale dei simboli usati, l'autoritarismo e cose simili.
Purtroppo anche nell'educazione alla fede qualcuno vorrebbe introdurre schemi del genere, giustificando la sua operazione con grosse motivazioni e con parole mozzafiato. L'animazione non va d'accordo con questi modi di fare. E li rifiuta decisamente.
Evangelizzare nel rispetto della logica educativa
L'animazione non è rinunciataria: fa proposte, ma in un certo modo (come abbiamo studiato negli altri quaderni).
L'innegabile dimensione propositiva che caratterizza l'evangelizzazione va realizzata nel rispetto pieno della logica educativa: partendo sempre dalle domande dei giovani, interpretate e approfondite verso la loro autenticità; con progressiva gradualità; mediante processi di animazione e non sulla forza dell'imposizione; aiutando i giovani a conservarsi maturi e critici anche nell'entusiasmo religioso; «facendo fare esperienze».
Evangelizzare «facendo fare esperienze»
Il fare esperienze è una esigenza seria, da prendere molto sul serio. Significa in una parola che è indispensabile far toccare dal vivo i messaggi, anche quelli più grandi e affascinanti. 1 messaggi (educativi e evangelizzatori, quelli che si riferiscono alla personale crescita in umanità e quelli che sollecitano a vivere da uomini nuovi in Gesù Cristo) sono prima di tutto delle esperienze che si fanno messaggio.
Su questa prospettiva si comprende l'importantissima scelta del gruppo di cui abbiamo appena parlato.
Il gruppo è infatti una «esperienza», uno spazio intessuto di esperienze. I messaggi passano di lì; si ricostruiscono «nel» gruppo; diventano vicini, concreti, interpellanti e affascinanti quando sono l'aria che si respira in gruppo.
Il gruppo è una esperienza che si fa messaggio.
Evangelizzare per aiutare ad essere felici
La passione educativa coinvolge anche il modo di comprendere l'obiettivo dell'educazione alla fede. Evangelizziamo il Dio di Gesù Cristo per aiutare ad essere pienamente felici, intensamente e autenticamente viventi,
Lo annunciamo con coraggio e con fermezza, perché siamo consapevoli che solo immersi nell'amore accogliente e liberante di Dio possiamo essere felici e viventi.
Educhiamo alla fede per aiutare a vivere: questo è in una parola l'obiettivo del nostro servizio pastorale e questa è la ragione della insistenza con cui lo vogliamo realizzare.
5. LA CONCLUSIONE: ANIMAZIONE E PERSONAL COMPUTER
Siamo finalmente arrivati a fine corsa. Qui, al capolinea di questa ricerca, si concludono le mie riflessioni e incomincia la faticosa e affascinante avventura dell'azione sul campo.
Possiamo fare il punto, riassumendo quello che ho diffuso lungo le pagine dei quaderno e proiettandomi un poco in avanti verso il concreto della prassi.
Qualche lettore troverà inutile questa sintesi: se l'è già costruita lui, commentando in fogli a parte quello che leggeva. Per qualche altro, invece, può essere come il dono (purtroppo tardivo) della pianta di una città sconosciuta: se l'avesse avuta tra le mani all'inizio non si sarebbe smarrito nell'intricato labirinto concettuale di questo quaderno.
Preciso con un esempio quello che vorrei comunicare.
Ho sempre sognato di possedere un «personal computer». Finalmente qualcuno me lo ha regalato (sono ancora nel sogno!).
Sono di formazione classica, con una mentalità molto lontana dalla logica di questa macchina raffinatissima.
Dopo il primo imbarazzo, incomincio ad utilizzarla. La scopro interessante, preziosa, quasi indispensabile. Mi risolve un mucchio di problemi, accelerando i tempi di lavoro e qualificando la resa.
Concludo: è proprio quello che ci voleva. Peccato non averla scoperta prima. Però costato progressivamente che la posso usare solo se cambio testa: se smetto di ragionare con la mia logica ed entro nel linguaggio nuovo del calcolatore.
Quando mi hanno regalato questa macchina, si sono verificate due cose: ho uno strumento prezioso e sono stato costretto a modificare il mio sistema di pensiero, per poterlo utilizzare. Senza questa modifica, lo utilizzerei così parzialmente da vanificarlo. La stessa cosa avviene quando si introduce l'animazione nei processi dell'educazione alla fede.
In un primo tempo, superate le iniziali resistenze, ci si accorge di possedere uno strumento privilegiato per risolvere quella funzione educativa che caratterizza anche l'educazione alla fede. Viene quasi da dire: finalmente quello che cercavamo, Attraverso l'animazione facciamo bene il nostro compito di educatori della fede. Immediatamente ci accorgiamo però di poter usare bene questo strumento (l'animazione) solo se «cambiamo logica»: se ripensiamo a fondo il modo di fare pastorale per fare una pastorale in stile di animazione. L'animazione infatti non è solo uno strumento, ma è un modello globale di relazione educativa e comunicativa.
L'animazione è, insomma, come il personal computer, uno strumento che posso usare pienamente solo se entro nella sua logica. Le lunghe pagine di questo quaderno sono state tutte spese per motivare che è corretto usare questo strumento (cf paragrafo 3) e che è egualmente corretto «cambiare logica» nella pastorale per usarlo bene (cf. paragrafo 4). Per essere ancora più concreto posso anche elencare alcune delle esigenze che investono l'educazione alla fede, quando si prende sul serio l'animazione. Per stare ancora nell'esempio: la logica nuova da assumere per entrare nel linguaggio del calcolatore che voglio usare pienamente.
BIBLIOGRAFIA
Alberich E., Catechesi e prassi ecclesiale, LDC, Leumann 1982.
Metz J.B., Al di là della religione borghese. Discorsi sul futuro del cristianesimo, Queriniana, Brescia 1981.
Piveteau D., Aprire i giovani alla fede, LDC, Leumann 1979.
Rahner K., Teologia dall'esperienza dello Spirito, Paoline, Roma 197
Id., Dio e Rivelazione, Paoline, Roma 1981.
Id., Sollecitudine per la Chiesa, Paolìne, Roma 1982.
Rahner K. - Weger K.H., Problemi di fede della nuova generazione. Queriniana, Brescia 1982.
Schillebeeckx E., La questione cristologica: un bilancio, Queriniana, Brescia 1980.
Tonelli R., Pastorale giovanile. Dire la fede in Gesù Cristo nella vita quotidiana, LAS, Roma 1982.
Wacker B., Teologia narrativa, Queriniana, Brescia 1981.
IL CANOVACCIO
Per una scuola di giovani animatori
Franco Floris - Domenico Sigalini
Gli obiettivi del quaderno sono riconducibili essenzialmente a tre:
- chiarire «se» e «come» la pedagogia elaborata dalle scienze umane ha a che fare con la educazione alla fede, oppure se sono due edifici diversi e separati;
- ripensare l'educazione dei giovani alla fede alla luce degli orientamenti di quel modello educativo originale che è l'animazione culturale;
- quali conclusioni operative ricavare per il proprio ambiente pastorale.
COSA C'ENTRA L'ANIMAZIONE CON L'EDUCAZIONE ALLA FEDE?
Veniamo al primo obiettivo. Raggiungere questo obiettivo comporta un cammino nel quale possono essere individuate le seguenti «tappe».
Quattro tappe verso l'obiettivo
1. La prima tappa è rendere consapevoli del problema e delle sue implicanze.
Come farlo emergere, in modo da motivare la ricerca stessa nei presenti? Può essere utile partire dal concreto ripensando i quattro «modelli negativi» che si riscontrano nella pratica offerti dall'autore (cf pag.).
Una volta individuati i modelli, applicandoli concretamente all'attività dei gruppo, centro giovanile, scuola._ si può riproporre il problema. Dovrebbero emergere due interrogativi:
- l'educazione umana del giovane è solo una fase preparatoria all'educazione cristiana?
- nell'educazione alla fede si possono utilizzare le «scienze dell'educazione, oppure si deve ricorrere ad altre fonti di orientamenti educativi?
2. La seconda tappa è, senza dare per scontata alcuna risposta, portare l'attenzione sul fatto che al problema, anche a livello teorico, esistono almeno tre soluzioni:
- la prospettiva incarnazionistica e la sua ottica «sacramentale»;
- la prospettiva dialettica e la sua ottica di «distinzione»;
- la prospettiva tradizionale e la sua ottica di «dipendenza».
Dove allora rintracciare qualcosa che permetta di orientarsi?
3. Siamo così al momento cruciale, fondamentale, della terza tappa: una meditazione sull'evento dell'Incarnazione.
- Da questa meditazione emerge anzitutto che ciò che è autenticamente umano è di fatto «sacramento» di incontro con Dio (quindi anche ogni impegno di animazione).
- Ma dalla «meditazione» emerge, in particolare, che l'educazione alla fede coinvolge un vero processo educativo, nel senso che l'educazione alla fede deve utilizzare le indicazioni della ricerca umana in campo educativo.
4. La quarta tappa si pone la domanda: l'animazione, in quanto originale stile/modello educativo, ha i requisiti sufficienti e necessari per essere «utilizzata» nell'educazione alla fede?
Se sì, «come» stabilire un dialogo tra evangelizzazione e animazione? Siamo alle soglie del secondo obiettivo.
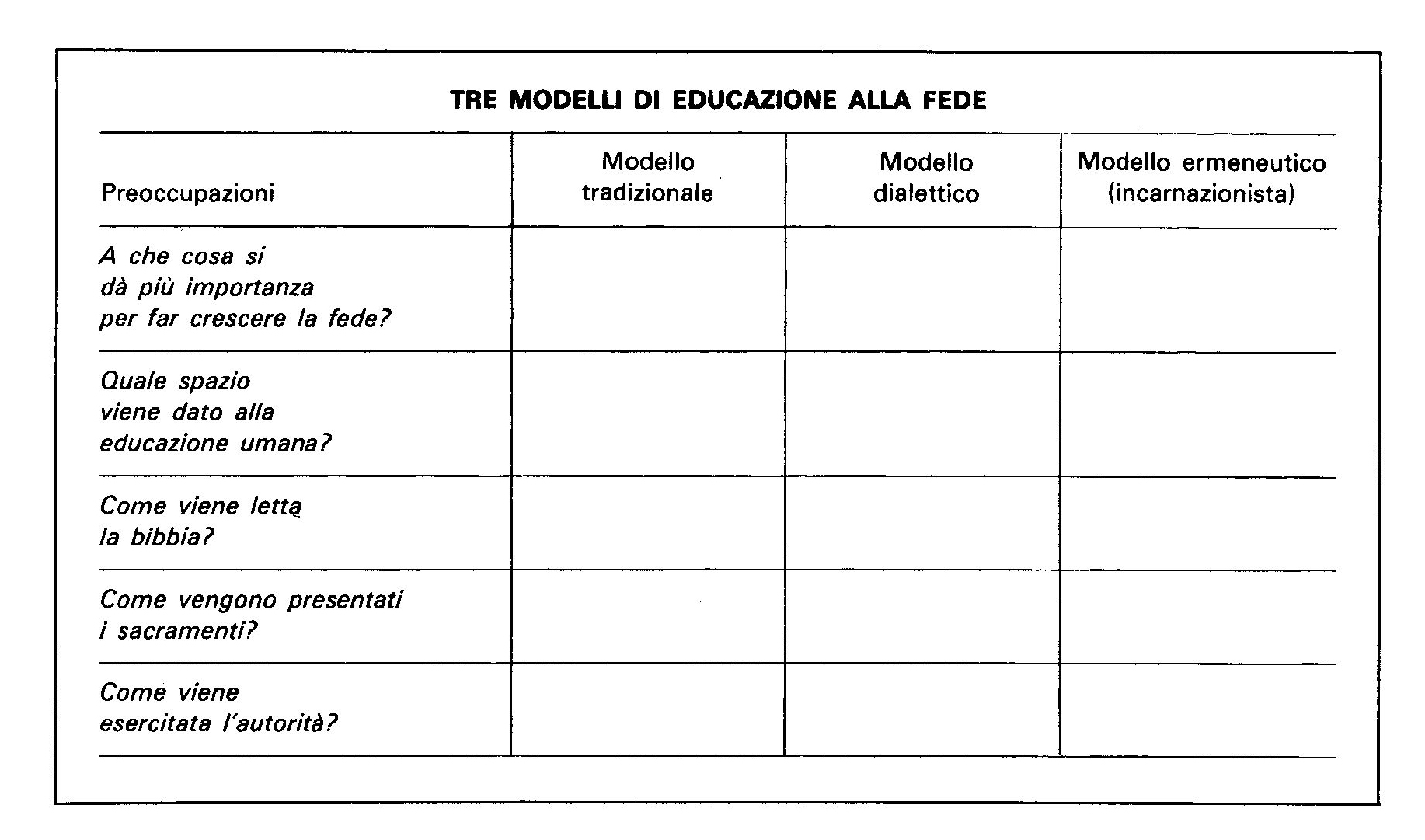
Strumenti
Esistenza del problema
Evidenziare lo stato d'animo di un animatore che si è imbarcato nel discorso dell'animazione e che, a questo punto, trova l'impatto coi problema della educazione alla fede.
Esaminare il seguente elenco di affermazioni o di problemi per vedere quale può essere la soluzione.
Bella l'impostazione dell'animazione culturale... ma io adesso devo entrare in classe e fare catechismo!
Quando io mi spendo per far essere un giovane, liberarlo, renderlo protagonista, non sempre emerge un bisogno di Dio. E' ancora animazione proporgli i «contenuti» della fede o è un tradimento dell'animazione?
L'animazione «centra» sulla persona, la fede «centra» su Cristo. Bisogna che qualcuno venga «scentrato»!
Animazione è tenere assieme con gioia gli adolescenti; pregare e credere è un'altra cosa!
Educazione, inculturazione, socializzazione stanno bene insieme senza la fede. Se animare è porsi a quel «crocevia» (cf Q5), che cosa c'entra la fede?
A queste frasi se ne possono aggiungere altre, che spesso sono nate da discussione su questi temi.
Se sono molte si fa un ciclostilato che viene messo a disposizione. Quindi si accostano queste frasi alle soluzioni negative presentate a pag. (modello funzionalista, dualista, soprannaturalista, riduzionista ...) per concludere con un elenco di esigenze che ciascuno sente irrinunciabili sia per la fede, sia per l'animazione.
Diverse soluzioni al problema
- Scrivere su un cartellone, in maniera disordinata, le seguenti parole: sport, preghiera, animatore, catechista, attività, amicizia, esperienza forte, impegno sociale (e altre che indicano ciò che si fa in gruppo). Di ciascuna dire a che «serve» e come viene utilizzata dentro le quattro «soluzioni negative» ora accennate (dualista, soprannaturalista, riduzionista, funzionalista). La discussione può essere orientata dal «mandato»: «A che cosa serve... (la preghiera) nel modello... (funzionalista)?».
- Confrontare quanto emerso con la prospettiva incarnazionista dell'articolo (cf pagg. ). Per affrontare con profitto la «finestra» sull'evangelizzazione (cf pag.), fare un esercizio di associazioni libere su «evangelizzazione». Scrivere le associazioni emerse e applicarvi il gioco della affermazionenegazione (cf Ql, pag. 3 1). Infine leggere e discutere sul contenuto di EN 2023.
- Un altro esercizio, dopo il precedente approfondimento teorico, ci riporta alla vita concreta per vedervi già utilizzato, anche senza accorgersi, un preciso modello educativo.
Descrivere sommariamente la vita di qualche gruppo di cui si è fatto parte o di qualche gruppo di associazione o movimento (ad es.: AC, AGESCI, Gioventù Aclista, CL, Gruppi Neocatecumenali ...) per tentare di cogliere la concezione di educazione, di persona, di fede, di esperienza che li orienta.
Domande utili potrebbero essere: quale rapporto con la realtà? quali momenti educativi fondamentali e con quale scopo?
- come, e a che punto, viene interrogata la vita delle persone?
- quale rapporto tra cultura e fede?
- che «tipo» di uomo viene esaltato?
Il lavoro può essere svolto in maniera induttiva dopo una drammatizzazione in cui si rappresenta qualche caratteristica di questi gruppi, o in una discussione o in una attività.
(Fare attenzione a non mettere in ridicolo chi non la pensa come noi, ma semplicemente far risaltare le differenze o le convergenze. La valutazione dei modello può essere fatta solo quando lo si conosce a fondo).
Le tre prospettive di fondo
A questo punto si deve essere in grado di orientarsi tra «modelli» diversi di educazione alla fede.
Si può utilizzare lo schema riportato in questa pagina.
L'EDUCAZIONE ALLA FEDE A PARTIRE DALL'ANIMAZIONE
Veniamo al secondo obiettivo: «Ripensare l'educazione alla fede a partire dalle indicazioni dell'animazione culturale».
Fasi e tappe
Il raggiungimento di questo obiettivo include due fasi distinte:
- prima fase: come, attraverso cioè quale procedura, far dialogare evangelizzazione ed animazione?
- seconda fase: una volta stabilito il «come» dei dialogo, concretamente in quali «campi/ambiti» si deve oggi sviluppare il dialogo?
1. Cominciamo dalla prima fase dedicata al «metodo ermeneutico», o, se si vuole, al cosiddetto circolo ermeneutico.
Si possono indicare alcune tappe metodologiche.
- Prima tappa: partendo da esempi concreti, evidenziare come quel che si fa nella pastorale giovanile implica un certo modo di pensare l'uomo e la sua educazione che da qualcuno viene fatto derivare indebitamente dalla fede (dal Vangelo o dalla tradizione cristiana).
- Seconda tappa: sottolineare come l'ermeneutica propone un procedimento attraverso il quale «separare» dentro l'azione pastorale ciò che è «indisponibile della fede» (= qualcosa da accogliere come «dato», sul quale non si possono fare adattamenti a piacere) da ciò che è «transitorio e riformabile».
- Terza tappa: seguendo le indicazioni dell'ermeneutica «incarnare» alcuni assunti della animazione in una proposta di educazione alla fede, sottolineando insieme le «attenzioni» che l'educazione alla fede comporta.
Tutto questo processo può essere riassunto in un disegno simile a quello riportato in questa pagina.
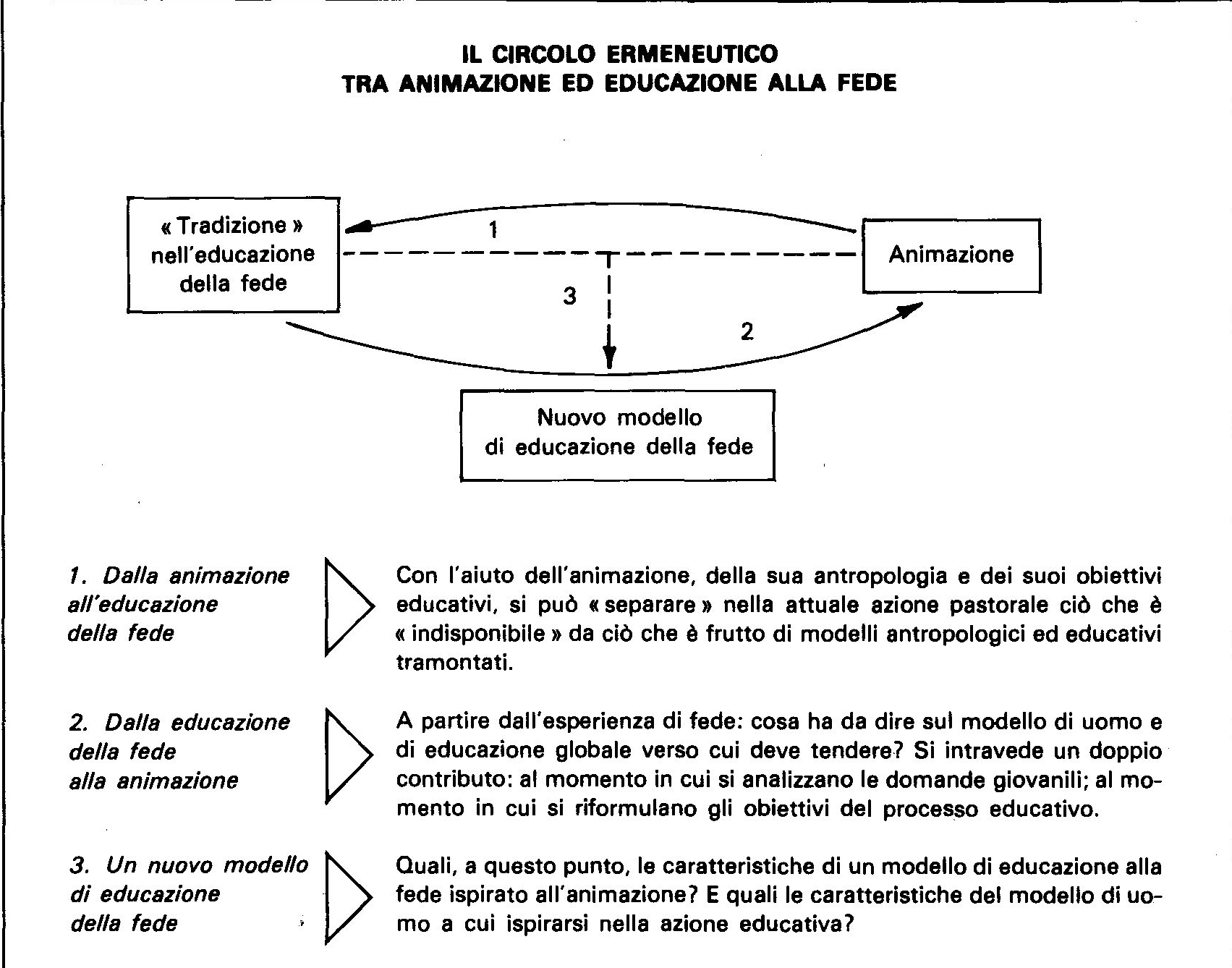
2. Veniamo alla seconda fase.
Essa consiste essenzialmente in alcune esemplificazioni su cui lavorare seguendo le indicazioni dei «metodo circolare».
Le vediamo in ordine, seguendo l'indice dei quaderno.
- Il primo e fondamentale «scambio» tra animazione ed educazione alla fede avviene a livello dell'orizzonte entro cui muoversi: la scommessa sull'uomo (cf pag. 16). Può l'evangelizzazione assumere questa istanza suprema dell'animazione e comprendere se stessa dentro tale istanza? E cosa comporta tale assunzione per l'educazione dei giovani alla fede?
- Il secondo scambio riguarda il modo di concepire la «relazione educativo/pastorale» dentro la evangelizzazione dei giovani. Come esercitare l'«autorità» nell'educazione alla fede? (cf pag. 19).
- Il terzo scambio è a proposito dei «contenuti» (cf pag. 20).
^ L'animazione culturale insiste sul fatto che mentre da una parte i giovani devono fare propria la cultura del loro ambiente, dall'altra sono chiamati a «inventare nuove rappresentazioni».
È possibile applicare questo procedimento alla pastorale giovanile? I contenuti che la fede propone non sono forse dati una volta per sempre e quindi solo da assimilare?
Come si può parlare di «nuove rappresentazioni» della fede?
^ L'animazione culturale distingue tra il linguaggio dei segni e il linguaggio dei simboli (cf Q5 e Q6).
Qual è, a questo punto, il linguaggio attraverso cui comunicare la fede: il linguaggio informativo/oggettivo dei segni scientifici? o il linguaggio evocativo/narrativo dei simboli? oppure entrambi?
- Il quarto esempio/scambio è a livello dell'identikit o del modello di cristiano a cui deve tendere una evangelizzazione ispirata all'animazione (cf pag. 24). Siamo dunque al livello della riformulazione generale dell'obiettivo dell'educazione alla fede.
Strumenti
- Riprendere quanto scritto nella «finestra» sull'ermeneutica (pp. 1617) evidenziando la novità della sequenza circolare sulle sequenze deduttive o riduttive.
Si può arrivare a questo scopo con un disegno di gruppo dal titolo: «vita e fede», in cui ciascuno con un simbolo esprime la sua sintesi tra fede e vita. Quindi si discute e si verifica la maggiore o minore circolarità.
- Lo stesso può essere ottenuto con un fotolinguaggio. Si sceglie la fotografia che rappresenta di più il rapporto fedevita come lo «trasmetto» nel mio gruppo. La si fa leggere agli altri e dopo si discute.
Vedere brevemente come nella storia umana e nella storia della comunità cristiana è stato indispensabile un mutuo «interrogarsi» di dato di fede e vita concreta. Indichiamo alcuni «temi».
La sessualità
Come si è passati dalla concezione quasi esclusiva della procreazione a quella della mutua relazione di dono e di crescita?
È stato un calare oggettivo dei dati di fede nella esperienza? un venir meno dei cristiano ai suoi principi? oppure né l'uno né l'altro, ma un «circolo ermeneutico
La concezione di Chiesa
Come si è passati dalla Chiesa-società alla Chiesapopolo di Dio?
È stata una infedeltà allo Spirito e alla Parola di Dio per seguire la moda democratica? Che ruolo hanno avuto i discorsi dei “segni dei tempi” Come si è coniugata fedeltà a Dio e fedeltà all'uomo?
Altri esempi, che possono essere discussi per capire meglio il problema, sono il rapporto fedepolitica, la figura del prete o le «immagini» di Gesù Cristo lungo ì secoli... o altre realtà che mettono in evidenza la appassionata crescita dei cristiano nella fedeltà a Dio e all'uomo, pur con oscillazioni talora devianti.
- Approfondire a gruppi le riflessioni sulle «scommesse» nell'articolo di R. Tonelli e affrontare in una tavola rotonda il problema dei «contenuti oggettivi» (cf pag. 20ss).
Riprendere lo schema dell'articolo di M. Pollo (cf QS; pagg. 45 e confrontare il paragrafo 4 (pagg. 2027) con le «scommesse» di questo quaderno.
RIPENSARE CONCRETAMENTE LA PASTORALE GIOVANILE
Veniamo al terzo obiettivo: come ripensare la pastorale giovanile, nel proprio ambiente educativo tenendo conto delle stimolazioni del quaderno, in particolare delle «aree di riflessione» studiate nel secondo obiettivo?
Indichiamo due fasi di lavoro:
- la scelta preferenziale di una delle tre prospettive di evangelizzazione (incarnazionista, dialettica, tradizionale) per evitare l'eclettismo di chi usa «materiali» provenienti dalle tre prospettive, mutandoli in modo tale che si crea solo confusione;
- l'approfondimento della prospettiva incarnazionista, ripensata in modo «circolare» con l'animazione culturale, come «modello educativo» entro cui «ridire la fede con i giovani della vita quotidiana».
Strumenti
- A questo punto lo studio dev'essere applicato alla propria situazione. Animare educando alla fede esige di costruire un modello di pastorale giovanile.
Le domande riportate nella «finestra» a pag. 31 possono aiutare a definire quale modello di pastorale seguiamo e quali correzioni di tiro è opportuno fare.
- Se questo lavoro è troppo arduo, dopo aver letto l'ultima parte dell'articolo di R. Tonelli (cf paragrafo 5) affrontare in un Philips qualcuna di queste domande provocatorie:
^ Chiudiamo o no l'oratorio per far spazio a gruppi di preghiera, bibbia?
^ D'ora in poi parliamo di catechisti o di animatori?
^ Perché non aumentiamo le manifestazioni di massa?
^ Non è utile un bel corso di teologia?
^ Basta fare gruppo, facciamo comunità!
^ Distinguiamo bene tra evangelizzazione e preevangelizzazione
«INDICATORI» PER UNA VERIFICA SUI MODELLI Di PASTORALE GIOVANILE
I. Obiettivi pastorali
- quale «fede». contenuti privilegiati e loro organizzazione;
- quale «realizzazione di sé»: quale uomo e per quale società si intende costruire (a livello di identità personale e di rapporto collettivo);
- qual è la funzione della fede nel quadro dei valori generali della persona;
- quali obiettivi intermedi sono evidenziati in ordine al raggiungimento dell'obiettivo globale.
2. Giudizio sull'oggi
- valutazione della «cultura» del tempo in cui si vive;
- valori e disvalori a cui si fa più attenzione.
3. Orientamento metodologico e prassi educativa
- processo-itinerario metodologico: impianto metodologico, canali formativi per la circolazione dei valori, cicli e tappe educative;
- quale «relazione educativa»,
- rapporto tra «educazione» e «educazione alla fede».
4. Rapporto chiesamondo: quale chiesa?
- quale immagine di chiesa percorre il modello;
- rapporto chiesa-mondo: per quale salvezza si opera, quale rapporto con il mondo si privilegia nel modello pastorale, qual è la specificità del cristiano in rapporto all'umano;
- i momenti tipici dell'esistenza cristiana (ascolto della parola celebrazioni esperienza di comunione ecclesiale) come sono valutati, come sono organizzati in «spiritualità», qual è la loro funzione in rapporto alla presenzaimpegno storico;
- dimensione missionaria;
- livello di appartenenza ecclesiale e rapporto con la chiesaistituzione.
5. Prassi associativa
- ruolo affidato all'espedenza di gruppo in ordine alla maturazione personale e in ordine all'esperienza ecclesiale;
- quale modello di «transazione» viene ipotizzato tra il gruppo, le persone che lo compongono, il sistema sociale (chiesa istituzionale, società ...);
- il problema dello «sbocco»: quale futuro per il gruppo (elaborazione di uno stile personale di vita verso comunità alternative verso semplici gruppi di riferimento ...).
6. Orizzonte culturale
- quadro di riferimento antropologico fondamentale (definizione dell'uomo in sé, del suo rapporto con la realtà, concezione della verità);
- valutazione globale del contesto socioculturale in cui il modello è presente e per cui agisce.
(Cf R. Tonelli, Pastorale giovanile, o.c., pagg. 60-66).













































