Carmine Di Sante
FIGURE DELLA FEDE
Meditazioni per adolescenti e giovani
Elledici 1998
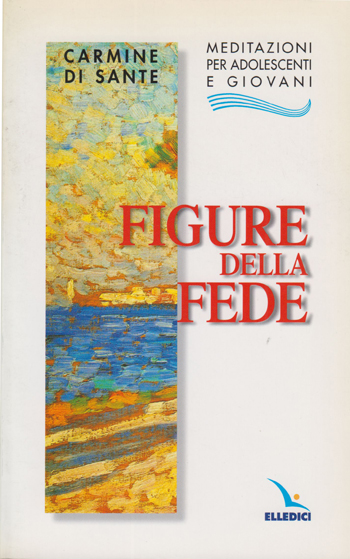
INTRODUZIONE
I PERSONAGGI DELLA BIBBIA
Figure lontane e vicinissime
Perché leggere la bibbia
ABRAMO
La chiamata
Il Signore disse ad Abram
ABRAMO
La risposta
Allora Abram partì
ABRAMO
La promessa di felicità
Diventerai una benedizione
SARA
La sterile
C'è forse qualche cosa impossibile per il Signore?
SARA
La sterile feconda
Il Signore visitò Sara
SARA
Paradigma del gratuito
Sara concepì e partorì
GIACOBBE
Lottare contro Dio
Non ti lascerò se non mi avrai benedetto
GIACOBBE
Chi è Dio
Perché mi chiedi il nome?
GIACOBBE
Chi sono io?
Non ti chiamerò più Giacobbe
AGAR
Storia di una esclusione
Che hai Agar? Non temere
AGAR
Storia di una violenza
Scaccia questa schiava e suo figlio
AGAR
Storia di una elezione
Ma Dio udì la voce del fanciullo
GIUSEPPE
Rifiutato
I suoi fratelli lo odiavano
GIUSEPPE
Salvato
A lui tutto riusciva bene
GIUSEPPE
Salvatore
Dio mi ha mandato qui
MOSÈ
La rivelazione
Il Signore gli parlava faccia a faccia
MOSÈ
Il monte Sinai
Se volete ascoltare la mia voce
MOSÈ
La terra promessa
Paese dove non ti mancherà nulla
DAVIDE
L'elezione
Io non guardo ciò che guarda l'uomo
DAVIDE
La regalità
Tu pascerai Israele mio popolo
DAVIDE
Il pentimento
Pietà di me o Dio
SALOMONE
La saggezza
Concedi al tuo servo un cuore docile
SALOMONE
Il tempio
Ma è proprio vero che il Signore abita sulla terra?
SALOMONE
Il cantico dei Cantici
Le tue tenerezze sono più dolci del vino
ELIA
La profezia
La sua parola bruciava come fiaccola
ELIA
La difesa di Dio
Gridate con voce più alta
ELIA
Come difendere Dio?
Non sono migliore dei miei padri
ELISEO
Il discepolo
Lo spirito di Elia si è posato su Eliseo
ELISEO
Il compassionevole
Che posso fare per te?
ELISEO
La moltiplicazione dei pani
Ne mangeranno e ne avanzerà anche
A mio figlio Lorenzo
nei cui occhi vedo riflessigli occhi
di tutti i ragazzi e ragazze
del mondo:
perché l'amicizia con Dio
sia il tesoro segreto
più prezioso della sua vita
INTRODUZIONE
Non è bene muoversi e correre tutto il giorno. Spesso c'è da interrompere e sostare. Come quando fai una scampagnata o scali una montagna: se ogni tanto non ti fermi e ti metti seduto vai in panne. Devi fermarti non solo per riposarti e recuperare le forze perdute, ma per contemplare i paesaggi percorsi o intravisti e fissarli nel cuore e nella mente come quadri o poesie da portare sempre dentro e che ti faranno compagnia quando torni a casa.
È bene quindi durante il giorno interrompere il cammino di tanto in tanto. Non solo il cammino con le gambe, ma anche il cammino con la mente. Sì, perché esistono due tipi di cammini: uno fatto con i piedi, dove a portarti da un luogo all'altro è il corpo, l'altro con il pensiero, dove a guidarti è la mente.
Queste due figure di viaggi richiedono ambedue delle soste. Quello con la mente più di quello con le gambe perché la mente ha il potere di condurti più lontano e, non conoscendo la stanchezza delle gambe, che misura le tue forze, può illuderti e ingannarti, facendoti perdere la bussola e l'orientamento. Di qui la necessità di fermarti di tanto in tanto: con la mente che sogna e con quella che pensa, con quella che fantastica e con quella che progetta. Perché il sognare e il progettare sono sì importanti, ma non sono né possono essere la parola ultima. Oltre il sognare e oltre il progettare c'è un "di più" che chiede di essere accolto e ascoltato, come si accoglie un amico o si ascolta una voce. Per questo quindi c'è da fermarsi e sostare.
Non ti si chiede di fermarti a lungo ma pochi istanti. Perché è in un istante che il raggio di luce penetra nella notte e la rischiara riconsegnando le cose al loro volto e al loro sorriso.
Le pagine che seguono sono state concepite come riposo e come sosta nell'arco quotidiano. Esse possono essere lette in ogni istante: al mattino, all'inizio del giorno che ci attende con le sue gioie, le sue fatiche e le sue incertezze; alla sera, quando, prima di riconsegnarci al riposo della notte, per la coscienza è tempo di bilanci; oppure in qualsiasi momento del giorno quando si dispone di un po' di tempo e si è aperti a dialogare con il proprio io.
Ogni pagina, cioè ogni capitoletto, offre quattro stimoli: 1) una riflessione o meditazione intorno ad un personaggio biblico, considerandone uno o più aspetti; 2) due o tre domande da rivolgere al proprio io; 3) una breve preghiera con cui parlare a Dio; 4) una brevissima frase, versetto o motto da memorizzare e "ruminare" (e, per questo, chiamato "ruminatio", secondo il significato latino che letteralmente vuol dire masticare a lungo e assimilare) e ripetere più volte durante il giorno.
"Il Signore è con me. Non manco di nulla". Prova a "ruminare", a ripetere durante il giorno un versetto come questo. Non una volta ma dieci, venti, trenta, quaranta, cinquanta, cento volte: camminando per la strada, guidando la macchina, sentendoti nervoso, arrabbiato o angosciato, abitato da pensieri pessimisti, oppure stanco e sfiduciato del mondo e degli amici. Scoprirai come lentamente in te qualcosa cambia. E come nella tua vita si accende lentamente la luce di una Presenza. Quella di Dio. Quella del suo "Tu" che ti parla, ti ama e ti accompagna. E scoprirai quanto, in compagnia di questo Tu, la vita è più bella.
I PERSONAGGI DELLA BIBBIA
Figure lontane e vicinissime
Perché leggere la bibbia
La bibbia non è un libro di vicende storiche. Non è un testo di filosofia. Neppure è una raccolta di poesie o di brani di particolare bellezza letteraria. E' tutto questo, ma è soprattutto più di questo. La bibbia è innanzitutto il racconto di una storia d'amore: tenera e affascinante ma anche, come ogni storia d'amore, intrigante e inquietante. Anzi più intrigante e inquietante di ogni altra, perché al suo centro si stagliano due protagonisti "stra-ordinari": Dio e l'uomo.
Dio: il Tu che le culture e i popoli da sempre hanno riconosciuto come il mistero e la sorgente di ciò che esiste e il Tu al quale la maggioranza degli uomini e delle donne si è sempre rivolta con fiducia nel nascere, nel vivere e nel morire. Ma Tu discreto e rispettoso che non si impone con la forza ma parla con il silenzio per cui può essere disatteso, ignorato o rinnegato, come è avvenuto negli ultimi due secoli nell'Europa cristiana dove molti hanno messo in discussione la sua presenza e il suo senso dichiarandosi "atei", cioè senza Dio.
E poi l'uomo: l'essere più nobile ed eccezionale dell'universo, perché dotato della capacità di pensare e di amare. Ma anche il più "terribile" e "temibile", capace delle peggiori nefandezze e violenze, come sta a ricordarci, con la pesantezza di un macigno irremovibile, l'"olocausto" o, con linguaggio più appropriato, shoah (termine ebraico che vuol dire "catastrofe" o "dis-astro", nel senso etimologico di "caduta" di un astro): la programmazione e lo sterminio di sei milioni di ebrei, un milione dei quali bambini, come pure di malati mentali, di handicappati, di diversi e di improduttivi, durante il periodo nazista in Germania nell'ultima guerra mondiale. L'uomo essere " bi-fronte" o "bi-forme", in cui sembra celarsi sia il volto dell'angelo che quello della bestia, sia il fiducioso dottor Jekyll che il mostruoso signor Hyde.
Questa storia d'amore ha un nome, un luogo e una data. Inizia con Abramo in Ur dei Caldei, in una regione asiatica, e si protrae per quasi duemila anni, dal 1800 a. C. al 100 d. C. in uno scenario geografico immenso e sconfinato che si estende dalla Mesopotamia all'Egitto, alla Fenicia, alla Siria, a Gerusalemme, ad Atene, a Roma ed è popolata da una schiera interminabile di personaggi dai nomi quasi sempre strani e dalle storie spesso stravaganti, inverosimili o impossibili. E' intorno a questi personaggi che si tesse la storia d'amore tra Dio e l'uomo. Centinaia di personaggi originali e variopinti accomunati, nella loro profonda e irriducibile differenza, da un unico tratto: di essere stati incontrati da Dio nella loro strada e di non essere stati più gli stessi dopo quell'incontro sconvolgente.
Nella bibbia sono tanti i personaggi con i quali Dio si è incontrato: giganti dello spirito e celeberrimi, come Abramo, Sara, Mosè, Davide, Salomone, Elia; oppure umili e sconosciuti come Agar. La storia di questi personaggi è interessante e affascinante perché nelle loro storie si celano le origini stesse della nostra storia. Ma soprattutto perché in esse si narra di un qualcosa che riguarda ognuno di noi personalmente: me, te, ogni ragazza e ogni ragazzo, ogni donna e ogni uomo. E' questo il motivo per cui questi personaggi, pur essendo legati ad epoche e culture del passato, si collocano al di là di ogni epoca e di ogni cultura e restano sempre vivi e attuali perché ciò che di essi si narra e in essi accade si offre come possibilità per ogni lettore ancora oggi: la possibilità dell'incontro con Dio e del coinvolgimento in una storia d'amore con l'Eterno che, più di ogni altra storia d'amore, è in grado di cambiare radicalmente la propria esistenza.
È questa la ragione per la quale la bibbia viene letta ancora oggi e tu sei invitato a confrontarti con i suoi personaggi. Perché quelle pagine e questi personaggi ti riguardano. Con le loro storie e con il loro silenzio essi ti dicono: "Anche tu, come noi, sei incontrato da Dio".
Interrogarsi
- Che posto occupa la lettura della bibbia nella tua vita?
- Hai mai pensato all'importanza della bibbia per la tua crescita spirituale?
- Perché confrontarsi con i personaggi biblici? Per delle ragioni solo culturali oppure per delle ragioni più profonde?
Preghiera
Signore
Tu che abiti negli abissi
degli oceani
e ti riverberi
nel sorriso dei bimbi,
rivelati a noi
con amore:
come ti rivelasti
ai santi,
ai profeti
ai patriarchi
e alle patriarche
della bibbia.
Amen.
Ruminatio
La tua parola mi fa vivere (Sal 119, 50)
ABRAMO
La chiamata
"Il Signore disse ad Abram"
Da Ur dei Caldei, dov'era nato intorno al 1850 a. C., Abramo si trasferisce a Carran, la città a nord della Mesopotamia, la fertile terra tra il Tigri e l'Eufrate dove, fin dalle epoche più antiche, fiorì una tra le più splendide civiltà mondiali. E' proprio qui a Carran che ad Abramo capitò un fatto sconvolgente che modificò il corso della sua vita e della storia umana:
«Il Signore disse ad Abram:
"Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria
e dalla casa di tuo padre,
verso il paese che io ti indicherò.
Farò di te un grande popolo
e ti benedirò,
renderò grande il tuo nome
e diventerai una benedizione.
Benedirò coloro che ti benediranno
e coloro che ti malediranno maledirò
e in te si diranno benedette
tutte le famiglie della terra" » (Gn 1, 1-3).
Abramo si trova di fronte a un Dio che gli parla. Fatto inaudito: perché per Abramo e i suoi contemporanei era l'uomo a rivolgersi a Dio ma non Dio all'uomo. Dio non poteva rivolgersi all'uomo essendo pienezza e perfezione non mancante di nulla. Al contrario solo l'uomo si rivolgeva a Dio, per desiderarne la vicinanza e invocarne la forza.
L'esperienza sconvolgente di Abramo è che, all'improvviso, questa concezione gli si sfalda e Dio gli "appare", cioè gli si rivela, come altro: non come la perfezione verso la quale l'uomo tende per spinta naturale, bensì come Tu che liberamente si china sull'uomo, rivolgendogli la parola per primo, come fa l'innamorato con l'amata, e instaurando con lui un rapporto di comunione e di dialogo. L'esperienza sconvolgente di Abramo è di aver capito che, nella sua profondità ultima e radicale, l'uomo è relazione di fronte a Dio: il suo essergli interlocutore e partner. Certo, anche per Abramo l'uomo è e resta sempre appartenenza: ad una terra, ad un'epoca storica, ad una cultura, ad una politica, ad una "ideologia", ad una religione, ecc. Ma dentro la logica delle appartenenze, Abramo scopre un "di più" che, pur dentro tutte le appartenenze, le trascende e le relativizza: "Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre". Questo "di più" che Abramo coglie dentro il "paese", la "patria" e la "casa di suo padre", cioè entro la totalità onnicomprensiva della civiltà in cui viveva, è "il di più" della relazione con Dio. Un "di più" irriducibile alla totalità e instauratore di novità radicale.
"Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò": la novità che si dischiude dal trovarsi di fronte a Dio che ti parla non è la riproduzione del "passato" e del "già dato" ma l'apparire, nella tua vita, del totalmente altro, del "Tu" divino" che ti ama e ti accompagna in ogni istante.
Interrogarsi
- Cosa ti colpisce della figura di Abramo, il patriarca al quale Dio rivolge la parola chiedendogli di uscire dalla "propria" terra?
- Cosa vuol dire per te uscire, come Abramo, dal "tuo paese", dalla "tua patria" e dalla "casa di tuo padre"?
- Riesci a sentire il senso di libertà e di felicità per il fatto di trovarti di fronte al Tu di Dio che ti ama?
Preghiera
Dovunque io vada, tu!
dovunque io sosti, tu!
solo tu, ancor tu, sempre tu!
tu, tu, tu!
Se mi va bene, tu!
se sono in pena, tu!
solo tu, ancor tu, sempre tu!
tu, tu, tu!
Cielo, tu, terra, tu,
sopra, tu, sotto, tu,
dove mi giro, dovunque miro,
solo tu, ancor tu, sempre tu
tu, tu, tu (M. Buber).
Ruminatio
Signore, tu mi scruti e mi conosci (Sal 139, 1).
ABRAMO
La risposta
"Allora Abram partì"
A Dio che gli si rivela come Tu che lo comanda, Abramo risponde obbedendo: "Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore". E' questa l'annotazione scarna del testo biblico. Obbedire rimanda alla radice latina ob-audire e vuol dire ascolto acconsentito, ascolto che, mentre ascolta, aderisce con il proprio "sì" a ciò che ascolta. La risposta di Abramo a Dio che gli si rivela è l'obbedienza, un'obbedienza immediata, che non chiede nulla: né una spiegazione o una motivazione ("chi sei Tu che mi chiami?"), né una rassicurazione o garanzia ("è proprio vero quello che dici e che prometti?") e neppure un tempo di riflessione, di approfondimento o di ripensamento ("fammici pensare"). "Allora Abram partì": una obbedienza muta e silenziosa, che non fa domande e non pone interrogativi ma semplicemente agisce accogliendo ed eseguendo l'ordine ricevuto. Dio comanda ad Abramo: "vàttene dal tuo paese", ed egli va; "esci dalla tua patria", ed egli esce; "lascia la tua casa", ed egli lascia; "parti", ed egli subito parte". In questo "partire" ("Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore") senza domande, pura espressione della sua obbedienza, c'è tutto Abramo: il suo abbandono, la sua fede e la sua fiducia nel Dio che gli si rivela.
Ma perché obbedire così immediatamente? Perché non chiedere nulla? Perché non fare domande? Perché non esigere spiegazioni? Perché non porre condizioni? "Vàttene dal tuo paese". Per quale ragione? E per andare dove? "Fuori" dalla propria terra conosciuta, "fuori" dal proprio spazio noto, "fuori" dai propri sentieri familiari. Ma perché andare "fuori" e perché cercare "altrove"? Quale il significato di questo "fuori" e di questo "altrove"?
Abramo non si pone queste domande e semplicemente obbedisce, dicendo "sì", non perché non voglia sapere bensì perché ha scoperto un nuovo sapere dischiuso dal quel Tu che gli ha parlato. Abramo sa - e per questo non chiede - perché si fida del Tu che gli ha parlato. E sa che ciò che il Tu gli dice corrisponde alla verità non perché è in grado di capirlo con l'intelligenza o verificarlo bensì perché si fida di chi gli ha parlato.
Per questo Abramo è, secondo la definizione di Paolo, "il padre di tutti i credenti" (Rm 4,11ss). Egli è il "paradigma" della fede, colui il quale, con il suo sì a Dio, mostra ai credenti di tutti i tempi e anche a noi oggi cosa vuol dire avere fede e credere in Dio: fidarsi della sua Parola e abbandonarsi al suo Tu che non può deludere. Fidarsi sempre e comunque, cioè incondizionatamente, anche quando i conti non tornano, anche quando la logica sembra contraddetta, come quando Dio chiede ad Abramo di sacrificargli il suo figlio Isacco sul monte Moria. Il senso di questa pagina, la più tesa e drammatica del testo biblico, non è di presentare Abramo alle prese con un Dio assurdo e insostenibile ai limiti della violenza (come è possibile che Dio comandi ad un padre di sacrificare suo figlio?), bensì quello di disegnare in Abramo, con la potenza del linguaggio narrativo, l'esemplare della fede radicale che, mentre contesta il divino come violenza (Isacco non viene infatti sacrificato!), si affida incondizionatamente a Dio: non perché la fede incondizionata possa convivere con l'assurdo e con la violenza bensì perché la fede incondizionata dischiude un orizzonte di luminosità tale - l'orizzonte della fede appunto - dove ciò che alla ragione o al buon senso appare come assurdo e violenza, si dilegua come nebbia al sole.
Interrogarsi
- Perché Abramo obbedisce a Dio senza chiedere nulla e porre condizioni?
- Cosa vuol dire "obbedire"?
- Hai mai pensato al senso dell'obbedienza come fiducia e affidamento a Dio?
Preghiera
Signore,
Tu mi rivolgi la parola,
chiamandomi per nome
e interessandoti
alla mia storia.
Come Abramo,
mi fido di te
e mi abbandono a Te
perché so
che sei l'Amore
che non deludi
e sconfiggi
le tenebre
del caos
e della morte.
Amen.
Ruminatio
In te, mai sarò deluso (Sal 31, 2).
ABRAMO
La promessa di felicità
"Diventerai una benedizione"
Abramo si fida del Tu che lo comanda e gli chiede di uscire dalla sua "terra" per avventurarsi in un "altrove" ignoto ed obbedisce senza chiedere spiegazioni e senza esigere garanzie. Ma come è possibile, ti chiederai, obbedire senza chiedere spiegazioni e senza esigere garanzie? E poi l'obbedienza non mette in causa l'autonomia e la dignità dell'io? Non è vero che l'uomo adulto e maggiorenne che tu sogni e che la modernità ha sognato e ancora sogna è di liberarsi da tutti i legami e da tutte le dipendenze?
Per Abramo le cose stanno diversamente, perché in quel Tu che lo comanda con la forza dell'imperativo categorico, cioè incondizionato, egli sente e scopre non l'ostacolo che lo limita bensì la Presenza dell'Amore che lo sorprende. Il Tu che lo comanda e al quale si consegna non è il Tu della legge impersonale o del padrone bensì il Tu del padre per il figlio o dell'amante per l'amata la cui volontà è volontà di bene, sollecitudine e tenerezza. Abbandonarsi a quel Tu e acconsentire al suo comando non è, per Abramo, umiliarsi e perdersi ma innalzarsi e arricchirsi: "Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione". Alla presenza del Tu divino, Abramo si scopre ricco di una ricchezza che non consiste nell'arricchirsi quanto nell'arricchire, non nell'essere-per-sé bensì nell'essere-per-gli-altri: "In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra".
Cos'è questa "benedizione", che fa di Abramo il capostipite di "un grande popolo" e del suo nome "un grande nome"? Anche se logorata dall'uso e dall'abuso, la "benedizione" che il Tu divino dischiude ad Abramo può essere ridetta con il termine felicità; a condizione di intendere per felicità non la felicità soggettiva, quella che l'io, dimentico degli altri, ricerca per sé, bensì la felicità oggettiva, quella che l'io, dimentico di sé, ricerca per l'altro e per ogni altro. La felicità oggettiva, che riguarda l'altro ed ogni altro, non nega la propria ma la radica nell'orizzonte della verità e della universalità, nel senso che la propria felicità per essere veramente tale (è questo l'orizzonte della verità) deve volere e promuovere quella di tutti gli altri (è questo l'orizzonte della universalità). Alla presenza del Tu divino Abramo si scopre "benedizione per tutte le famiglie della terra": diviene testimone di una promessa di felicità che coinvolge non solo lui personalmente ma tutti indistintamente ("tutte le famiglie della terra").
Come Abramo anche tu sei destinato alla benedizione, cioè alla felicità. Tu sei voluto per essere felice, perché ogni tuo giorno e ogni tua notte siano come dei bicchieri colmi. Ma Abramo insegna che la felicità è una cosa strana che non si raggiunge curandosi del proprio io ma curandosi dell'altro e che la vera ricchezza non consiste nel riempire il proprio bicchiere ma nello svuotarlo, non nel volere le cose per sé ma nel donarle.
Interrogarsi
- In che senso Abramo è una "benedizione" per tutti i popoli della terra?
- Qual è il rapporto tra felicità soggettiva e oggettiva?
- In che senso l'io si arricchisce se rinuncia ad arricchirsi?
Preghiera
Signore
Tu hai fatto di Abramo
un grande nome
e un grande popolo
perché si è fidato di te
e della tua parola
e lo hai reso benedizione
per tutte le famiglie della terra.
Fa' anche della mia vita
una benedizione
e una ricchezza
per quanti incontrerò
lungo la strada
e al mio fianco.
Amen.
Ruminatio
Felicità e grazia mi saranno compagne per tutti i giorni della mia vita (Sal 23, 6).
SARA
La sterile
"C'è forse qualche cosa impossibile per il Signore?"
«Sara, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana chiamata Agar, Sara disse ad Abram: "Ecco, il Signore mi ha impedito di aver prole; unisciti alla mia schiava: forse da lei potrò avere figli". Abram ascoltò la voce di Sara. Così al termine di dieci anni da quando Abram abitava nel paese di Canaan, Sara, moglie di Abram, prese Agar l'egiziana, sua schiava, e la diede in moglie ad Abram, suo marito. Egli si unì ad Agar, che restò incinta" » (Gn 16, 1-4).
Con queste scarne parole il testo biblico adombra l'indicibile sofferenza di Sara che, sterile, consegna a suo marito la schiava Agar perché fosse lei, secondo il diritto mesopotamico di quell'epoca, a provvedergli una discendenza. Condannata alla sterilità, Sara incarna la sofferenza per la maternità mancata e, contemporaneamente, la volontà di non rassegnarsi ad essa, ricorrendo a tutti mezzi allora consentiti. Ancora oggi, è noto, quanto sia doloroso per una donna non avere figli e a quale calvario di sacrifici sia disponibile pur di adottare un bambino oppure curarsi sottoponendosi a ricerche e interventi medici prolungati.
Ma un giorno alla sterile Sara accadde, secondo il racconto biblico, un fatto straordinario. Nell'ora più calda della giornata, mentre Abramo sedeva all'ingresso della sua tenda a Mamre, gli apparvero tre personaggi strani che, in cambio della ospitalità avuta, gli fecero una promessa inaudita: «Gli dissero: "Dov'è Sara, tua moglie?" Rispose: "E' là nella tenda". Il Signore riprese: "Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio". Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda ed era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni; era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: "Avvizzita come sono dovrei provare il piacere, mentre il mio signore è vecchio!". Ma il Signore disse ad Abramo: "Perché Sara ha riso dicendo: Potrò davvero partorire, mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te alla stessa data e Sara avrà un figlio". Allora Sara negò: "Non ho riso!", perché aveva paura; ma quegli disse: "Sì, hai proprio riso!"» (Gn 18, 9-15).
Sara è testimone dell'annuncio della maternità imminente. Annuncio paradossale, perché sia lei che Abramo erano avanti negli anni e impossibilitati a generare per una ragione naturale. L'annuncio dei tre personaggi è inaudito perché sfida l'ordine naturale (è naturale che una donna anziana non possa più generare!) impossibile e ingiusto da modificare. L'in-credibile e l'in-audito di questo impossibile che si vuole possibile è quanto denuncia il commento ironico di Sara su di sé ("Avvizzita come sono dovrei provare il piacere") e su Abramo ("mentre il mio signore è vecchio!")
Quante volte anche tu, come Sara, hai sentito la tua vita infeconda: come una terra arida senza acqua, come un deserto bruciato, come un vicolo cieco, come un orizzonte chiuso senza speranza, come un vuoto incolmabile senza attesa, come un grembo di donna incapace di generare. Quante volte! Ma la storia di Sara insegna che non esiste al mondo situazione disperata che Dio non sappia capovolgere e sovvertire: "Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio". Quando Dio irrompe nel tuo mondo, come il grembo di Sara esso si apre all'incredibile e all'inaudito del totalmente nuovo.
Interrogarsi
- Perché Sara si ribella alla sua condizione di sterile?
- Per quale ragione Sara non si fida delle parole dei tre strani personaggi?
- Quali situazioni di "infecondità" riscontri nella tua vita e nella società attuale?
Preghiera
Qualche volta
Signore
sento la vita
come un tronco senza rami
un albero senza frutti
un grembo senza vita.
Sento
ma non è vero
perché so
Signore
che tu sei il Dio della vita
che non ti stanchi
di sorprenderci
e amarci.
Amen.
Ruminatio
Getta sul Signore il tuo affanno (Sal 35, 23).
SARA
La sterile feconda
"Il Signore visitò Sara"
Che una donna sterile partorisca contraddicendo le leggi naturali, è impossibilità reale, che merita solo l'abbozzo del sorriso, come fa Sara, oppure è una possibilità altra dalle altre, come pensa il misterioso personaggio che, perentorio, sfida Abramo chiedendogli se ci sia "qualcosa di impossibile per il Signore" e promettendogli che sarebbe tornato da lui quando Sara gli avrebbe partorito veramente un figlio nonostante l'età avanzata di ambedue? Da che parte si trova la "ragione": da parte di Sara, che si prende gioco del misterioso personaggio, anche se nascostamente e non apertamente, oppure di quest'ultimo che la sfida?
«Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece come aveva promesso. Sarà concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito... Abramo aveva cento anni quando gli nacque il figlio Isacco. Allora Sara disse: Motivo di lieto riso mi ha dato Dio: chiunque lo saprà sorriderà di me!". Poi disse: "Chi avrebbe mai detto ad Abramo: Sara deve allattare figli! Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia!" » (Gn 21, 1-7).
Scoprendosi incinta contro la sua stessa aspettativa, Sara diviene la "sterile feconda", l'immagine stessa di un ossimoro (figura letteraria che consiste nel mantenere uniti due termini di per sé autoescludentisi, come ad esempio quando si dice di un "amaro" che è "dolce" o di un "intelligente" che è "stupido") dove la sterilità, lungi dall'opporsi alla fecondità, convive con una più profonda fecondità e dove questa, lungi dal negare la sterilità, la esige.
Ma come è possibile questa strana metamorfosi o ossimoro che trasforma la sterilità in fecondità, sospendendo l'ordine naturale (appartiene infatti all'ordine naturale che una donna ad una certa età non sia più feconda) e rendendo possibile l'impossibile di una vita nuova?
Per il racconto biblico questa metamorfosi non è dovuta ad un intervento immanente all'ordine naturale, come avviene quando una donna sterile per vincere la sterilità si sottopone a cure mediche, ma ad un intervento trascendente l'ordine naturale e avente come soggetto Dio: "Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece come aveva promesso. Sarà concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato". Ciò che trasforma Sara sterile in feconda ed istituisce nel suo grembo il passaggio dalla non vita alla vita non riguarda l'ordine naturale ma il trascendimento dell'ordine naturale e il dischiudersi di un nuovo ordine che, per la bibbia, è la "visitazione" di Dio a Sara.
Con questa pagina la bibbia non vuole insegnare che Dio "è il Dio tappabuchi" che si sostituisce alla natura e alla progettualità umana ma che egli è il Dio incatturabile e che incontrarlo è incontrare la novità assoluta che, oltre la natura, dove la novità è riproduzione del già noto, e oltre il progetto, dove la novità è proiezione al futuro del già dato nel passato, è sguardo altro su di sé, sul mondo e sul reale.
Interrogarsi
- In che senso niente è impossibile a Dio?
- Qual è la differenza tra il Dio "tappabuchi" e il Dio biblico?
- Qual è il senso della visitazione di Dio a Sara?
Preghiera
Nulla per te
Signore
è impossibile:
perché ogni mattina
tu ricrei il mondo,
riconsegnandolo
alla bellezza dei colori
e della forma,
e perché, visitando Sara,
le hai fatto dono
di una vita nuova.
Mi fido di te
Signore
e fa' che mai dubiti
che nulla
è impossibile
al tuo amore.
Amen.
Ruminatio
Crea in me, Signore, un cuore nuovo (Sal 51, 12).
SARA
Paradigma del gratuito
"Sara concepì e partorì"
Visitando una persona non si va mai a mani vuote. Bussando alla sua porta ed entrando nella sua casa, si va a mani piene, portando doni.
Dio "visitando" Sara, le porta la vittoria della sterilità, il dono di generare, il miracolo della nascita, il passaggio dall'infecondo al fecondo. La vita, in una parola: "Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella sua vecchiaia" (Gn 21, 2). Dio per la bibbia è il Dio "visitatore" che, per sua libera iniziativa, senza essere richiesto né atteso, irrompe in una casa e vi porta la vita contro la morte. Dio per la bibbia è il Vivente che, dove passa, sconfigge la morte e fa fiorire la vita. Essere visitati da lui è incontrare la vita.
Ma quale vita? Sembrerebbe che la vita donata a Sara sia la riattivazione della vita naturale, la capacità di generare bloccata dalla sterilità innata. Ma non è dalla sterilità innata che, con la sua visitazione, Dio guarisce Sara, bensì da una sterilità più radicale che non riguarda l'ordine oggettivo ma l'ordine soggettivo, non la logica della natura ma la logica del cuore. Per noi, figli della scoperta dell'io e del soggetto, non ci vuole molto per capire che non è l'ordine naturale a garantire la qualità del vivere e che una donna, anche se capace di generare figli e figlie, può vivere ugualmente una vita di inferno e di insensatezza. La vita dell'uomo non è definibile, per la bibbia, dall'ordine naturale ma da un di più che è la relazione con Dio riconosciuto e amato come Tu; un "di più" che non si sostituisce all'ordine naturale ma lo risignifica e trasfigura dischiudendovi un nuovo senso: la relazione e il gratuito al posto della totalità e della necessità.
È a questo livello che si attinge il significato profondo dell'ossimoro biblico della sterile feconda di cui non solo Sara ma anche altre donne, come Rachele e Lia, costituiscono, nella bibbia, le figure esemplari. Mettendo in scena figure sterili che generano per l'intervento di Dio e non in forza del principio naturale la bibbia non intende sostituire Dio alla natura ma dischiudere nella natura la presenza di "un di più" che è il suo Amore personale. Alla luce di questo "di più" la parola ultima e fondante del reale non è più l'ordine naturale ma l'amore personale di Dio che in esso prende corpo, trasfigurandolo e rivelandolo come dono per l'uomo.
Tutto è grazia perché tutto ci è dato dall'amore personale di Dio: questo è il messaggio dell'ossimoro biblico della sterile feconda. Attraverso la "messa in scena" della visitazione di Dio alla sterile Sara, la bibbia svela, con la potenza del racconto mitico, il senso ultimo del reale che è l'ordine della relazione personale con il divino: "Tu" che attende di essere riconosciuto e acconsentito dal "tu" umano. Generare, per la bibbia, non è l'espressione di una legge generale ma l'evento dell'amore di Dio personale. Allo stesso modo che mangiare non è obbedire ad un processo naturale ma, secondo il racconto di Israele nel deserto, essere invitati da Dio ad un banchetto dove si è nutriti gratuitamente dal suo amore. Il senso dell'ossimoro della sterile feconda è lo sfondamento dell'ordine naturale e l'apertura dell'ordine dialogico e personale dove Dio e l'uomo si incontrano e parlano da amici.
Interrogarsi
- Cosa intendi tu per vita?
- In che senso per la bibbia il valore della vita va colto sul piano relazionale prima che naturale?
- Perché Sara è il paradigma di un modo di porsi nel mondo dove ciò che conta è il gratuito: non ciò che l'io fa ma ciò che all'io viene fatto?
Preghiera
Signore
do tutto per scontato:
il sole che nasce
l'albero che fa ombra
le gambe che mi portano
la mano dell'amico che mi stringe
e il pane che papà e mamma
non fanno mai mancare sulla mensa.
Do tutto per scontato,
Signore.
E non penso
che dietro ogni cosa
c'è la tua Presenza
silenziosa e personale
che grida
quanto tu ci ami.
Amen.
Ruminatio
Aprimi gli occhi, perché il veda (Sal 119, 18).
GIACOBBE
Lottare con Dio
"Non ti lascerò se non mi avrai benedetto"
In uno dei racconti più strani della bibbia si narra dell'incontro di Giacobbe con un non ben definibile personaggio in una notte sul torrente Iabbok: "Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi undici figli e passò il guado dello Iabbok. Li prese, fece passare il torrente e fece passare anche tutti i suoi averi" (Gn 32, 23-24).
Ed ecco che all'improvviso «Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quegli disse: "Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora". Giacobbe rispose: "Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto!". Gli domandò: "Come ti chiami?". Rispose: "Giacobbe". Riprese: "Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!". Giacobbe allora gli chiese: "Dimmi il tuo nome". Gli rispose: "Perché mi chiedi il nome?". E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel "Perché - disse - ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva". Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca» ( Gn 32, 24-32).
In questa storia enigmatica e insondabile si cela l'esperienza del divino per la bibbia, dove si dice come Dio viene incontro all'uomo e come all'uomo è dato riconoscerlo.
Innanzitutto da notare il contesto della notte e della solitudine in cui avviene l'incontro tra Giacobbe e Dio. "Giacobbe rimase solo": Dio lo si incontra nella notte quando si rimane "soli", quando cessa la "chiacchiera" del giorno e si rimane nella solitudine e in ascolto. La "chiacchiera" è il parlare vano, il vani-loquio, metafora dell'inautenticità dell'esistenza umana che si perde nell'anonimato del "si dice" impersonale. La notte, luogo del silenzio, sottrae l'uomo alla chiacchiera del vani-loquio, ed è la condizione, per la bibbia, dell'esistenza autentica come esistenza di fronte a Dio.
Di un Dio però che non si presenta con la luminosità della luce ma con l'ambiguità del prossimo, provocante ed inquietante: "E un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora". Dio ci viene incontro in maniera anonima, attraverso la voce di un maestro, di un saggio, di un amico o di un estraneo e riconoscerlo e consegnarglisi non è rinuncia ma passione e confronto che esigono impegno e lotta. Credere è "lottare", dove le ragioni per il "sì" o per il "no" si scontrano e dove, all'improvviso, il "sì" si impone sul "no" per forza interna: "Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui". Per quanto gli si voglia opporre resistenza, Dio è più forte di ogni resistenza e prima o dopo egli si insinua nella nostra vita con una mossa impensabile e imprevista, come quella dello "sgambetto" con il quale Giobbe viene vinto.
Interrogarsi
- Qual è la tua prima impressione di fronte a una storia così strana?
- La solitudine ti fa paura oppure è lo spazio dove tacciono le voci della chiacchiera per ascoltare ed incontrare Dio?
- Come ci viene incontro Dio e in che senso si può parlare di una "lotta" tra noi e lui?
Preghiera
Signore
tu sei presenza
discreta e silenziosa
che non ti imponi
con la forza
ma ti nascondi
e attendi con pazienza.
A volte mi sembri
lontano o assente
e lotto
tra il credere e il non credere.
Ma tu
Signore
sei più forte delle mie resistenze
e trionfi
sulla mia incredulità
e debolezze.
Amen.
Ruminatio
Non nascondermi il tuo volto, Signore (Sal 102, 3).
GIACOBBE
Chi è Dio?
"Perché mi chiedi il nome?"
Entrando nella nostra esistenza, Dio vi entra come enigma che affascina ma sfugge alla presa umana: «Quegli disse: "Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora"» (Gn 32, 27). Avendone sperimentato la potenza, Giacobbe vorrebbe appropriarsene, ma il misterioso personaggio si schernisce supplicandolo ironicamente di lasciarlo andare. A questa richiesta Giacobbe acconsente ad una condizione: "Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto!". Segue poi il dialogo in cui i due personaggi cercano di venire allo scoperto: « Gli domandò: "Come ti chiami?". Rispose: "Giacobbe". Riprese: "Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!". Giacobbe allora gli chiese: "Dimmi il tuo nome". Gli rispose: "Perché mi chiedi il nome?". E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel "Perché - disse - ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva". Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca» (Gn 32, 28-33).
Al "come ti chiami" del misterioso personaggio, segue il "come ti chiami" di Giacobbe: "Dimmi il tuo nome". Ma ecco nuovamente l'imprevisto: «Gli rispose: "Perché mi chiedi il nome"». Egli si rifiuta di dire il nome, per far seguire al nome la silenziosa espressività del gesto: "e qui lo benedisse".
Chi è Dio e qual è il suo nome? Dio è il benedicente e non ha altro nome che non sia la benedizione: "La sua benedizione si diffonde come un fiume e irriga come un'inondazione la terra" (Sir 39, 32). E' di fronte a questo gesto di benedizione che Giacobbe capisce chi è lo strano personaggio col quale si è scontrato e che sotto le sue sembianze anonime si nasconde Dio stesso: «Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel "Perché - disse - ho visto Dio faccia a faccia" ». Secondo l'etimo popolare ebraico, Penuel vuol dire "davanti (peni) a Dio (El) e Giacobbe capisce di trovarsi di fronte a Dio sperimentandone la benedizione.
La domanda chi sia Dio e quale il suo nome è ardua e affascinante. Mosè, colui che la bibbia definisce come l'amico con cui Dio parlava faccia a faccia, quando fu chiamato a liberare il suo popolo dall'Egitto, gliela rivolse direttamente, ricevendo in cambio la risposta enigmatica: "Io sono colui che sono". Che non vuol dire: l'Essere e la Pienezza dell'essere ma la Presenza che sta sempre accanto, camminando a fianco dell'uomo e guidandolo. Chi è Dio? Qual è il suo nome? E' quello di essere Compagnia dell'uomo, l'Emmanuele, l'Im-anu-el: il "Dio-con-noi". Quel "Dio-con-noi" di cui Gesù, per la tradizione cristiana, è la trasparenza stessa, meritando per questo il titolo per eccellenza di "Emmanuele" e di "messia".
Il bene più grande della vita è questa Compagnia. «Giacobbe allora gli chiese: "Dimmi il tuo nome". Gli rispose: "Perché mi chiedi il nome?". E qui lo benedisse». Il nome di Dio è benedizione. Benedizione che inabita concretamente ogni frammento ed istante dell'esistenza umana.
Interrogarsi
- In che senso Dio è enigma o mistero?
- Perché egli si rifiuta di dire il suo nome a Giacobbe?
- Qual è il nome di Dio e cosa vuol dire "Emmanuele"?
Preghiera
Chi sei, Signore,
e qual è il tuo nome?
Quante volte
ho pensato
che se ti conoscessi
e incontrassi
la mia vita fiorirebbe
come un albero
dalle foglie verdi
e dai frutti abbondanti.
Ma il tuo nome, Signore,
è facile da conoscere:
Tu sei "Il-con-me"
Tu sei "Il-con-noi"
Tu sei "Il-per-me"
Tu sei "Il-per-noi".
Grazie Signore
per il tuo nome.
Ruminatio
Il Signore sta alla mia destra, non posso vacillare (Sal 16, 8).
GIACOBBE
Chi sono io?
"Non ti chiamerò più Giacobbe”
Giacobbe capisce chi è Dio nel momento in cui si sente benedetto, cioè oggetto della sua benedizione.
Ma cosa vuol dire essere benedetto? In cosa consiste la benedizione divina? Nella bibbia il termine benedizione è sinonimo stesso di creazione. Per Dio creare è benedire e le cose che esistono, dal pane, al vino, all'acqua, all'albero e alle stelle, sono benedizioni: realtà materiali che, al di là del loro spessore materiale, dicono "il di più" che le sottende e che è l'amore personale di Dio; beni funzionali che, al di là della loro dimensione appetibile, rimandano ad un Bene altro dal bene come desiderabile, il Bene come Bontà, come Bene-volenza, come libertà di amore e come gratuità. Duplice è il significato della benedizione divina pertanto: da una parte l'abbondanza dei beni necessari al bisogno umano, senza i quali l'esistenza, incolmata, si fa carenza e gemito; dall'altra il Tu d'amore divino che, attraverso i beni in cui si incarna, si rivolge all'uomo per istituire con lui la relazione e il dialogo. Per questo la benedizione divina è la pienezza stessa dell’umano: non solo perché coincide con l'abbondanza dei beni ma soprattutto perché dischiude l’orizzonte dove l'uomo, da essere di bisogno, si scopre e si vive come relazione e come tu di fronte a Dio. Essere benedetti da Dio non è solo fruire dei beni necessari al bisogno ma è cogliere, al di là dei beni, la Benevolenza o Bontà che li sottende e che, donandoli, instaura la relazione responsabile. Essere benedetti da Dio è accedere a quella dimensione dell'umano dove l'io, da parte del mondo, naturale o cultuale, si vive come partner di fronte a Dio, nella gratuità e nella responsabilità.
Questa nuova dimensione dell'umano che la benedizione divina dischiude è espressa dalla bibbia con il cambiamento del nome: "Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!" (Gn 32, 29). La benedizione riversata su Giacobbe è acquisizione di una nuova identità e di un nuovo nome: non più Giacobbe ma Israele che, secondo l'etimo ebraico, può significare sia: "Dio è stato forte", sia: "tu sei stato forte con Dio".
A parte l'etimo, l’importante è cogliere che quando Dio incontra l'uomo, l'uomo ne esce interiormente trasformato e che questa trasformazione consiste nella sua elevazione a partner di Dio: colui che, costituito tu dal Tu di Dio, gli sta di fronte come responsabile. Per questo i personaggi biblici, da Abramo, a Sara, a Giacobbe quando incontrano Dio cambiano nome. E per questa stessa ragione, secondo la prassi antica cristiana, quando ci si battezzava o si entrava in un ordine religioso si cambiava ugualmente nome: per significare che consacrarsi a Dio voleva dire acquisire un'altra identità: quella di suo partner nell'alleanza.
Se partner di Dio, l'uomo non appartiene più all'ordine naturale ma interpersonale dove la metafora della lotta (come nell'espressione: «bisogna "lottare" per conquistarsi l'amore della persona amata» ) svela tutta la sua profondità: "Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché ha combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto".
Interrogarsi
- Cosa vuol dire essere benedetti da Dio?
- Perché molti personaggi biblici cambiano nome quando Dio li incontra?
- Quale è la nuova identità dell'io di fronte a Dio?
Preghiera
Chi sono Signore
al di là dei ruoli
al di là delle maschere?
Quale la mia identità
quale il mio volto?
Ma se Tu mi ami
non ha senso,
Signore,
chiedersi chi sono
e tormentarsi
di notte
per la propria immagine!
Chi sono?
Mi basta sapere
di essere amato
e che ad amarmi
sei Tu
l'Amore in persona.
Amen.
Ruminatio
Tu sei buono Signore, pieno di misericordia (Sal 86,5).
AGAR
Storia di una esclusione
"Che hai Agar? Non temere"
La storia della schiava Agar è drammatica: «Quando essa si accorse di essere incinta, la sua padrona [Sara] non contò più nulla per lei. Allora Sara disse ad Abram: "L'offesa a me fatta ricada su di te! Io ti ho dato in braccio la mia schiava, ma da quando si è accorta d'essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te!". Abram disse a Sara: "Ecco, la tua schiava è in tuo potere: falle ciò che ti pare". Sara allora la maltrattò, tanto che quella si allontanò. La trovò l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua nel deserto, la sorgente sulla strada di Sur, e le disse: "Agar, schiava di Sara, da dove vieni e dove vai?". Rispose: "Vado lontano dalla mia padrona Sara. Le disse l'angelo del Signore: "Ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa". Le disse ancora l'angelo del Signore: "Moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla per la sua moltitudine. Soggiunse poi l'angelo del Signore:
"Ecco, sei incinta:
partorirai un figlio
e lo chiamerai Ismaele,
perché il Signore ha ascoltato la sua afflizione..." » (Gn 16, 4-11).
L'angelo risana la lacerazione tra le due donne, invitando Agar a tornare dalla sua padrona, promettendole, in cambio, che a vegliare sul figlio sarebbe stato Dio stesso e suggerendole il nome da dargli, Ismaele che in ebraico significa: "Dio ascolta" (oppure: "ascolti"). Ma si tratta di una riconciliazione apparente, perché, dopo la nascita di Ismaele, il conflitto riesplode in forma più drammatica: «Il bambino crebbe e fu svezzato e Abramo fece un grande banchetto quando Ismaele fu svezzato. Ma Sara vide che il figlio di Agar l'Egiziana, quello che essa aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco. Disse allora ad Abramo: "Scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco". La cosa dispiacque molto ad Abramo per riguardo a suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: "Non ti dispiaccia questo, per il fanciullo e la sua schiava: ascolta la parola di Sara in quanto ti dice, ascolta la sua voce, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe. Ma io farò diventare una grande nazione anche il figlio della schiava, perché è tua prole". Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un otre di acqua e li diede ad Agar, caricandoli sulle sue spalle; le consegnò il fanciullo e la mandò via. Essa se ne andò e si smarrì per il deserto di Bersabea. Tutta l'acqua dell'otre era venuta a mancare. Allora essa depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte, alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: "Non voglio veder morire il fanciullo!". Quando gli si fu seduta di fronte, egli alzò la voce e pianse. Ma Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: "Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione". Dio le aprì gli occhi ed essa vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire l'otre e fece bere il fanciullo. E Dio fu con il fanciullo, che crebbe, abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco» (Gn 21, 8-20).
Interrogarsi
- Puoi provare ad immaginare la sofferenza e il disagio di una schiava come Agar?
- Quali sono oggi le situazioni di emarginazione e di esclusione che si stanno affermando o consolidando?
- Puoi ricordare nella tua vita quali sono stati quei momenti in cui ti sei sentito messo da parte ed escluso?
Preghiera
Quanta esclusione,
e quanta sofferenza
nella storia umana!
Quanti bambini,
come Ismaele,
hanno
solo la voce del pianto
e quanti uomini e donne
solo la disperazione
e il lamento
come Agar!
Fa' che sugli esclusi
e gli emarginati della terra
risuoni
ancora oggi
il tuo: "Non temere!",
Signore!
Amen.
Ruminatio
Io a te Signore grido aiuto (Sal 88, 14).
AGAR
Storia di una violenza
"Scaccia questa schiava e suo figlio"
Agar patisce una triplice violenza. La prima perché schiava. Schiava egiziana, secondo il racconto biblico, una tra le tante donate ad Abramo quando scese in Egitto con Sara della cui bellezza il faraone si invaghì. "Per riguardo a lei [Sara] egli trattò bene Abram, che ricevette greggi e armenti e asini, schiavi e schiave" (Gn 12, 16). Schiava: espropriata della propria libertà per essere a servizio di Abramo e di Sara, esecutrice non del proprio ma del loro progetto.
Su questa prima violenza, sulla quale il racconto biblico sorvola perché era naturale in quell'epoca che ci fossero schiavi e schiave, se ne innesta una seconda più insopportabile: quella di Sara che, divorata dal démone della gelosia, si trasforma in una furia vendicativa, sia nei confronti di Agar che, maltrattata, è costretta a fuggire, sia soprattutto nei confronti dello stesso bambino: «Disse allora ad Abramo: "Scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco" ». La violenza di Sara è tanto più conturbante, quanto più vuole giustificarla maldestramente, prima proiettando su Agar la ragione del suo odio ("da quando si è accorta d'essere incinta, io non conto più niente per lei") e poi rivendicando una irriducibile differenza tra il figlio della schiava e il suo: "perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco".
La terza violenza, infine, è quella dello stesso Abramo il quale, invece di prendere le difese di Agar, l'espone alla vendetta di Sara, facendosene in parte corresponsabile: «Abram disse a Sara: "Ecco, la tua schiava è in tuo potere: falle ciò che ti pare" »; come pure, invece di difendere il diritto alla vita di Ismaele, anche lui figlio suo come Isacco, cede alle pressioni di Sara, abbandonandolo in mezzo al deserto insieme alla madre: "Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un otre di acqua e li diede ad Agar, caricandoli sulle sue spalle; le consegnò il fanciullo e la mandò via". Il testo biblico in realtà si preoccupa di giustificare Abramo con una lettura teologica dell'accaduto: «Dio disse ad Abramo: "Non ti dispiaccia questo, per il fanciullo e la sua schiava: ascolta la parola di Sara in quanto ti dice, ascolta la sua voce, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe. Ma io farò diventare una grande nazione anche il figlio della schiava, perché è tua prole" ». Nonostante però questa lettura, il comportamento di Abramo resta ugualmente ingiustificabile.
Una persona che oggi si comportasse allo stesso modo susciterebbe indignazione e da lettori disincantati quali siamo ci chiediamo come sia stato possibile che un personaggio come Abramo, che Paolo definisce "il padre della fede" (cf Rm 4,11), e una donna come Sara, che sempre Paolo presenta, nella lettera agli Ebrei, come esempio da imitare (cf Eb 11, 11), si siano potuti comportare in questo modo e in che senso pertanto le loro storie, che non sono edificanti, possano essere lette ed essere d'insegnamento a noi oggi. La risposta è che la bibbia non è la storia di uomini e donne ideali bensì la storia dell'amore di Dio per gli uomini e le donne così come sono e che, incontrati da Dio, cominciano a cambiare la loro vita.
Interrogarsi
- Di quale violenza sono oggetto Agar e il bambino?
- Perché Sara chiede ad Abramo di scacciare la schiava e suo figlio?
- Ricordi qualche caso particolare in cui hai subito o causato violenza?
Preghiera
Signore
con il fuoco dell'amore
purifica il mio cuore
dai germi
di violenza
e fa' che mai
sia tentato
di umiliare il fratello
che tu
mi hai affidato
come pupilla dell'occhio
da proteggere
e amare.
Amen.
Ruminatio
Salvami, o Dio (Sal 69, 2).
AGAR
Storia di una elezione
"Ma Dio udì la voce del fanciullo"
Se la bibbia fosse un libro di storie edificanti, avrebbe poco da insegnarci. Cosa potrebbe infatti insegnare la storia di Sara se non che, nei sottosuoli della psiche umana, albergano i démoni della invidia e della gelosia? E cosa la storia di Abramo, silenzioso e succube di fronte a Sara, se non che lo spirito del quieto vivere prevale su quello della verità e del coraggio? Ma la bibbia è l'esatto contrario: non la storia edificante dell'umano, ma la storia delle sue sconfitte, delle sue viltà, dei suoi vizi e dei suoi "peccati", cioè delle sue colpe e delle sue violenze. Più che storia dell'umano realizzato, la bibbia è dispiegamento e denuncia del dis-umano che trionfa e minaccia l'umano. Ma allora perché leggere la bibbia e in che senso essa è "parola di Dio" prima che parola dell'uomo?
Nel racconto di Agar letto e commentato si cela la risposta a questa domanda: nella storia umana che è storia di peccato, cioè di violenza, Dio è dalla parte degli sconfitti, dalla parte di coloro che, schiacciati dalla "macchina" della storia in cui sventolano le bandiere e i trofei dei vincitori, vengono condannati all'emarginazione e all'oblio. La storia di Agar è la storia di una donna perdente e vinta sulla quale però veglia lo stesso Dio di Abramo che capovolge la sua storia da storia di morte in storia di vita: "Ma io farò diventare una grande nazione anche il figlio della [tua] schiava". Qui è da individuare il senso profondo della bibbia e la ragione per cui va letta ed accolta come parola di Dio: perché essa è il racconto dell'alterità divina e del suo amore che, entrando nella storia umana, ne denuncia la logica di forza e di violenza, in-quietandola e "ri-voltandola", come si rivolta un vestito dall'esterno all'interno.
Dio "in-quieta" e "ri-volta" la storia dei vincitori, mettendosi dalla parte dei vinti, ascoltandone il gemito e facendosene il garante: «Ma Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: "Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione". Dio le aprì gli occhi ed essa vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire l'otre e fece bere il fanciullo. E Dio fu con il fanciullo, che crebbe, abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco». Testo mirabile, dove Dio si rivela come il Dio della compassione e della misericordia, non diversamente da come si era prima rivelato ad Abramo e a Sara e non diversamente da come, in seguito, si rivelerà a Mosè liberando il popolo d'Israele dall'Egitto.
Nella storia di Agar, rifiutata da Sara e da Abramo ma accolta e protetta dal Dio di Abramo e di Sara, si rivela e si annuncia l'amore di un Dio singolare e universale. Amore singolare: nel senso che egli ama ognuno personalmente, nella sua realtà individuale e non in quanto appartenente ad un gruppo, ad un popolo, ad una nazione, ad una religione o ad una famiglia. E amore universale: nel senso che il suo amore si estende su tutti gratuitamente, senza distinzioni e senza preferenze tra "l'ebrea" Sara e la "schiava" egiziana, tra Isacco, il figlio della promessa, e Ismaele, il "figlio secondo la carne" (cf Gal 4, 23). Il Dio della bibbia che ama Israele è un Dio che, attraverso l'amore per Israele, rivela il suo amore per tutti. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è anche il Dio di Ismaele di cui ascolta il gemito. Dio, per la bibbia, non ha preferenze. Se non per chi, come Agar e suo figlio, è derelitto.
Interrogarsi
- Che idea ti sei fatto della bibbia e in che senso essa è parola di Dio?
- Cosa ci può insegnare la storia di Sara e la storia di Agar?
- In che senso Dio "in-quieta" e "ri-volta" la storia dei vincitori mettendosi dalla parte degli sconfitti?
Preghiera
Grazie, Signore,
perché il tuo amore
si riversa,
come il sole,
su tutti gratuitamente
e perché
non hai preferenze
se non per Agar
la schiava
e il bambino
abbandonato.
Amen.
Ruminatio
La tua bontà è grande fino ai cieli (Sal 108, 5).
GIUSEPPE
Rifiutato
"I suoi fratelli lo odiavano"
Anche Giuseppe, come Isacco, è figlio di una sterile, di Rachele, figlia di Labano, "bella di forme e avvenente di aspetto" (Gn 29, 17). Di lei Giacobbe si invaghisce perdutamente e, per averla in sposa, offre in cambio al suocero sette anni di lavoro ("che gli sembrarono pochi giorni, tanto era il suo amore per lei") e ancora altri sette quando, con inganno, fu costretto a sposare prima Lia, la sorella meno bella. Ardentemente desiderato, Giuseppe arriva quando non più atteso: «Poi Dio si ricordò anche di Rachele; Dio lo esaudì e la rese feconda. Essa concepì e partorì un figlio e disse: "Dio ha tolto il mio disonore". E lo chiamò Giuseppe dicendo: "Il Signore mi aggiunga un altro figlio" » (Gn 30, 22-24).
Ma inaspettatamente su Giuseppe si abbatte l'odio dei fratelli, perché il padre lo amava più di tutti gli altri e perché faceva sogni strani nei quali i fratelli leggevano allusioni e minacce: «Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono ancor di più. Disse dunque loro: "Ascoltate questo sogno che ho fatto. Noi stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, quand'ecco il mio covone si alzò e restò diritto e i vostri covoni vennero intorno e si prostrarono davanti al mio"» (Gn 37, 6-8). Di qui allora la decisione di ucciderlo: «Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro, complottarono di farlo morire. Si dissero l'un l'altro: "Ecco, il sognatore arriva! Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in qualche cisterna! Poi diremo: Una bestia feroce l'ha divorato! Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni"» (Gn 37, 19-20).
Il seguito della storia è noto: due dei fratelli, Ruben e Giuda, ebbero un ripensamento e quest'ultimo disse: "Che guadagno c'è ad uccidere il nostro fratello e a nasconderne il sangue? Su vendiamolo agli ismaeliti e la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne" (Gn 37, 26-27). Il consiglio fu accolto e Giuseppe fu venduto ad una carovana di madianiti che lo condussero in Egitto e lo vendettero a Potifar, consigliere del Faraone e comandante delle guardie. I suoi fratelli scannarono poi un capro, presero la sua tunica dalle lunghe maniche, la intinsero nel sangue e la fecero pervenire al padre dicendo: "L'abbiamo trovata; riscontra se è o no la tunica di tuo figlio! Una bestia feroce l'ha divorato. Giuseppe è stato sbranato" (Gn 37, 32-33). A questa notizia, Giacobbe si stracciò le vesti, si pose un cilicio attorno ai fianchi e, rifiutandosi di farsi consolare, a chi lo consolava diceva: "No, io voglio scendere in lutto dal figlio mio nella tomba" (Gn 37, 35).
Di nuovo una storia di odio e di violenza che esplode tra fratelli a causa dell'invidia e della gelosia: "Israele [cioè Giacobbe] amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica dalle lunghe maniche. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non potevano parlargli amichevolmente" (Gn 37, 3-4). Ma anche qui, entro la storia di odio e di violenza, la storia dell'amore di Dio che la trascende.
Interrogarsi
- Perché Giuseppe è odiato dai fratelli ed amato da Giacobbe più degli altri?
- Hai mai riflettuto sul potere distruttivo dell'odio e della gelosia, sentimenti che crescono soprattutto nell'ambito delle relazioni parentali?
- Hai ceduto qualche volta alla violenza di questi sentimenti?
Preghiera
Non permettere
Signore
che Odio
e Gelosia
abitino la mia casa.
Donami
ti prego
un cuore trasparente
che si rallegri
del fratello
e l'ami
con lo stesso amore
con cui tu lo ami.
Amen.
Ruminatio
A te, mia forza, io mi rivolgo ( Sal 59, 10).
GIUSEPPE
Salvato
"A lui tutto riusciva bene"
Nella storia di odio e di rifiuto di cui Giuseppe è vittima si delinea in filigrana una controstoria di Dio che lentamente la contrasta e la ribalta.
Il primo momento di questa controstoria è il successo di Giuseppe in Egitto dove "Potifar, consigliere del faraone e comandante delle guardie, un Egiziano, lo acquistò da quegli Ismaeliti che lo avevano condotto laggiù. Allora il Signore fu con Giuseppe: a lui tutto riusciva bene e rimase nella casa dell'egiziano suo padrone. Il suo padrone si accorse che il Signore era con lui e che quanto egli intraprendeva il Signore faceva riuscire nelle sue mani. Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e divenne suo servitore personale; anzi quegli lo nominò suo maggiordomo e gli diede in mano tutti i suoi averi. Da quando egli lo aveva fatto suo maggiordomo e incaricato di tutti i suoi averi, il Signore benedisse la casa dell'Egiziano per causa di Giuseppe e la benedizione del Signore fu su quanto aveva, in casa e nella campagna. Così egli lasciò tutti i suoi averi nelle mani di Giuseppe e non gli domandava conto di nulla, se non del cibo che mangiava. Ora Giuseppe era bello di forma e avvenente di aspetto" (Gn 39, 1-6).
Il secondo momento è la promozione insperata di Giuseppe a ministro del faraone, per avergli interpretato il sogno delle sette vacche belle e delle sette vacche magre, delle sette spighe belle e delle sette spighe arse, come annuncio di un periodo di abbondanza cui sarebbe seguito un periodo di terribile carestia: «Poi il faraone disse a Giuseppe: "Dal momento che Dio ti ha manifestato tutto questo, nessuno è intelligente e saggio come te. Tu stesso sarai il mio maggiordomo e ai tuoi ordini si schiererà tutto il mio popolo: solo per il trono io sarò più grande di te". Il faraone disse a Giuseppe: "Ecco io ti metto a capo di tutto il paese d'Egitto". Il faraone si tolse di mano l'anello e lo pose sulla mano di Giuseppe; lo rivestì di abiti di lino finissimo e gli pose al collo un monile d'oro. Poi lo fece montare sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava: "Abrech" [evviva!]. E così lo si stabilì su tutto il paese d'Egitto. Poi il faraone disse a Giuseppe: "Sono il faraone, ma senza il tuo permesso nessuno potrà alzare la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto". E il faraone chiamò Giuseppe Zafnat-Paneach e gli diede in moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On. Giuseppe uscì per tutto il paese d'Egitto. Giuseppe aveva trent'anni quando si presentò al faraone, re d'Egitto» (Gn 41, 39-46).
Attraverso questo racconto, il testo biblico insegna come Dio agisce nella storia umana: come signore che la guida e la in-quieta, mettendo in crisi la quiete dei vincitori e capovolgendo la sorte degli sconfitti. La storia di Giuseppe è la storia di come Dio sovverte i progetti umani sottesi dall'odio e dalla violenza vanificando la volontà di morte dei loro artefici e restituendo la vita alle vittime. È la storia di come Dio si prende gioco, ieri come oggi, dei malvagi e dei potenti impedendo che l'ultima parola dell'umano sia quella dell'ingiustizia e della violenza.
Interrogarsi
- Per la bibbia, come agisce Dio nella storia ?
- Cosa insegna il racconto biblico di Giuseppe elevato a ministro del faraone?
- Qual è la controstoria che Dio scrive dentro le nostre storie?
Preghiera
Il forte
che schiaccia il debole,
il furbo
che inganna il semplice,
il ricco
che affama il povero,
l'uomo
che domina l'uomo:
è questa, Signore,
la storia.
Ma tu,
Signore,
sei dentro la storia
e le nostre storie
e dal di dentro
le capovolgi
trasformi
e rinnovi.
Amen.
Ruminatio
Benedetto il Signore, Dio d'Israele (Sal 106, 48).
GIUSEPPE
Salvatore
"Dio mi ha mandato qui”
Dio capovolge la storia di Giuseppe non solo sottraendolo alla morte e restituendogli la vita, ma costituendolo salvatore dei suoi stessi fratelli che ne volevano la fine.
Per una grande carestia, infatti, i figli d'Israele scesero in Egitto per cercarvi frumento e, per l’occasione, si incontrarono con Giuseppe che li riconobbe: «Diede in un grido di pianto e tutti gli Egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa del faraone. Giuseppe disse ai fratelli: "Io sono Giuseppe! Vive ancora mio padre?". Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli, perché atterriti dalla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai fratelli: "Avvicinatevi a me!". Si avvicinarono e disse loro: "Io sono Giuseppe, il vostro fratello, che voi avete venduto per l'Egitto. Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto quaggiù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Perché già da due anni vi è la carestia nel paese e ancora per cinque anni non vi sarà né aratura né mietitura. Dio mi ha mandato qui prima di voi, per assicurare a voi la sopravvivenza nel paese e per salvare in voi la vita di molta gente. Dunque non siete stati voi a mandarmi qui ma Dio ed Egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore su tutta la sua casa e governatore su tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi a salire da mio padre e ditegli: Dice il tuo figlio Giuseppe: Dio mi ha stabilito Signore di tutto l'Egitto. Vieni quaggiù, presso di me, e non tardare» (Gn 45, 2-9).
Facendosi riconoscere dai fratelli, Giuseppe lungi dall'accusarli li "giustifica", leggendo nel loro gesto di esclusione il disegno divino che li trascende: "Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto quaggiù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi". A monte della decisione dei fratelli di venderlo ad un mercante in Egitto, Giuseppe riconosce la decisione di Dio, per cui può concludere: "Dunque non siete stati voi a mandarmi qui ma Dio". E, ironia della sorte, la ragione di questa decisione è di destinare Giuseppe ad essere il salvatore proprio di quei fratelli che volevano la sua morte: "Dio mi ha mandato qui prima di voi, per assicurare a voi la sopravvivenza nel paese e per salvare in voi la vita di molta gente".
Ciò che questo racconto svela è che Dio è "dietro" e "dentro" la storia e le nostre storie e che egli si "serve" del male "a fin di bene", non soccombendo al male ma vincendolo: non nel senso che egli progetti il male, decidendo per l'uomo e deresponsabilizzandolo, ma nel senso che, con la sua potenza d'amore, egli è in grado di "convertire" e di "correggere" le decisioni malvage degli uomini in occasioni di bene. Dio è Dio, per la bibbia, perché capace di insinuarsi, come un ladro di notte, nei progetti umani, svelandone l'inconsistenza e la fallacia e riconvertendoli alla giustizia e al bene.
Interrogarsi
- In che senso Giuseppe è più che salvato?
- Come intendere la frase di Giuseppe che è stato Dio a mandarlo in Egitto e non i fratelli?
- Come interpretare l'espressione: "Dio si serve del male a fin di bene"?
Preghiera
Studio la storia
ascolto la TV
parlo con la gente
apro il giornale:
Signore,
più che il bene
mi colpisce il male,
più che l'amore
l'indifferenza
e l'odio.
Ma il tuo Amore
Signore
è più forte dell'indifferenza,
più forte dell'odio.
Signore
che io creda in te
e nella potenza del tuo Amore
che mi chiama ad amare.
Amen.
Ruminatio
Signore, qui c'è la tua mano (Sal 109, 27).
MOSÉ
La rivelazione
"Il Signore gli parlava faccia a faccia"
Tra le figure bibliche delle scritture ebraiche, nessuna ha l'altezza di Mosè, la cui morte il libro del Deuteronomio così celebra: "Non è sorto in Israele un profeta come Mosè - lui con il quale il Signore parlava faccia a faccia - per tutti i segni e i prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nel paese d'Egitto, contro il faraone, contro i suoi ministri e contro tutto il suo paese, e per la mano potente e il terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele" (Dt 34, 10-12).
La ragione dell'altezza di Mosè, il "fondatore" vero e proprio dell'ebraismo, è che Dio gli si è rivelato, parlando con lui "faccia a faccia", cioè intimamente, come avviene tra due amici o innamorati. La grandezza di Mosè non è pertanto in ciò che lui ha fatto quanto in ciò che gli è stato fatto: Dio che lo chiama e gli parla, confidandogli i suoi "progetti" sulla storia di Israele e dell’umanità.
«Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: "Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?". Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: "Mosè, Mosè!". Rispose: "eccomi!". Riprese: "Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa!". E disse: "Io sono il Dio di tuo Padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe". Mosè allora si velò il viso, perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: "Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido... Il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto l'oppressione con cui gli egiziani li tormentano. Ora va'! Io ti mando dal faraone. Fa' uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!"» (Es 3, 1-11).
Sono tanti gli elementi che, in questo racconto colpiscono: Mosè che pascola il gregge nel deserto (per essere incontrati da Dio non si richiedono luoghi o professioni particolari. Dio ci viene incontro dovunque siamo e qualsiasi cosa facciamo!); l'angelo del Signore che appare in fiamme di fuoco in mezzo ad un roveto per dire, con il linguaggio metaforico, che Dio, quando viene incontro all'uomo, sfugge alla sua presa e al suo possesso; il dialogo breve ed essenziale dove Dio si definisce come colui che chiama per nome ("Mosè, Mosè") mentre Mosè come colui che risponde immediatamente ("Eccomi").
Ma il cuore del racconto è la rivelazione di Dio come compassione ("Il grido degli Israeliti è arrivato fino a me") e la missione di Mosè ("Ora va'") della quale Dio ha bisogno perché la sua compassione diventi efficace storicamente.
La storia umana - la tua storia come pure la storia di ogni ragazzo e ragazza - è incrociata dalla storia di Dio che è storia di compassione che si prende a cuore la sofferenza umana e associa ciascuno di noi in questa storia di liberazione e di amore.
Interrogarsi
- Hai mai pensato al ruolo unico di Mosè nella storia biblica e nella tradizione ebraico-cristiana?
- In cosa consiste la rivelazione di Dio a Mosè?
- Qual è il significato della "missione" di Mosè? Perché Dio associa a sé Mosè nel suo progetto di compassione e di liberazione?
Preghiera
Signore
era un giorno tra i tanti
quando Mosè,
pascolando il gregge
nel deserto
fu sorpreso dalla tua voce
con cui ti rivelavi
come Dio
della compassione
e della tenerezza.
Fa' Signore
che ancora oggi
io possa ascoltare la tua rivelazione
e, come Mosè,
risponderti
con il mio: "Eccomi".
Amen.
Ruminatio
Il Signore rialza chiunque è caduto" (Sal 145, 14).
MOSÉ
Il monte Sinai
"Se volete ascoltare la mia voce..."
La liberazione di Israele dall'Egitto è finalizzata all'ingresso nella terra promessa, dove scorrono "latte e miele", una metafora per dire la pienezza dei beni e la felicità per tutti. Ma la via che introduce in questa terra non è lineare perché passa per il monte Sinai dove Dio consegna a Mosè la "legge" ed è attraverso questa che il popolo entrerà nella terra promessa: «Al terzo mese dall'uscita degli Israeliti dal paese di Egitto, proprio in quel giorno, essi arrivarono al deserto del Sinai... Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: "Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli Israeliti"» (Es 19, 1-6).
In cosa consistono questa "voce" e questa "alleanza" che fanno d'Israele un popolo particolare, cioè "un regno di sacerdoti" e una "nazione santa"? La risposta a questa domanda è sorprendente: innanzitutto perché ciò che Dio propone ad Israele è una serie di comandamenti riassunti nel cosiddetto "decalogo" o "dieci parole", secondo l'etimo del termine; poi perché il contenuto di questi comandamenti riguarda soprattutto il comportamento dell'uomo nei confronti dell'altro uomo piuttosto che il comportamento dell'uomo nei confronti di Dio. Ciò che Dio chiede ad Israele è di amare l'altro allo stesso modo con cui egli lo ha amato in Egitto quando si chinò gratuitamente sulla sua sofferenza: "Voi stessi avete visto ciò che ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me". Ciò che Dio dà ad Israele sul Sinai è la "legge" o il "comandamento" dell'amore.
Ma non è un controsenso parlare di "legge" o "comandamento" dell'amore? Non è l'amore un sentimento spontaneo che è contraddittorio comandare? La bibbia afferma e così svela che l'amore vero, quello che ama l'altro in quanto altro, non in quanto desiderabile che appaga bensì in quanto alterità che mette in crisi l'io e lo spodesta, può essere solo comandato, e che l'amore naturale o spontaneo che si istituisce al di fuori del comandamento è un amore che si rivolge al proprio io, dove l'altro è amato non come fine in sé bensì come momento interno al suo autorealizzarsi.
Il Dio che sul Sinai si rivela come "legislatore dell'amore" è il Dio che, attraverso la forza del comandamento, interrompe il movimento naturale dell'io verso l'io e lo genera all'altezza dell'amore verso l'altro: miracolo della bontà o santità che è il senso stesso del rivelarsi di Dio all'uomo.
Interrogarsi
- Qual è il rapporto tra l'uscita dall'Egitto e il Sinai?
- In cosa consiste l'evento del Sinai e in che senso il Dio biblico è il Dio "legislatore"?
- Qual è il senso della "legge" o del "comandamento" dell'amore e qual è la differenza tra l'amore per sé e l'amore per l'altro?
Preghiera
Che strano
Signore
sentire
che tu ci comandi di amare
e che la legge
da te rivelata
è la rivelazione
dell'amore come legge.
Ma forse Signore
è vero:
in ogni amore
amo solo me stesso
e se non ci fosse il tuo comandamento
sarei solo
prigioniero dell’io.
Grazie Signore
che mi comandi di amare
e rendimi capace
di amare
come tu ami.
Amen.
Ruminatio
Fammi grazia della tua legge (Sal 119, 29).
MOSÉ
La terra promessa
"Paese dove non ti mancherà nulla"
Dio si rivela ad Israele e gli consegna la legge dell'amore per introdurlo in un paese dove non gli manchi nulla: "Il Signore tuo Dio sta per farti entrare in un paese fertile: paese di torrenti, di fonti e di acque sotterranee che scaturiscono nella pianura e sulla montagna; paese di frumento, di orzo, di viti, di fichi e di melograni; paese di ulivi, di olio e di miele; paese dove non mangerai con scarsità il pane, dove non ti mancherà nulla; paese dove le pietre sono ferro e dai cui monti scaverai il rame. Mangerai dunque a sazietà e benedirai il Signore tuo Dio a causa del paese fertile che ti avrà dato" (Dt 8, 7-11). Dio parla ad Israele quindi non per rivelargli chissà quali misteri o verità nascoste ma per svelargli che il suo essere nel mondo è un essere destinato alla felicità: una felicità personale, che riguarda l'io nella sua irriducibile singolarità, perché solo un "io" può essere felice e non il corpo sociale o il collettivo; una felicità universale, che oltre all’io coinvolge e riguarda ogni altro, perché fino a quando, sia pure su un solo volto, resta una lacrima da asciugare, nessuno può essere felice fino in fondo; una felicità terrestre, che non si colloca fuori del tempo e dello spazio ma fiorisce in ogni pezzo di mondo o angolo dove ad ogni io è dato abitare.
Ma più che promessa della felicità piena, descritta con le immagini della terra ricca di acque e di alberi (immagini legate ad una società agricola che conservano il loro fascino anche per noi figli della tecnologia!), Dio sul monte Sinai è soprattutto, per Israele, la Volontà rivelatrice e istitutrice delle condizioni da cui essa fiorisce: "Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, quando avrai costruito belle case e vi avrai abitato, quando avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento e il tuo oro, e abbondare ogni tua cosa, il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile; che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso...; che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima; che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta... Guardati dunque dal pensare: La mia forza e la potenza della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze. Ricordati invece del Signore tuo Dio perché egli ti dà la forza per acquistare ricchezze, al fine di mantenere, come fa oggi, l'alleanza che ha giurato ai tuoi padri. Ma se tu dimenticherai il Signore tuo Dio... io attesto oggi contro di voi che certo perirete!" (Dt 8, 12-18).
La felicità alla quale Dio ci destina è condizionale: una felicità che non si realizza naturalmente, in forza di un principio dal quale si è sospinti, bensì soggettivamente, in forza di una decisione che appartiene all'ordine della responsabilità singolare e irriducibile. La felicità è il miracolo che ac-cade quando, oltre il mondo in cui e di cui si vive, l'io intra-vede e riflette il di più che in esso si cela e da esso ci appella: il "di più" dell'amore personale di Dio che mentre tutto dona gratuitamente, chiama a ridonare tutto allo stesso modo.
Interrogarsi
- Qual è il rapporto tra il Sinai e la terra promessa?
- Perché la bibbia descrive con le immagini di una terra ricca di acque e di alberi la meta alla quale vuole condurre l'umanità?
- Dov'è la differenza tra la felicità naturale da una parte e la felicità promessa da Dio sul Sinai dall'altra?
Preghiera
Signore,
hai voluto per noi una terra
bella come un giardino
e accogliente come una casa,
dove ci fosse per tutti
abbondanza
di beni e di gioia.
Ma il nostro sguardo,
si è fatto sordo
duro ed opaco,
incapace
di ascoltare
il sole,
le stelle,
i fiumi e le piante.
Apri, Signore, i nostri occhi
perché,
oltre la bellezza del mondo,
scorgiamo la tua bontà.
Amen.
Ruminatio
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore (Sal 138, 1).
DAVIDE
L'elezione
"Io non guardo ciò che guarda l'uomo"
Davide è ricordato nella tradizione ebraica come re esemplare perché "secondo il cuore di Dio" (cf At 13, 22; 1 Sam 13, 14) e come colui dalla cui stirpe nascerà il messia, secondo la testimonianza del primo evangelista quando nella genealogia si riferisce a Gesù Cristo come "figlio di Davide" (Mt 1,1).
Succeduto a Saul, il primo re d'Israele scelto da Samuele e segnato dalla follia e dalla morte suicida, così il testo biblico presenta l'elezione di Davide: «Il Signore disse a Samuele: "Ti ordino di andare da Iesse il Betlemmita, perché tra i suoi figli mi sono scelto un re"... Quando furono entrati egli osservò Eliab e chiese: "E' forse davanti al Signore il suo consacrato?". Il Signore rispose a Samuele: "Non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura. Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore". Iesse fece allora venire Abìnadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse: "Nemmeno su costui cade la scelta del Signore". Iesse fece passare Samma e quegli disse: "Nemmeno su costui cade la scelta del Signore". Iesse presentò a Samuele i suoi sette figli e Samuele ripeté a Iesse: "Il Signore non ha scelto nessuno di questi". Samuele chiese a Iesse: "Sono qui tutti i giovani?". Rispose Iesse: "Rimane ancora il più piccolo che ora sta a pascolare il gregge". Samuele ordinò a Iesse: "Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui". Quegli mandò a chiamarlo e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e gentile di aspetto. Disse il Signore: "Alzati e ungilo: è lui!". Samuele prese il corno dell'olio e lo consacrò con l'unzione in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno in poi» (1 Sam 16, 1-13).
È Dio che sceglie Davide, il più piccolo, indifeso e inesperto. Un Dio "strano", che agisce in un modo che contrasta con il comune agire umano. Quando noi agiamo e scegliamo siamo mossi, cioè spinti e attratti, dal valore che cogliamo riflesso nell'altro: la sua virtù, la sua forza, il suo coraggio, la sua intelligenza, la sua maestria o la sua saggezza. Non così Dio che rivela a Samuele il segreto del suo agire: "Non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura. Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore".
Ciò che per Dio conta non è ciò che appare e, apparendo, si offre allo sguardo e al giudizio altrui: così inteso ciò che appare è apparenza nel senso di illusione e di inganno. Ciò che per Dio conta è l'altro in quanto altro, nella sua nuda alterità sulla quale veglia il suo amore. Ciò che il racconto biblico insegna attraverso l'elezione di Davide "il più piccolo" non è che Dio abbia delle preferenze, escludendo alcuni ed accogliendo altri, bensì che egli è libertà d'amore che si china gratuitamente su ognuno.
Interrogarsi
- Perché nella tradizione ebraica e nella tradizione cristiana è così importante la figura di Davide?
- Come va inteso il racconto biblico per il quale Dio preferisce ai fratelli Davide il più piccolo?
- Cosa vuol dire che Dio non guarda l'apparenza ma il cuore?
Preghiera
Ho tanta paura
Signore
di essere
osservato
guardato
giudicato.
A volte
neppure mi accetto
e quando mi guardo allo specchio
sono tentato
di rifiutarmi.
Ma tu, Signore,
mi accetti
e mi ami
per quello che sono.
Grazie Signore!
Dammi la gioia
di sentirmi amato.
Amen.
Ruminatio
Ti sono note tutte le mie vie (Sal 139, 3).
DAVIDE
La regalità
"Tu pascerai Israele mio popolo"
Secondo il libro di Samuele Davide fu incoronato re ad Ebron dove si recarono tutte le tribù d'Israele: « "Ecco noi ci consideriamo come tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: Tu pascerai Israele mio popolo, tu sarai capo in Israele"... Davide aveva trent'anni quando fu fatto re e regnò quarant'anni» (2 Sam 5, 1-4).
Davide re d'Israele, ma re paradossale perché Israele, per la bibbia, non ha né può avere altro re che non sia Dio: "Voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa" (Es 19, 5-6). E' questa la ragione per la quale, quando le tribù di Israele chiesero a Samuele un re ("Ora stabilisci per noi un re che ci governi, come avviene per tutti i popoli": 1 Sam 8, 5) la prima reazione fu negativa: «Agli occhi di Samuele era cattiva la proposta perché avevano detto: "Dacci un re che ci governi"» (1 Sam 8, 6). E fu solo in un secondo momento che, quasi andando incontro alla debolezza del suo popolo, Dio acconsente alla richiesta di un re: «Rispose il Signore a Samuele: "Ascoltali; che regni pure un re su di loro"» (2 Sam 8, 22).
Questa contestazione nei confronti della istituzione monarchica sta a significare una cosa importante: il timore che la nuova figura regale offuscasse il monoteismo biblico, riducendo l'originalità del Dio rivelatore e redentore che con mano forte e braccio disteso liberò Israele dall'Egitto per farne il popolo sul quale regnare. Quando, nonostante la contestazione iniziale, Israele accettò l'istituzione monarchica, ciò avvenne ad una condizione precisa di cui la coscienza profetica si farà interprete esigente: che essa fosse l'incarnazione e il riflesso dell'agire di Dio nei confronti degli ultimi, dei poveri e degli oppressi e dove questa istanza di giustizia fosse stata tradita, essa sarebbe rimasta sottoposta al giudizio e alla condanna da parte di Dio. La ragione per la quale l'esperienza monarchica fallirà definitivamente con la caduta del tempio di Gerusalemme nel 586 a.C., dalla coscienza matura d'Israele è attribuita al "peccato" dei suoi re, alla discrepanza abissale tra il loro agire e quello divino che essi, invece di riflettere, hanno tradito. La grandezza di Davide è di essere stato il re esemplare la cui regalità fu esercitata in conformità al volere divino, secondo la testimonianza stessa di Dio nel libro degli Atti: "Ho trovato Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore; egli adempirà tutti i miei voleri" (At 13, 22).
Di fronte a Dio il senso del "potere", di cui la regalità è la figura principale, è di essere a servizio dell'alterità dell'altro: non il potere dell'io-per-l'io bensì il potere dell'io-per-l'altro. E' conforme al "cuore" di Dio e al suo volere quel "potere" il cui fine non è l'io bensì l'altro. Ogni "potere", a partire da quella accezione originaria con cui io dico a me stesso e all'altro: "posso" parlare, "posso" camminare. Per la bibbia il senso ultimo del "potere" di parlare e del "potere" di camminare non è da ricercare nell'io ma nell'altro: l'altro a cui rivolgo la parola o l'altro verso cui mi dirigo per sfamarlo o accarezzarlo.
Interrogarsi
- Qual è il senso della regalità nella bibbia?
- Perché l'introduzione del modello monarchico inizialmente fu contestata?
- Cosa vuol dire che il potere non deve essere per-l'io ma per-l'altro?
Preghiera
So bene, Signore,
che nel mondo in cui vivo
sono sempre di meno
coloro che hanno
corone, nomi
e ruoli di re.
So bene, Signore,
che solo tu
sei re:
ma non per dominare
bensì per amare,
non per farti servire
bensì per servire.
Fa' che quando abbiamo potere
- compreso il mio io
nel suo potere
di parlare o camminare -
non dimentichiamo mai
di mettere al primo posto
il volto
e il bisogno dell'altro.
Amen.
Ruminatio
Dio, da' al re il tuo giudizio (Sal 72, 1).
DAVIDE
Il pentimento
"Pietà di me o Dio"
Un giorno il Signore mandò il profeta Natan da Davide per raccontargli una storia: "Vi erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero; ma il povero non aveva nulla, se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprata e allevata; essa gli era cresciuta in casa insieme con i figli, mangiando il pane di lui, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno; era per lui come una figlia. Un ospite di passaggio arrivò dall'uomo ricco e questi, risparmiando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso, per preparare una vivanda al viaggiatore che era capitato da lui, portò via la pecora di quell'uomo povero e ne preparò una vivanda per l'ospite venuto da lui" (2 Sam 12, 1-4). A questo racconto segue la reazione di Davide: "Per la vita del Signore, chi ha fatto questo merita la morte. Pagherà quattro volte il valore della pecora, per aver fatto una tale cosa e non aver avuto pietà" (2 Sam 12, 5-6).
Ed ecco il colpo di scena quando Natan apostrofa David con queste parole: "Tu sei quell'uomo! Così dice il Signore, Dio d'Israele: Io ti ho unto re d'Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e, se questo fosse stato troppo poco, io vi avrei aggiunto anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'Hittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti" (2 Sam 12, 7-9).
Davide, anche se grande re e paradigma di una regalità gradita a Dio, si macchia della duplice colpa dell'omicidio di Uria e dell'adulterio con la moglie Betsabea. Grande re quindi, ma anche grande peccatore. Il peccato - il negarsi a Dio per consegnarsi alla voluttà del proprio io che, pur di appagarsi, è pronto a farsi omicida - non risparmia nessuno, neppure Davide. Come un'infezione, come una peste, esso minaccia ogni membro del corpo sociale: giovani e vecchi, ricchi e poveri, colti e incolti, potenti e derelitti, furbi e stupidi. Nessuno ne è immune per nascita o fortuna. Tutti possono restarne infetti e rovinarsi.
Oltre che grande peccatore, Davide però è anche grande penitente: colui che di fronte a Natan che smaschera la sua colpa, non accusa né si giustifica ma chiede perdono e la riconosce umilmente: «Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; nella tua grande bontà cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto...". E' l'inizio del celebre salmo 51, il salmo con cui attraverso i secoli la tradizione ebraico-cristiana ha manifestato di fronte a Dio la coscienza della colpa e la richiesta di perdono. A questo salmo anche tu puoi ricorrere quando ti senti oppresso dal peccato e dal rimorso. Dio è capace di creare anche in te un cuore puro e rinnovare nel profondo la tua soggettività: "Purificami con issopo e sarò mondo, lavami e sarò più bianco della neve".
Interrogarsi
- Cosa ti colpisce di più nella parabola di Natan a Davide?
- In cosa consiste la grandezza di Davide come penitente?
- Perché è così difficile riconoscere la propria colpa quando si commette un' offesa nei confronti di Dio e dei fratelli?
Preghiera
Sono sorpreso
e mi chiedo
come sia stato possibile
che Davide,
l’uomo secondo il tuo cuore,
si sia macchiato
di colpe così gravi.
Ma la grandezza dell'uomo,
Signore,
non è nell'innocenza
ma nel riconoscimento della colpa
e nella volontà di pentirsi.
Ti prego,
Signore,
quando pecco
aiutami
a non farmi schiacciare
dalla colpa
e dal rimorso
e fammi la grazia
di ricominciare
ogni volta daccapo.
Amen.
Ruminatio
Lavami e sarò più bianco della neve (Sal 51, 9).
SALOMONE
La saggezza
"Concedi al tuo servo un cuore docile"
Figlio di Betsabea e di Davide, Salomone è ricordato nella tradizione biblica come il re per eccellenza ripieno di saggezza divina da lui richiesta:
"Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male" (1 Re 3,9). Al Signore piacque la preghiera di Salomone al quale risponde: "Perché hai comandato questa cosa e non hai domandato per te né una lunga vita, né la ricchezza, né la morte dei tuoi nemici ma hai domandato per te di amministrare la giustizia, ecco faccio come tu hai detto. Ecco, ti concedo un cuore saggio e intelligente: come te non ci fu alcuno prima di te né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come nessun re ebbe mai" (1 Re 3, 11-13).
La saggezza di cui Salomone è la figura esemplare è quella forma di sapere che non inerisce all'intelligenza bensì al cuore ("concedi al tuo servo un cuore docile") e la cui finalità o senso non riguarda l'ordine della conoscenza bensì l'ordine della giustizia ("perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male").
Il "cuore", per la bibbia, è lo spazio della relazione dove l'io si apre all'altro non per prenderlo e comprenderlo bensì per accoglierlo e servirlo, come la madre che, nel suo grembo, accoglie la vita e si consacra al mistero del suo sviluppo e della sua nascita. Il "cuore docile", che Salomone chiede al Signore all'inizio dell'esercizio della sua regalità, è il cuore "giusto" e "buono" che non domanda per sé ("Non hai domandato per te né una lunga vita, né la ricchezza, né la morte dei tuoi nemici") ma domanda per l'altro e la cui occupazione non è il desiderio dell'io da realizzare bensì il bisogno dell'altro da ascoltare: "hai domandato per te di amministrare la giustizia". Il testo originale ebraico suona letteralmente: "hai domandato per te l'intelligenza per ascoltare il diritto". La saggezza, quella che colora la vita in ogni suo istante, nel ritmo dei suoi giorni e delle sue notti, fiorisce e si diffonde come aroma quando l'io si mette in ascolto del "diritto" che, per la bibbia, coincide con quello del povero, dell'orfano e della vedova, cioè quando l'io rinuncia ai suoi diritti e alle sue pretese e, come Dio, si china sull'altro e ne accoglie l'appello.
Chiedere al Signore un "cuore docile", come fa Salomone, è credere che la cosa più importante della vita non è ampliare e realizzare lo spazio dell'io desiderante ma metterlo in crisi e convertirlo in amore e responsabilità per l'altro. Nella logica divina il desiderio non è un negativo da cancellare ma un di più che fiorisce sul principio bontà o giustizia: "Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria".
Interrogarsi
- Perché Salomone è la figura esemplare della "saggezza" o della "sapienza"?
- In cosa consiste il "cuore docile" che Salomone invoca da Dio?
- Dove cogliere la differenza tra il "sapere" del cuore e il "sapere" della ragione?
Preghiera
Cerco
sogno
desidero
voglio.
E ogni giorno
Signore
il mio volere
sempre più
vuole.
Ma al mio cuore
tutto questo
non basta
e resta
sempre
più vuoto.
Ti prego
Signore
concedimi
un cuore
intelligente
e saggio
che sappia riconoscere
il volto dell'altro.
Amen.
Ruminatio
Il Signore è con me (Sal 118,7)
SALOMONE
Il tempio
"Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra?"
Oltre che per la sua saggezza, Salomone è ricordato come il costruttore del tempio di Gerusalemme, colui che edificò una "casa" per Dio: «Salomone mandò a dire a Chiram: "Tu sai che Davide mio padre non ha potuto edificare un tempio al nome del Signore suo Dio, a causa delle guerre che i nemici gli mossero da tutte le parti... Ora il Signore mio Dio mi ha dato pace da ogni parte e non ho né avversari né particolari difficoltà. Ecco, ho deciso di edificare un tempio al nome del Signore mio Dio, come ha detto il Signore a Davide mio padre: Tuo figlio, che io porrò al tuo posto sul tuo trono, edificherà un tempio al mio nome" » (1 Re 17-19).
Il tempio di Gerusalemme edificato da Salomone rappresenta uno dei momenti più alti della storia biblica, essendo il simbolo del luogo dove Dio abita e incontra il suo popolo.
Ma dov'è che Dio abita e incontra realmente me, te, ogni uomo e ogni donna che si trovano in ogni angolo del mondo? Inaugurando il tempio appena fatto edificare, con una preghiera considerata una delle più belle della bibbia, Salomone così si rivolge a Dio: "Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto ameno questa casa che ti ho costruita! Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio; ascolta il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te! Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto: Lì sarà il mio nome! Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo" (1 Re 8, 27-29).
Dio non abita né può abitare in nessun tempio e in nessuna casa perché nulla di ciò che esiste può contenerlo: se non i cieli e i cieli dei cieli, che sono illimitati, tanto meno un edificio costruito sulla terra. Ma in che senso allora il tempio è "la casa di Dio" e il luogo in cui egli pone il "suo nome" ("Il luogo di cui hai detto: Lì sarà il mio nome"), cioè il suo essere Amore e Compagnia dell'uomo?
Più che il luogo dove Dio abita e pone il suo Nome, il tempio, per la bibbia, è il segno del luogo dove egli abita e pone il suo Nome. Il luogo vero dove Dio abita, dove mi rivela il suo amore e mi incontra, è lì dove ognuno di noi vive: gioiendo e amando, soffrendo e sperando, sognando e lottando. E' qui, nel cuore dell'esistenza e delle relazioni che la intessono, che Dio ti viene incontro amandoti e chiamandoti. Tutti i cosiddetti luoghi sacri - templi, pagode, chiese, moschee, sinagoghe, basiliche o cappelle - che in ogni tempo e sotto ogni cielo sono stati innalzati e gelosamente adornati sono parole di pietra che nella storia hanno detto e continuano a dire una sola cosa: che l'uomo sulla terra non è solo perché c'è Dio che gli viene incontro in ogni istante per essergli Compagno di viaggio.
Interrogarsi
- Perché fu Salomone e non Davide a costruire a Gerusalemme il tempio a Dio?
- In che senso il tempio è il luogo dove Dio pone il suo Nome?
- Quando pensi alla parola "tempio" oppure "chiesa" quali sono le prime cose che ti vengono in mente?
Preghiera
Non c'è
città
paese
villaggio
il più sperduto
il più dimenticato
dove un campanile
un minareto
una guglia
non ricordi
Signore
la tua presenza.
Anche se io
neppure me ne accorgo
oppure resto
infastidito
o indifferente.
Tu, Signore,
con questo linguaggio
gridi al mondo
che nessuno è solo
e che sei il Compagno
dell'uomo
in ogni suo giorno
e in ogni sua notte.
Amen.
Ruminatio
Proteggi il mio capo nel giorno della lotta (Sal 140, 8).
SALOMONE
Il Cantico dei Cantici
"Le tue tenerezze sono più dolci del vino"
Oltre che sapiente e costruttore del tempio di Gerusalemme, Salomone è ricordato come grande poeta e cantore, per eccellenza, del dialogo tra Dio e il suo popolo. Anche se storicamente infondata, la tradizione biblica gli attribuisce quattro grandi opere: Qoelet, Proverbi, la Sapienza e il Cantico dei Cantici.
Tra i libri della bibbia, il Cantico dei Cantici (così chiamato perché ritenuto il poema per eccellenza, il più bello tra tutti) è il più paradossale perché non fa mai riferimento a Dio e soprattutto perché usa un linguaggio d'amore così passionale che fino al primo secolo dell'era cristiana la sua appartenenza al canone biblico era ritenuta problematica. Composto di otto brevi capitoli, il poemetto canta l'amore tra un uomo e una donna, tra un "lui" e un "lei" che si desiderano e cercano, nascondono e rincorrono in un gioco di attese e di sguardi teneri e sfuggenti intrecciato di parole poetiche e sensuali. L'amata, chiamata "la sulammita" (Ct 7, 1), parla tra sé e sé rivolgendosi al suo amato di nome Salomone (per questo secondo alcuni etimologicamente "sulammita" può significare "colei che appartiene a Salomone") e vagheggiandolo come re:
«Che lui mi baci con i baci della sua bocca!
Sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino.
Per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi,
profumo olezzante è il tuo nome,
per questo le giovinette ti amano.
Attiriamo dietro a te, corriamo!
M'introduca il re nelle sue stanze:
gioiremo e ci rallegreremo per te,
ricorderemo le tue tenerezze più del vino.
A ragione ti amano!» (Ct 1, 2-4).
er quale ragione un canto così profano e passionale, dove non si parla dell'amore di Dio e neppure dell'amore per Dio ma dell'amore tenero e violento tra l'amata e il suo amante è entrato a far parte del canone biblico ed è e deve essere ritenuto ispirato? "Se ti sei innamorato una volta, sai ormai distinguere la vita da ciò che è supporto biologico e sentimentalismo, sai ormai distinguere la vita dalla sopravvivenza. Sai che la sopravvivenza significa vita senza senso e sensibilità, una morte strisciante: mangi il pane e non ti tiene in piedi, bevi acqua e non ti disseti, tocchi le cose e non le senti al tatto, annusi il fiore, e il suo profumo non arriva alla tua anima. Se però l'amato è accanto a te, tutto improvvisamente risorge e la vita ti inonda con tale forza che ritieni il vaso di argilla della tua esistenza incapace a sostenerla. Tale piena della vita è l'Eros. Non parlo di sentimentalismi e di slanci mistici, ma della vita che solo allora diventa reale e tangibile, come se fossero cadute squame dei tuoi occhi e tutto, attorno a te, si manifestasse per la prima volta, ogni suono venisse udito per la prima volta, e il tutto fremesse di gioia alla prima percezione delle cose. Tale eros non è privilegio né dei virtuosi né dei saggi, è offerto a tutti, con pari possibilità. Ed è la sola pregustazione del Regno, il solo reale superamento della morte. Perché solo se esci dal tuo io, sia pure per gli occhi belli di una zingara, sai cosa domandi a Dio e perché corri dietro a lui" (Christos Yannaras).
Interrogarsi
- Conosci il Cantico dei Cantici e la sua trama poetica e narrativa?
- Perché il Cantico dei Cantici è entrato con difficoltà a far parte del canone biblico e suscita ancora oggi meraviglia?
- In che senso l'eros fa uscire l'io da se stesso e diventa pregustazione del regno?
Preghiera
Se non sento
la sua voce
se non vedo
il suo volto
i mio cuore
Signore
si fa triste
e buio
come quando nel cielo
si spengono le stelle.
È bello
sapersi amati,
guardarsi negli occhi
e sentirsi
liberi
e forti
come la roccia.
Grazie,
Signore
perché esiste
l'amore
e in ogni amore
ci sei Tu
l'Amore.
Amen.
Ruminatio
La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente (Sal 42, 3).
ELIA
La profezia
"La sua parola bruciava come fiaccola"
Nel libro del Siracide la figura di Elia viene così scolpita: "Allora sorse Elia profeta, simile al fuoco; la sua parola bruciava come fiaccola" (Sir 48, 1). Elia è il primo profeta nella storia d'Israele, il capostipite di una lunga serie di personaggi unici e irripetibili tra i quali, per le opere sistematiche con cui sono stati tramandati, i più noti sono Amos, Isaia, Michea, Sofonia, Geremia, Ezechiele e Daniele.
Cosa vuol dire "profeta" e in che senso la parola che Elia pronuncia è "simile al fuoco" o alla "fiaccola" che brucia? Per molti il profeta è sinonimo di "indovino", nel senso di chi prevede il futuro, oppure di messaggero di cattive notizie, nel senso di chi annuncia disgrazie e sciagure, oppure infine di contestatore dell'ordine costituito, nel senso di chi non accetta il già dato ma vuole e lotta per il cambiamento della società. Quest'ultima accezione è quella più comune, come ad esempio in espressioni come queste: "Giovanni XXIII è stato un uomo profetico" o "la chiesa ha pochi profeti". Con la prima espressione si intende che papa Giovanni XXIII, con l'idea di indire un concilio (la convocazione a Roma di tutti i vescovi del mondo per consultarli e lasciarli parlare liberamente), mise in moto nella chiesa un processo di cambiamento profondo; con la seconda che, nella chiesa di oggi, ci sarebbe bisogno di uomini coraggiosi, capaci di guardare con fiducia al futuro piuttosto che arroccarsi nella difesa del passato.
Per la bibbia il termine "profeta" ha però un altro significato: né colui che prevede il futuro, né colui che annuncia cattive sventure, né colui che fa della contestazione, dell'essere "contro", la sua professione e neppure colui che sogna chissà quali mondi ancora da venire, bensì colui la cui parola non proviene da lui ma da Dio, per cui la sua parola è parola di Dio: non parola su Dio ma parola di Dio. Il profeta è colui che, nel parlare, parla non di sé, dei suoi vissuti o dei suoi progetti, bensì di Dio, di quello che lui vuole e pensa sull'uomo e sulla storia. Colui quindi la cui parola trascende se stessa e entro cui risuona la Parola di Dio: Parola assoluta che l'uomo non può contenere e possedere ma dalla quale è contenuto e posseduto e la cui assolutezza o trascendenza consiste nella assolutezza o trascendenza dell'Amore che tutto giudica e misura senza essere giudicato e misurato. Per questo la parola profetica "brucia come fiaccola": perché, come il fuoco, scioglie le catene dell’io e della violenza che irretiscono la storia umana e, come la luce della fiaccola, illumina la notte dell'esistenza ridisegnandovi i sentieri della riconciliazione e della pace.
La profezia è parola divina che brucia e che riscalda, che giudica e che illumina, inquietando l'umano e sottraendolo alla chiusura e all'inganno. Questa parola non inabita solo alcuni grandi spiriti del passato, quali Elia o altri. Inabita ogni donna e ogni uomo, ogni ragazza e ogni ragazzo. Anche te, la tua biografia e il tuo cammino. E' in te e con te. Chiede solo di essere accolta e obbedita.
Interrogarsi
- Cosa si intende nel linguaggio comune per "profeta"?
- In cosa consiste, per la bibbia, la parola profetica e in che senso essa "brucia" e "illumina"?
- Hai mai pensato che la Parola di Dio inabita anche le tue parole?
Preghiera
Maghi
astrologi
chiromanti
indovini:
che pretendono
di sapere il futuro
e indicare le strade
che rendono felici.
Ma non è al futuro,
Signore,
che tu mi chiami a guardare
ma all'oggi,
all'oggi in cui vivo
in cui spero
in cui lotto.
È in questo oggi
la tua Parola
che purifica come il fuoco
e dischiude
il futuro
davvero nuovo.
Grazie, Signore,
per la tua Parola
e fa' che al fondo
di ogni parola
scopra
sorpreso
la tua Parola.
Amen.
Ruminatio
Il Signore è nostra luce (Sal 118, 27).
ELIA
La difesa di Dio
"Gridate con voce più alta"
Il profeta Elia appare sulla scena politica dopo Salomone, al tempo del re Acab (IX secolo a.C.), quando la fede nel Dio biblico minaccia di scomparire a causa del sincretismo e nel regno d'Israele si affermano ingiustizie gravi. Contro questo degrado, dove al Dio biblico della giustizia e della responsabilità veniva sostituito il dio fenicio della bellezza e della natura chiamato Baal, il profeta Elia eleva la sua voce sfidando Acab e il popolo alla prova del fuoco: «Elia si accostò a tutto il popolo e disse: "Fino a quando zoppicherete con i due piedi? Se il Signore è Dio, seguitelo! Se invece lo è Baal, seguite lui!". Il popolo non gli rispose nulla. Elia aggiunse al popolo: "Sono rimasto solo, come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono quattrocentocinquanta. Dateci due giovenchi; essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Voi invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò quello del Signore. La divinità che risponderà, concedendo il fuoco è Dio!". Tutto il popolo rispose: "La proposta è buona!"» (1 Re 18, 21-24).
La storia prosegue raccontando che la preghiera dei profeti di Baal fu vana: «Quelli presero un giovenco, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: "Baal rispondici!". Ma non si sentiva un alito, né una risposta. Quelli continuavano a saltare intorno all'altare che avevano eretto. Essendo già mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro dicendo: "Gridate con voce più alta, perché egli è un dio! Forse è soprappensiero oppure indaffarato o in viaggio; caso mai fosse addormentato si sveglierà". Gridarono a voce più forte e si fecero incisioni, secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno quelli ancora agivano da invasati ed era venuto il momento in cui si sogliono offrire i sacrifici, ma non si sentiva alcuna voce né una risposta né un segno di attenzione» (1 Re 18, 25-29).
Alla preghiera inascoltata dei profeti di Baal segue quella di Elia al Dio di Israele: «Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutti si prostrarono a terra ed esclamarono: "Il Signore è Dio, il Signore è Dio" » (1 Re 18, 38-39).
Ciò che questa storia insegna, al di là della sua veste narrativa che solo all'apparenza è ingenua, è che esiste una differenza irriducibile tra il vero Dio, di cui il profeta Elia custodisce la memoria e la coscienza, e il falso Dio, di cui i profeti di Baal sono la coscienza convinta ma illusoria; e che la differenza irriducibile tra il falso Dio e il vero Dio consiste nel fatto che il primo è la personificazione dell'io e della sua storia, mentre il secondo il Tu personale o Volontà che si erge di fronte all'io interrompendone il movimento spontaneo e innocente per elevarlo all'altezza della responsabilità di fronte a Dio e di fronte al prossimo.
Nel "supermarket" del villaggio globale in cui viviamo, corriamo il rischio, oggi più che nel passato, di crearci un dio a nostra immagine e somiglianza. La critica beffarda di Elia ci ricorda ("Gridate con voce più alta, perché egli è un dio! Forse è soprappensiero oppure indaffarato o in viaggio; caso mai fosse addormentato si sveglierà") che il vero Dio non è quello che l'io si crea bensì quello che gli si rivela, mettendolo in crisi ed elevandolo all'altezza della responsabilità e dell'amore incondizionato.
Interrogarsi
- Perché la profezia sorge nell'epoca monarchica, al tempo del re Acab?
- In cosa consiste il culto di "Baal", il dio pagano della Fenicia, e perché Elia gli oppone il Dio biblico?
- Qual è la differenza tra il "vero" Dio e il "falso" Dio, tra la vera fede e l'idolatria?
Preghiera
Quante volte
Signore
ho detto di amarti
più di ogni altro
e sopra ogni cosa!
Ma è vero
che io ti amo
e che per me
Tu sei
il Bene più grande?
Oppure
amo solo me stesso
e adoro
un dio
costruito
a mia immagine?
Ti prego
Signore
purifica la mia fede
e fa' che io creda
veramente in te!
Amen.
Ruminatio
Il tuo spirito buono mi guidi (Sal 143, 10).
ELIA
Come "difendere" Dio?
"Non sono migliore dei miei padri
La storia di Elia che trionfa sui falsi profeti di Baal si conclude con un gesto di violenza: «Elia disse loro [cioè ai suoi seguaci]: "Afferrate i profeti di Baal; non ne scappi uno!". Li afferrarono. Elia li fece scendere nel torrente Kison, dove li scannò» (1 Re 18, 40).
I vincitori hanno sempre pensato di sancire il trionfo sui nemici con la loro distruzione. Dagli inizi della storia ad oggi (si pensi solo ai recenti fatti della ex-Iugoslavia o di alcuni paesi africani) la logica è stata sempre la stessa: chi vince, vince eliminando il nemico fisicamente, sottraendolo allo spazio dell'esistenza per sempre. Anche il profeta Elia, non diversamente dagli altri, condivide questa logica e fa lo stesso, afferrando i profeti di Baal e uccidendoli. Ma quel Dio per la cui difesa egli si era mosso con zelo e in obbedienza al quale aveva sterminato i profeti di Baal, entra di nuovo in scena ponendo in crisi la sua coscienza. Il racconto biblico infatti narra che Elia, minacciato di morte dal re Acab per l'azione compiuta, per non farsi catturare fugge nel deserto dove, credendosi abbandonato da Dio, invoca la morte: "Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri" (1 Re 19, 4).
Ma qui nel deserto, invece di trovare la morte invocata, Elia incontra finalmente il vero Dio: «Ivi entrò in una caverna per passarvi la notte, quand'ecco il Signore gli disse: "Che fai qui, Elia? Egli rispose: "Sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita". Gli fu detto: "Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore". Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu la voce del silenzio sottile (la bibbia della Cei, distaccandosi di molto dal testo originale, traduce: "il mormorio di un vento leggero")"» (1 Re 19, 9-11). E' qui, nel "silenzio della voce sottile", che Elia incontra veramente Dio: come colui la cui potenza non è quella della forza naturale che distrugge, come il terremoto, il fuoco e il vento, bensì quella della parola inerme che parla con una voce che è quella del silenzio e sa attendere.
In questo secondo incontro rivelativo, ritenuto dalla tradizione cristiana uno dei vertici della letteratura mistica, Elia capisce la sua colpa e comprende che il Dio che aveva difeso con la violenza, uccidendo i suoi nemici, era un falso Dio: perché il vero Dio non vince con la forza che, come "il vento impetuoso e gagliardo" spacca "i monti e spezza le rocce" bensì con silenzio dell'amore che sa attendere e soffrire, piuttosto che imporre e far soffrire; e soprattutto perché Dio non ha nemici ma solo figli e amici. Lezione mirabile che contesta gran parte della storia umana dove da sempre i vincitori hanno imposto la verità - spesso anche la verità religiosa - con la forza. La verità imposta con la forza è la negazione della verità, soprattutto della verità di Dio, che è la verità dell'amore che accoglie e perdona.
Interrogarsi
- Perché Dio si rivela ad Elia non nella potenza della natura bensì nella "voce del silenzio sottile"?
- Cosa capisce Elia dopo la rivelazione di Dio sul monte Oreb?
- In che senso imporre con la forza la verità del Dio biblico è la negazione stessa della verità?
Preghiera
Vincere
dominare
imporre
ma anche
uccidere
annientare
annichilire:
questa
è la storia
Signore.
Anche i tuoi profeti
a volte
hanno imposto la verità
con la forza
e se guardo
al mio cuore
con disincanto
quanta violenza vi trovo!
Fammi capire
Signore
che la tua verità
è l'amore
e che non devono esistere
nemici
ma solo
fratelli da amare.
Amen.
Ruminatio
Paziente e misericordioso è il Signore (Sal 145, 2).
ELISEO
Il discepolo
"Lo spirito di Elia si è posato su Eliseo"
Oltre che grande profeta e capostipite dei profeti, Elia è ricordato nella tradizione soprattutto per la sua morte avvolta nel mistero. Sentendo prossima la sua fine, egli chiama il discepolo Eliseo, dirigendosi verso il fiume Giordano: «Elia prese il mantello, l'avvolse e percosse con esso le acque, che si divisero di qua e di là; i due passarono sull'asciutto. Mentre passavano Elia disse a Eliseo: "Domanda che cosa io debba fare per te prima che sia rapito lontano da te. Eliseo rispose: "Due terzi del tuo spirito diventino miei". Quegli aggiunse: "Sei stato esigente nel domandare. Tuttavia, se mi vedrai quando sarò rapito lontano da te, ciò ti sarà concesso, in caso contrario non ti sarà concesso". Mentre camminavano conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: "Padre mio, padre mio, cocchio d'Israele e suo cocchiere". E non lo vide più» (2 Re 8-12).
Più che della morte di Elia, questo racconto parla della sua scomparsa dalla terra e del suo rapimento al cielo attraverso il carro di fuoco. Elia pertanto non muore, ma trapassa da un luogo all'altro, dalla terra al cielo. La sua morte più che morte è il sottrarsi alla visibilità dell'occhio. Per questo egli può essere presente dovunque sotto mentite spoglie (Gesù stesso nel vangelo dirà che Giovanni Battista è "quell'Elia che deve venire", Mt 11, 14) e per questa stessa ragione nel Nuovo Testamento l'ascensione di Gesù al cielo è pensata narrativamente con un rimando probabile alla fine di Elia.
Ma cosa può insegnare a noi una storia così bizzarra, dove si parla di "carro di fuoco" e di "cavalli" e dove prevale il gioco della finzione e del racconto popolare?
Che la profezia, di cui Elia è la figura esemplare, non muore e non scompare mai dalla storia umana. Se muoiono e scompaiono i profeti, non muore né scompare la profezia. Questa, intesa come la parola di Dio che abita la storia umana ed accompagna l'uomo nella sua vocazione all'amore e alla giustizia, sopravvive ai profeti e trova sempre nuovi profeti, cioè nuove donne e nuovi uomini, attraverso cui esprimersi e tramandarsi, sia pure nel silenzio e nell'anonimato. Stando alla struttura narrativa del racconto, il centro della storia è rappresentato più che dalla fine di Elia rapito al cielo dalla figura di Eliseo su cui si trasferisce lo spirito di Elia: «Domanda che cosa io debba fare per te prima che sia rapito lontano da te. Eliseo rispose: "Due terzi del tuo spirito diventino miei"». Più che la storia della fine di Elia, il racconto è e vuole essere la storia della profezia che non hai mai fine perché lo spirito di Dio che prima era su Elia ora si è posato su Eliseo: "Lo spirito di Elia è su Eliseo".
Forse anche tu qualche volta avrai detto o avrai sentito dire che il momento in cui viviamo è così difficile perché mancano i profeti, i giusti e i santi. La storia di Elia ci insegna che nella storia - anche nella tua piccola storia quotidiana e familiare - di fatto non manca mai la parola di Dio che illumina e che salva. Il problema non è la sua assenza, ma l'ascolto e l'adesione alla sua presenza.
Interrogarsi
- Quali sentimenti e pensieri ti suscita la storia della fine di Elia rapito al cielo?
- Perché al centro del racconto c'è la figura di Eliseo sul quale si posa lo spirito profetico di Elia?
- Cos'è la profezia e perché essa non può mai estinguersi nella storia?
Preghiera
Da qualche parte
ho letto
che Tu sei morto
Signore
e che gli uomini
vivono
come
se Tu non ci fossi.
È vero.
A volte anch'io
mi dimentico di Te,
e penso
che la storia
è abbandonata a se stessa
e che a trionfare sono
i furbi
e i forti.
Ma l'importante
Signore
è sapere
che Tu mai ci abbandoni!
Donami
la tua Parola
che inquieta
e ricrea il mio cuore
Amen.
Ruminatio
La tua parola mi fa vivere (Sal 119, 50).
ELISEO
Il compassionevole
"Che posso fare io per te?"
Annunciando una parola che proviene da Dio, il profeta è il "porta-parola" divino, colui che, alla sua parola, sostituisce quella di Dio, divenendone il testimone e il difensore anche a costo della vita. Ma qual è il contenuto di questa parola che, come una lama tagliente, entra nella storia e vi introduce una rottura che la giudica e la misura dall'alto e dal di fuori?
Narra il testo biblico che un giorno una donna si rivolse ad Eliseo piangendo: «Mio marito, tuo servo è morto; tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Ora è venuto il suo creditore per prendersi come schiavi i due miei figli". Eliseo le disse: "Che posso fare io per te? Dimmi che cosa hai in casa". Quella rispose: "In casa la tua serva non ha altro che un orcio di olio". Le disse: "Su, chiedi in prestito vasi da tutti i tuoi vicini, vasi vuoti, nel numero maggiore possibile. Poi entra in casa e chiudi la porta dietro a te e ai tuoi figli; versa olio in tutti quei vasi; i pieni mettili da parte". Si allontanò da lui e chiuse la porta dietro a sé e ai suoi figli; questi porgevano ed essa versava. Quando i vasi furono pieni, disse a un figlio: "Porgimi ancora un vaso". Le rispose: "Non ce ne sono più". L'olio cessò. Essa andò a riferire la cosa all'uomo di Dio, che le disse: "Va', vendi l'olio e accontenta i tuoi creditori; tu e i tuoi figli vivrete con quanto ne resterà" (2 Re 4, 6).
In questo miracolo, uno tra i tanti che la tradizione biblica attribuisce ad Eliseo, c'è la risposta all'interrogativo precedente: il contenuto della parola divina, che il profeta custodisce e difende, non riguarda Dio bensì l'uomo e non l'uomo come essere di potere, in quanto dotato di capacità di realizzazione dell’io, bensì l'uomo come essere di bisogno, in quanto vuoto che invoca di essere riconosciuto e colmato dall'altro. La vedova per la quale Eliseo compie il miracolo dell'olio, liberandola dai creditori esosi e dalla riduzione dei figli in schiavitù, è la metafora dell'uomo essere di bisogno sul quale veglia la sollecitudine di Dio. La profezia annuncia e custodisce questa sollecitudine di Dio per il "debole" che, nella storia dei riusciti, è una macchia da occultare, come si occulta un neo sul corpo, o un ostacolo da eliminare, come si elimina dalla strada la pietra o il macigno che impedisce al vincitore il raggiungimento dello scopo.
La profezia - la parola di Dio che entra nelle parole dell'uomo e le sovverte, trasfigurandole e sottraendole alla pretesa dell'assoluto che le rende idolatriche - non parla di Dio, non annuncia il futuro o l'utopia, non disegna il mondo ideale a misura del desiderio umano, bensì parla dell'oggi e del presente e annuncia che l'assoluto si cela in ogni "qui e ora", nel volto anonimo dell’"orfano", della "vedova" e del "povero", di tutti coloro cioè che, per la storia, non contano nulla e non sono.
Su chi non è nessuno veglia l'assoluto: è questo il senso del racconto del miracolo di Eliseo. L'olio che, con la sua parola profetica, egli moltiplica straordinariamente non è una pia favola ma lo svelamento mirabile che l'assoluto veglia sul bisogno umano e chiama il mio io a fare altrettanto. E' questo il "miracolo" da credere e da compiere: davvero la cosa più meravigliosa e mirabile.
Interrogarsi
- In cosa consiste la parola profetica e quale il suo contenuto?
- Come reagisci al racconto del miracolo dell'olio compiuto dal profeta Eliseo?
- In che senso il miracolo dell'olio è svelamento della cosa più meravigliosa e importante della storia?
Preghiera
Che strano
leggere
o parlare
di miracoli:
immaginazione,
illusione
o desiderio?
Eppure
a volte
anch'io
invoco miracoli:
per me
per il mondo
per gli altri.
Ma c'è un solo miracolo
Signore:
l'Amore
con cui mi ami
e mi chiami ad amare.
Fammi comprendere
Signore
che questo
è il miracolo più grande!
Amen.
Ruminatio
Fammi sentire la tua grazia perché in te confido (Sal 143, 8)
ELISEO
La moltiplicazione dei pani
"Ne mangeranno e ne avanzerà anche"
Oltre il miracolo dell'olio, la tradizione biblica attribuisce al profeta Eliseo anche altri prodigi: la risurrezione di un bambino (2 Re 4, 8, 37), la purificazione dell'acqua dal veleno (2 Re 4, 38-41), la guarigione di Nàaman (2 Re 5, 1-27), l'ascia perduta e ritrovata (2 Re, 6, 1-7) e la cessazione di una carestia devastante durante la quale alcune madri giunsero perfino a nutrirsi della carne dei propri figli (2 Re, 6, 32ss).
Tra i vari prodigi il più importante è però quello dei pani: «Da Baal-Salisa venne un individuo, che offrì primizie all'uomo di Dio, venti pani d'orzo e farro che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: "Dallo da mangiare alla gente". Ma colui che serviva disse: "come posso mettere questo davanti a cento persone". Quegli replicò: "Dallo da mangiare alla gente. Poiché così dice il Signore: Ne mangeranno e ne avanzerà anche". Lo pose davanti a quelli, che mangiarono, e ne avanzò secondo la parola del Signore» (2 Re 4, 42-44). Con pochi pani d'orzo e di farro Eliseo sfama cento persone e la ragione di questa "moltiplicazione" è la parola profetica che su di essi viene pronunciata: "Poiché così dice il Signore: Ne mangeranno e ne avanzerà anche". E' per "la parola di Dio" e non per chissà quali poteri straordinari del profeta che tutti mangiano a sazietà. Ma un'affermazione come questa non è insensata? Quando mai la parola di Dio ha sfamato le folle? E che coloro che credono in lui hanno forse visto sconfitta la loro fame? O non è vero il contrario: che proprio coloro che più credono in lui - la sterminata massa dei poveri, dei diseredati, degli umiliati, degli emarginati - sono privi spesso del minimo indispensabile?
Nel salmo 136, il salmo di lode più importante del salterio, noto come il "grande hallel" (in ebraico "hallel" vuol dire "lodare"), si elencano le opere mirabili della creazione e della liberazione che Dio compie "per dare il cibo ad ogni vivente" (v.25; cf pure Sal 145, 15). Affermazione mirabile: sfamare chi ha fame è gesto divino, espressione e concrezione della sua sollecitudine per l'uomo essere di bisogno. Sfamare chi ha fame è cosa radicalmente diversa dallo sfamarsi perché tra l'uno e l'altro esiste la stessa irriducibile differenza tra chi allunga la mano per prendere e portare il pane alla propria bocca e chi lo sottrae alla propri bocca per portarlo alla bocca dell'altro. Sfamare è l'attività di Dio per eccellenza, perché espressione della sollecitudine con cui egli, nella sua libertà d'amore, si china in ogni istante sull'uomo essere di bisogno. A questo gesto divino Dio associa anche l'uomo che così, da essere di bisogno, curvato su di sé e intento a sfamarsi, è elevato all'altezza dell'amore, libero dal proprio io e responsabile dell'altro.
"Un giorno un mandarino", narra una storia cinese, "fece un viaggio nell'aldilà. Prima arrivò all'inferno. C'erano là molti uomini seduti davanti a piatti pieni di riso, ma tutti morivano di fame, perché avevano dei bastoncini lunghi due metri, e non potevano servirsene per nutrirsi. Poi andò in cielo. Anche là c'erano molti uomini seduti davanti a piatti pieni di riso, ma tutti erano felici ed in buona salute; anche loro avevano dei bastoncini lunghi due metri, ma ciascuno se ne serviva per nutrire il fratello che era di fronte a lui".
Sotteso allo sfamare, a differenza dello sfamarsi, c'è l'evento della sollecitudine o gratuità, la cui assenza è l'inferno, la cui presenza è il paradiso. E' nell'annuncio di questo evento il senso della narrazione profetica della moltiplicazione dei pani, che non senza significato, nella testimonianza dei sinottici, è l'attività più importante di Gesù messia.
Interrogarsi
- Come può essere interpretato il racconto miracoloso della moltiplicazione dei pani?
- Perché e in che senso "sfamare" è gesto divino?
- Qual è la differenza tra sfamarsi e sfamare e perché nel primo si nasconde l'inferno, mentre nel secondo il paradiso?
Preghiera
Un cane
del primo mondo
consuma
diciassette volte di più
di un bambino
del terzo mondo!
Perdonaci
Signore
per questa vergogna
e facci capire
che la fame nel mondo
non è solo problema
di lavoro
e di tecnica
ma di conversione dell'io
nell'io-per-l'altro.
Fa'
che il mio cuore comprenda
che l'inferno è l'io
e il paradiso
l'altro
che mi sfama e sfamo.
Amen.
Ruminatio
Egli dà il cibo ad ogni vivente (Sal 136, 25).













































