Piero Mandruzzato e Animatori della Parrocchia «Maria SS. Madre di Dio - Rovigo
(NPG 1994-2-73)
Mi chiamo Piero e mi piacerebbe dirvi un'esperienza fatta da un gruppo di animatori parrocchiali sulla narrazione. Mi rendo conto che raccontare di narrazione ha un che di tautologico, e io stesso mi trovo un po' nell'incertezza sulla via migliore, ma tagliamo corto: vi racconterò della cosa come meglio mi riesce.
Durante lo scorso anno pastorale mi è stata affidata, come chierico, la formazione (!) degli animatori di una delle parrocchie di Rovigo.
Insieme abbiamo cercato di cogliere quali fossero, se c'erano, le esigenze diffuse in fatto di crescita personale, e ci è sembrato di sintetizzarle in un obiettivo: ridare vita alla Parola. Da quasi tutti i nove animatori, infatti, è venuto fuori il disagio di sentire da un lato l'importanza vitale di dare sempre uno spazio primario alla Parola di Dio nell'esperienza dei rispettivi gruppi, dall'altro la difficoltà nel farsi servitori di quella Parola per farla diventare pane, fonte, luce.
La storia, le storie
Restavano da pensare i mezzi e i metodi con cui progettare un itinerario formativo, fatto di incontri che sapevamo pochi ma non volevamo insipidi. Una mano decisiva ce l'ha data il «Narrare per aiutare a vivere» di Tonelli, Gallo e Pollo e, al di là di qualsiasi rigorosa coerenza con le nostre esigenze, la curiosità per un titolo così e l'interesse di chi aveva già dato un'occhiata al contenuto hanno fatto il resto: abbiamo deciso di adottarlo come «libro di testo».
Il metodo seguito è piuttosto semplice, forse banale. Il nostro «sussidiario» è stato suddiviso in sette-otto parti di uno o due capitoli ciascuna. Di ogni parte ho tentato di preparare una specie di sintesi, in modo che i contenuti portanti occupassero al massimo un paio di pagine: la lettura collettiva di tutto il testo sarebbe stata di certo troppo lunga e pesante.
Così, ad ogni incontro, riservavamo un primo momento alla sintesi del libro, che di volta in volta presentavo, attento a comunicare le idee essenziali ma diffondendomi, se necessario, in esempi e citazioni laddove il discorso si faceva particolarmente arduo o delicato.
Non sempre, infatti, il testo ci è parso facilissimo; e il secondo momento era riservato a verificare la nostra comprensione; ad esso seguiva un tentativo di confronto sulle tesi che si potevano trarre per la vita personale e di gruppo.
Nella fase finale del lavoro, quando era diventata a tutti più chiara la proposta della narrazione negli aspetti sia teorici che metodologici, ci è venuta voglia di sperimentare, di provare a prendere confidenza con questo nuovo «stile»; così abbiamo dedicato alcuni incontri al «lavoro di laboratorio»: ognuno di noi avrebbe preparato qualcosa.
Certamente sarebbe stato più logico che ciascuno avesse pensato alla sua proposta prevedendo come destinatari i ragazzi stessi del suo gruppo, con il loro linguaggio e le loro attese, ma ci sembrò piuttosto difficile, e forse scorretto, riuscire a verificare con loro, in modo anche tecnico e analitico, l'efficacia del nostro lavoro.
Così abbiamo deciso che la condivisione della «storia» di ciascuno restasse all'interno del gruppo animatori, con piena libertà di scelta dei modi e dei contenuti: molti di noi infatti vedevano questa «prova» come una scommessa non facile, perché, nonostante quelli narrativi non fossero estranei ai mezzi educativi abituali, affrontarli con questa nuova intenzionalità rendeva tutto una sfida affascinante.
I temi che hanno fatto da sfondo alle nòstre storie sono stati diversi, ma tutti di «grossa» portata: la libertà, il dolore, la morte, il silenzio, il tempo, la felicità, l'amore divino, i valori... C'è chi ha inventato un racconto tutto suo, chi si è fatto aiutare da Kafka, chi ha preso spunto da una poesia di Ungaretti; qualcuno ha voluto accompagnare le parole con le diapositive, qualcun altro ha usato solo un salmo e il disegno.
Probabilmente nessuno è riuscito davvero a proporre una narrazione «ortodossa», che rispettasse tutte le regole tracciate dal libro, ma il momento della sperimentazione si è rivelato presto, io credo, quello più interessante e arricchente: si è percepito subito, nel momento in cui uno di noi con un leggero senso di pudore iniziava il suo racconto, che si passava da un ascoltare e un discutere intensi e cordiali ma pur sempre consuetudinari ad un livello di comunicazione più profondo, in cui chi narrava, ma anche chi ascoltava, si sentiva fortemente implicato.
Tuttavia mi è difficile avere un'idea della quantità e qualità del coinvolgimento che in questa esperienza ha avuto ciascuno degli animatori presenti. Ho potuto certamente intuire una qualche varietà di effetti, reazioni, risonanze, a conferma di una constatazione che il libro chiama decisiva: il contenuto della narrazione e la relazione in cui essa avviene sono strettamente interdipendenti. Il tipo di relazione tra dieci animatori non è asimmetrico come un rapporto specificamente educativo, ma la diversità di interazioni e di sensibilità che era comunque in gioco ci ha fatto percepire la ricchezza e insieme la complessità che si scatenano in una comunicazione che aspiri ad essere anche produzione di senso per l'esistenza.
Se da un lato questo ci è sembrato avvincente, dall'altro ci ha un po' spaventato: la responsabilità racchiusa nel compito di chi cerca di educare è proprio tanta, non ne parliamo poi quando si cerca (o crede) di evangelizzare, e narrando!
Al di là della volontà di crescere nella competenza di narratori, obiettivo su cui vale la pena «perdere» ancora del tempo in futuro, una consapevolezza a cui tutti siamo convenuti in maniera rinnovata è stata l'importanza della testimonianza, il valore decisivo dell'essere autentici, autorevoli e insieme capaci di farci da parte per servire Gesù nell'annuncio della sua salvezza.
Gli ambiti di impegno da privilegiare quindi nella nostra formazione ci sono sembrati soprattutto i seguenti: * l'educazione al silenzio e alla solitudine, come condizioni essenziali per poter recuperare la profondità della comunicazione di tipo «sapienziale»: lontani dal significare assenza di comunicazione ed isolamento, essi rappresentano davvero una via necessaria per diventare autenticamente se stessi e imparare il dialogo;
- una cura e un'attenzione maggiore nel nostro lavoro settimanale di progettazione: una preparazione sapiente richiede anche la capacità di frenare i ritmi convulsi della vita quotidiana per dedicare al nostro servizio, oltre che a noi stessi, un tempo libero e pacificato;
- la competenza legata al linguaggio, in particolare biblico, per restituire alle parole il loro spessore storico, la loro forza evocativa, e riscoprire la ricchezza insondabile dei simboli e delle immagini.
La verifica
Ma le riflessioni e i propositi non si fermano qui: in un'ultima riunione di verifica, ognuno ha voluto sottolineare un aspetto importante del lavoro fatto.
Marta è stata tentata, nel narrare, di voler «spiegare» a tutti i costi, di non rispettare la carica simbolica del linguaggio per timore di non essere capita; invece, pur avendo cura della chiarezza del messaggio, si devono comunque prevedere dei «vuoti» da riempire, e «restituire agli ascoltatori quello spazio di solitudine interiore dove ciascuno prende decisioni per la propria vita».
A Federico è parsa particolarmente importante la qualità della narrazione, per poter garantire una certa essenzialità comunicativa.
Anche Sara e Matteo hanno avvertito, oltre alla fatica che comporta essere creativi, il rischio di disperdere il messaggio in tanti rivoli a causa della difficoltà del mezzo narrativo.
Angela ha sottolineato il valore di quella meta-comunicazione che sono i gesti, le espressioni mimiche che accompagnano il racconto, e l'importanza della musica, delle immagini, dell'uso di segni e simboli.
Particolarmente intenso è stato il confronto sul rapporto tra l'esperienza personale del narratore e il contenuto della narrazione: per Angela, che è la veterana del gruppo, le esperienze «private» vanno raccontate col contagocce.
Anna: il racconto è vita, e invece io tendo spesso a separare ciò che comunico dalla mia esperienza.
Francesca: è vero che si deve sempre attingere all'esperienza vissuta, ma ci sono fatti della nostra vita che non siamo ancora riusciti ad illuminare nel loro significato sapienziale; ci sono problemi irrisolti, tensioni che possono essere rischiose se trasmesse in tutta la loro problematicità.
Emanuela: non tutti i temi, se di temi è corretto parlare, sono adatti a trovare spazio nella narrazione, e non tutti inoltre trovano un riscontro vitale nella nostra storia personale.
Piero: forse queste difficoltà dipendono da un lato dalla nostra scarsa familiarità con la capacità di leggere la nostra esistenza, diciamo «cristologicamente», di vederci davvero come dei «salvati», dall'altro lato dalla debolezza della nostra memoria: forse non siamo poveri di esperienze, facciamo solo fatica a recuperarle dal nostro passato e presente, per apparente mancanza di senso, o perché, dato che sono semplici e quotidiane, le giudichiamo ingiustamente banali.
Lorenza: non dimentichiamo di capire prima di tutto la giusta lunghezza d'onda da usare con i ragazzi! Correremmo sempre il rischio fatale di mettere prima noi stessi e dopo il messaggio, mentre del messaggio dobbiamo farci servitori, facendo un continuo esercizio di umiltà: basta far caso anche solo al tono di voce che usiamo qualche volta, a come parliamo...
Mi rendo conto che, senza volerlo, nella nostra verifica abbiamo toccato tutti gli aspetti problematici segnalati nel capitolo nono del libro; esso individua proprio gli equivoci che possono togliere autenticità alla narrazione:
- il rischio strisciante di soggettivizzare il dato di fede e ridurlo a esperienza emotiva, frutto di un rapporto sbagliato tra soggettività e oggettività nell'atto narrativo;
- il problema della sistematicità, qualità dell'evangelizzazione che è apparentemente inconciliabile con il narrare;
- il rapporto tra il linguaggio narrativo e quello argomentativo, esplicativo.
Questo dimostra forse che la scelta a favore della narrazione non è una scelta facile, che diventare buoni animatori-narratori richiede molto impegno, e magari non è da tutti, ma il valore educativo della narrazione resta innegabile: basterebbe chiedere anche solo a qualcuno degli Akela che guidano i tanti lupetti d'Italia, per i quali il racconto è un mezzo educativo insostituibile e ricco di tradizione.
Per finire, per quanto riguarda me, l'esperienza che ho tentato di raccontarvi è stata ricca di stimoli e di conseguenze sul mio modo di pensare e di parlare di Dio, mi ha suggerito soprattutto molta più umiltà; del resto, per cambiare il nostro «stile» di evangelizzazione, basterebbe far nostre quelle quattro indicazioni su «come dire Dio» che è Gesù stesso a darci:
- Gesù «fece ed insegnò»: quanta animazione verbosa e sterile perché slegata dalla prassi, dai segni concreti!
- Gesù parlò del Padre in modo metaforico e narrativo: quanti discorsi sulla fede aridi e pretenziosi!
- Gesù parlò rispondendo alle attese profonde della gente: qual è la nostra effettiva capacità di cogliere i bisogni reali dei ragani e di adeguarvi la nostra proposta?
- Gesù parlò producendo gioia e speranza: che fatica, a volte, evitare lo scandalo della noia e della tiepidezza!
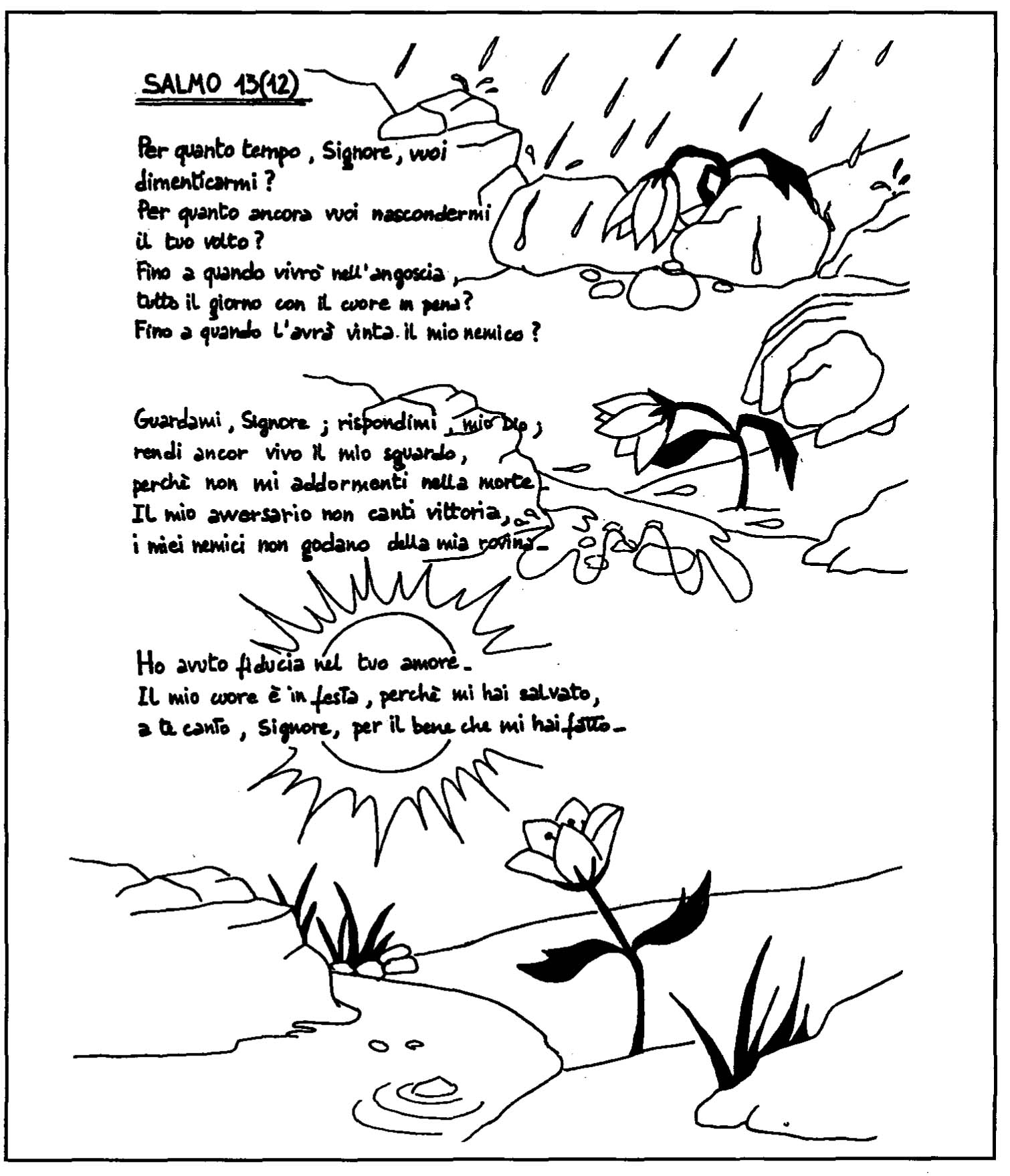
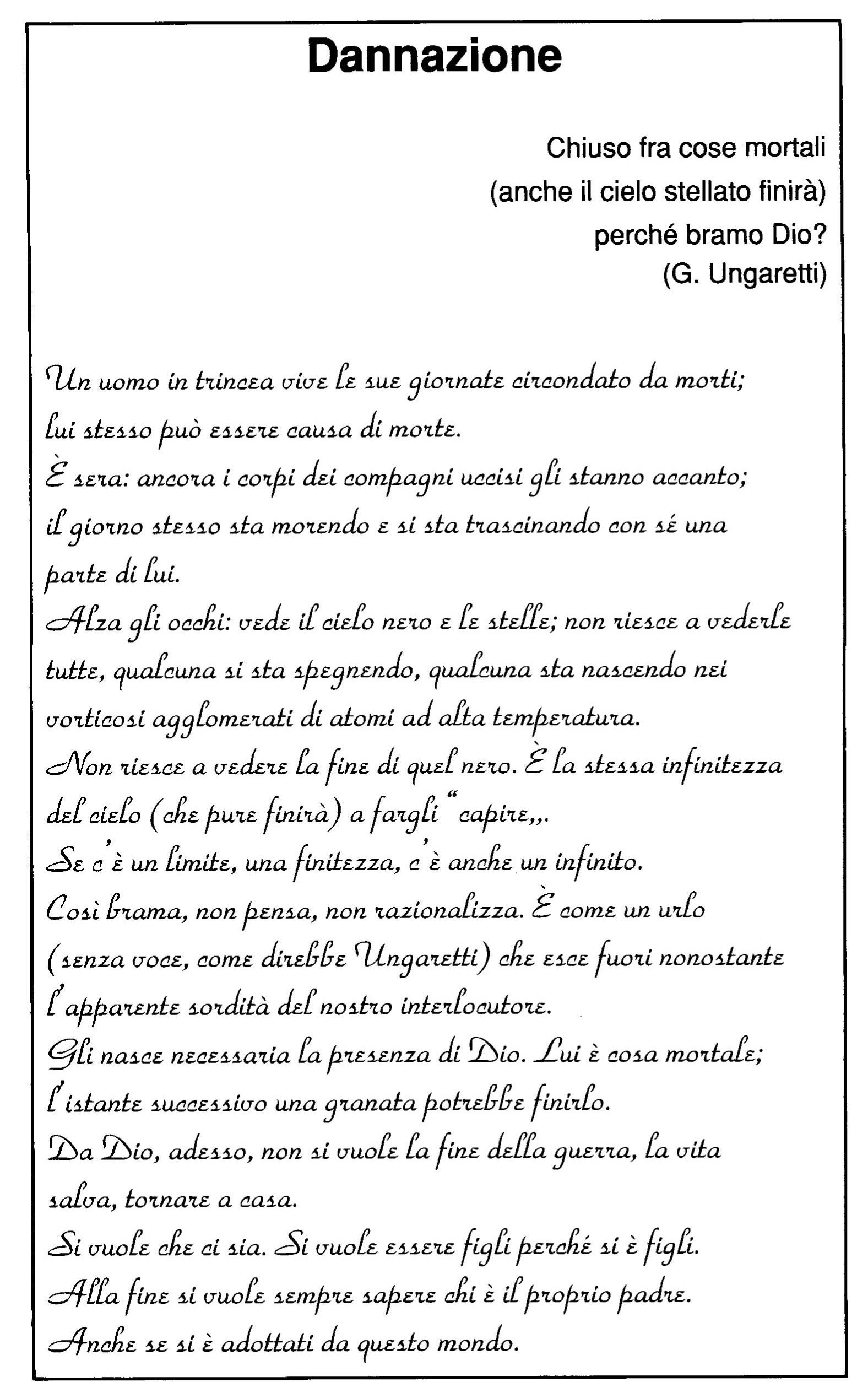
Ascolto
Jerene lo scoprì per caso. Stava lavorando in biblioteca un pomeriggio - in realtà sprecando tempo - scorrendo gli indici di riviste e periodici psicanalitici alla ricerca di qualcosa, qualsiasi cosa le desse un suggerimento, una nuova base, che illuminasse l'uscita di quella mastodontica e sregolata tesi in cui si era persa. Nel corso di sette anni aveva cambiato l'argomento della tesi una dozzina di volte: dall'abbandono del bambino alla fenomenologia dell'adozione, fino alle lingue perdute che i bambini balbettavano nelle loro stanzette. Eppure la sua borsa di studio era stata rinnovata e a quanto pareva avrebbe continuato a esserlo indefinitamente, perché molti dei professori della facoltà di filosofia la consideravano un genio nascente, una grande mente filosofica, mentre il resto temeva che potesse perdere il lume della ragione se respingevano la sua richiesta di denaro, temevano che potesse sorprenderli con un fucile a canna mozza per fargli saltare il cervello, come aveva fatto quello studente di matematica di Stanford, completamente impazzito. Percorrendo l'indice, un po' annoiata e incominciando a pensare al pranzo, lesse il riassunto di un caso clinico che la incuriosì. Era in una raccolta dí giornali psicanalitici, sistemati in una sezione remota della biblioteca. Seguì la traccia del numero d'ordine del volume; lo tolse dallo scaffale; lesse l'articolo la prima volta in fretta, un po' ansiosamente, saltando le frasi qua e là per scoprire la tesi come si era abituata a fare da molto tempo. Poi lo rilesse, lentamente. Quando finì respirava in modo irregolare, forte, e il suo piede tamburellava sulla base di scuro metallo della libreria. Il cuore le batteva forte.
L'articolo parlava di un bambino piccolo, di nome Michel, nato da un'adolescente sbandata, probabilmente ritardata, il frutto di uno stupro. Fino all'età di quasi due anni aveva vissuto con sua madre in un casamento popolare vicino a un cantiere edilizio. Ogni giorno la madre vagava dentro, intorno e fuori dell'appartamento, persa nella sua follia. Si accorgeva appena della presenza del bambino, non sapeva nemmeno come nutrirlo e come occuparsi di lui. I vicini erano allarmati per le grida di Michel, ma quando andavano a bussare alla porta per chiederle di tranquillizzarlo, spesso lei non c'era. Usciva a tutte le ore, lasciando il bambino da solo, incustodito. Poi un bel giorno, quasi improvvisamente, i pianti si interruppero. Il bambino non gridava più, e non gridò neanche la notte seguente. Per giorni non si sentì neanche un rumore. Vennero chiamati la polizia e gli assistenti sociali. Trovarono il bambino sdraiato sul suo lettino accanto alla finestra. Era vivo e straordinariamente in buona salute, considerando quanto era stato trascurato. In silenzio, giocava sul suo squallido lettino, fermandosi
ogni qualche secondo per guardare fuori della finestra. Il suo gioco era diverso da qualsiasi altro gioco avessero mai visto. Guardando fuori della finestra, sollevava le braccia, poi le bloccava bruscamente, si rizzava in piedi sulle gambe scarne, poi cadeva; si piegava e si al72va. Faceva strani rumori, una specie di scricchiolio con la gola. Cosa stava facendo?, si chiesero gli assistenti sociali. Che razza di gioco poteva essere questo?
Poi guardarono fuori della fnestra, dove erano in funzione alcune gru, che sollevavano travi maestre e travetti, o allungavano palle di demolizione sul loro unico braccio. Il bambino stava osservando la gru più vicina alla finestra. Quando questa si sollevava, lui si sollevava; quando si piegava, lui si piegava; quando le sue marce stridevano e il motore ronzava, il bambino produceva uno stridio con i denti, un ronzio con la lingua. Lo portarono via. Lui gridò istericamente, e non si riuscì a calmarlo, tanta era la sua desolazione per essere separato dalla sua adorata gru. Anni dopo Michel era un adolescente che viveva in un istituto speciale per handicappati. Si muoveva come una gru, faceva i rumori di una gru, e benché i medici gli mostrassero molte fotografie e giocattoli, reagiva soltanto alle fotografie della gru, giocava soltanto con delle gru giocattolo. Soltanto le gru lo rendevano felice. Divenne famoso come bambino-gru». E la domanda contro cui Jerene continuava a sbattere, leggendo l'articolo, era questa: che suono aveva? Che effetto faceva? Il linguaggio apparteneva a Michel soltanto; per lei era perduto per sempre. Come dovevano essere parse meravigliose e grandiose quelle gru a Michel, in confronto alle piccole e goffe creature che lo circondavano. Perché, Jerene ne era convinta, ciascuno a modo suo, trova ciò che deve amare, e lo ama; la finestra diventa uno specchio; qualunque sia la cosa che amiamo, è quello che noi siamo.
Dopo avere fotocopiato l'articolo, uscì dalla biblioteca. Fuori c'era un vento pungente; si alzò il bavero della giacca. Nelle vicinanze erano in corso lavori edilizi, le gru stavano funzionando, sollevando travi all'altezza degli uomini con il casco che brulicavano sulle impalcature precarie del condominio in costruzione. Le gru sembravano una specie di insetti giganteschi, dalle membra lunghissime. Incantata, Jerene si avvicinò alla staccionata di legno provvisoria che circondava il cantiere. Nella staccionata c'era un buco tagliato sommariamente, e attraverso questo Jerene osservò l'ampia voragine dalla quale sarebbe sorto l'edificio, guardò la gru affondare e allungarsi. Rimase lì nel fragore assordante delle gru. Nel macino, nelle vibrazioni, negli stridii, nell'universo delle gru, nel grembo delle gru, rimase lì, a occhi spalancati, e ascoltò.
(da La lingua perduta delle gru di David Leavitt, p. 201-203).
«Qualunque sia la cosa che amiamo, è quello che noi siamo»
È una frase che mi ha dato da pensare tantissimo e, credo involontariamente (dato il libro da cui è tratta), mi ha aiutato a capire meglio Gesù.
Quando cerca di distogliere i suoi amici dalla preoccupazione eccessiva per il cibo e i vestiti, e li rassicura sulla sollecitudine amorosa del Papà che è nei cieli per ciascuno di loro, Gesù dice:
«Procuratevi ricchezze che non si consumano, un tesoro sicuro in cielo. Là, i ladri non possono arrivare e la ruggine non lo può distruggere. Perché, dove sono le vostre ricchezze là c'è anche il vostro cuore» (Lc 12,33-34).
Il signor Castellini era il mio principale, il mio capo. Era ormai più di un anno che lavoravo nel suo studio pubblicitario, ed avevo la sensazione che lui cominciasse a fare dei progetti su di me, perché credo che gli piacesse come lavoravo, cominciavo a non essere tanto impacciato nemmeno con la grafica al computer.
Una sera, prima di andare a casa, gli ho detto che dovevo parlargli. Lui si è subito seduto alla sua scrivania e io ho chiuso la porta. Forse si aspettava di dover discutere sullo stipendio, ma prima mi ha lasciato dire.
Non sapevo bene come dirglielo, così ho cominciato dicendo con un po' d'ironia che avevo deciso di cambiare indirizzo professionale. Lui ha corrugato la fronte. «Ho deciso di entrare in seminario». «Co-cosa?». Ho dovuto ripetere, ma presto ha capito, mi ha fatto gli auguri allargando le braccia, ha sorriso un po' tristemente e mi è sembrato di capire che mi ritenesse proprio fortunato, come se avesse preferito anche lui non passare più di trent'anni della sua vita chiuso lì dentro.
Per capire dov'era il mio cuore ho fatto proprio come Jerene: mi sono messo ad ascoltare, anche se capire che siamo tutti fatti per amare. Dio non può forse essere frutto solo di un ascolto attento: è un grande dono.
Ma per convincermi a cambiare mi è bastato cominciare ad amare appena qualche parola dell'alfabeto di Dio, che è strano e misterioso come quello delle gru. Anzi, a me ha fatto venire in mente il canto delle balene, perché per sentirlo bisogna scendere coraggiosamente negli abissi, nel profondo di sé.
Felice chi segue le strade della sapienza,
e cerca di capire i suoi segreti.
Buttati alla sua ricerca e seguine le tracce,
nasconditi aspettando là dove essa passa.
Chi fa così è come un innamorato: spia alle sue finestre
e sta in ascolto alla sua porta.
Per restarle vicino,
pianta la sua tenda accanto alle mura della sua casa,
dove è bello per lui abitare.
Alla sapienza affiderà i suoi figli,
troverà riparo sotto i suoi rami:
sarà protetto dal suo calore
e vivrà alla luce della sua presenza» (Siracide 14,21-27).













































