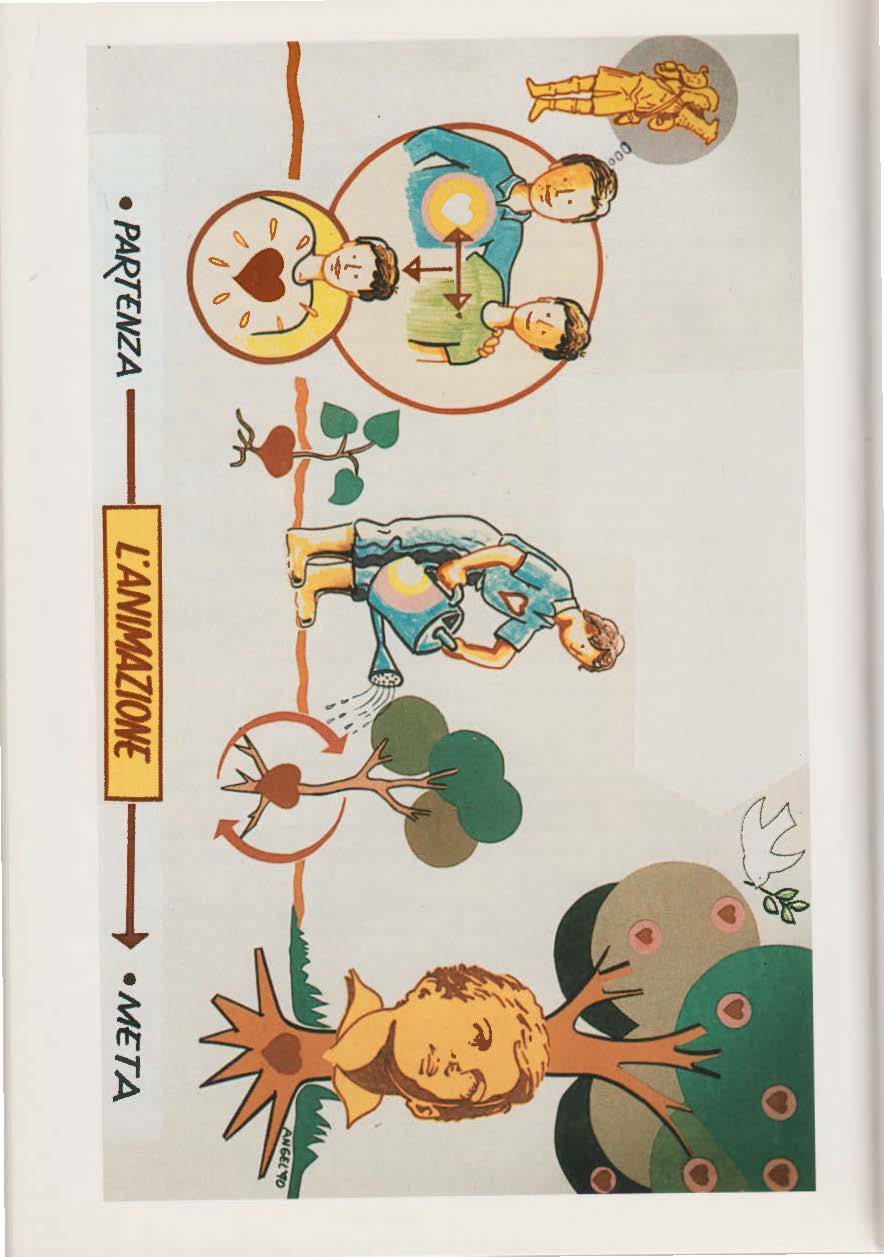Dicastero per la Pastorale Giovanile
La Pastorale Giovanile
Salesiana
Quadro di riferimento fondamentale
II edizione 2000
PARTE II
UN MODELLO OPERATIVO
La realizzazione della Pastorale Giovanile Salesiana ha bisogno di una grande varietà di elementi: persone, strutture, attività, risorse materiali, programmi, ecc. che devono orientarsi adeguatamente secondo gli obiettivi, contenuti e strategie del Progetto Educativo-Pastorale. In questo modo, tutte queste realtà, anche nella loro varietà e diversità, acquistano una identità propria, diventano cioè salesiane.
Questa forma concreta di strutturare e di organizzare i diversi elementi di una pratica educativa e pastorale, per assicurarne la sua identità, la sua coerenza rispetto agli obiettivi del progetto e la sua organicità, lo chiamiamo “modello operativo”.
In questa parte vogliamo esplicitare questo modello operativo della Pastorale Giovanile Salesiana, presentando le caratteristiche dei diversi elementi, strutture e servizi che realizzano il PEPS, per facilitare una loro più chiara identità salesiana e la loro unità organica.
Capitolo 4
OPERE E SERVIZI DELLA PASTORALE GIOVANILE SALESIANA NEI DIVERSI AMBIENTI GIOVANILI
Introduzione
Il PEPS si attua in un determinato territorio attraverso “pluralità di forme, determinate in primo luogo dalle esigenze di coloro a cui ci dedichiamo” (Cost.41) e degli ambienti in cui vivono, soprattutto gli ambienti di impoverimento economico, politico e culturale.
Per questo “realizziamo la nostra missione principalmente attraverso attività ed opere in cui è possibile promuovere l’educazione umana e cristiana dei giovani, come l’oratorio e il centro giovanile, la scuola e i centri professionali, i convitti e le case per giovani in difficoltà”, le parrocchie e residenze missionarie, i centri specializzati nel campo pedagogico e catechistico, le case per esercizi; operiamo inoltre nel settore della comunicazione sociale e in altre opere e forme di presenza tra i giovani (cfr. Cost. 41-43).
Attraverso questa pluralità di opere e servizi si manifesta l’unità e allo stesso tempo la ricchezza del progetto salesiano. Ogni opera e struttura apporta la sua specificità all’insieme e collabora a realizzare il criterio oratoriano dell’art. 40 delle Costituzioni, essere “per i giovani casa che accoglie, parrocchia che evangelizza, scuola che avvia alla vita e cortile per incontrarsi da amici e vivere in allegria”.
Per esprimere con chiarezza questa unità del Progetto Pastorale Salesiano nel territorio e nella Chiesa locale le diverse opere e servizi che costituiscono una presenza salesiana in un determinato territorio devono pensarsi in mutuo riferimento e complementarità attorno:
- alla comunità salesiana locale o ispettoriale che anima la presenza curando la sua identità salesiana,
- al consiglio dell’opera come organismo centrale di animazione che coinvolge insieme SDB e laici (CG24, 160-161; 171).
Questo esige che tra queste diverse opere e servizi ci siano:
. alcune linee e criteri d’azione educativo-pastorali comuni,
. certe strutture di coordinamento e di collaborazione,
. uno spirito di comunione e di condivisione di risorse.
Compete all’Ispettore con il suo Consiglio - tenendo conto della realtà ispettoriale e della consistenza dei diversi ambiti educativi, in dialogo con la comunità salesiana locale- determinare le forme concrete di attuare questa relazione e i modelli concreti di attuazione della CEP (Cf. CG24, 169).
In questo capitolo si presentano le caratteristiche più importanti di queste opere e servizi nelle quali si realizza la Pastorale Giovanile Salesiana espressa nel Progetto Educativo-Pastorale.
Anzitutto si presentano le opere e strutture più organizzate e tradizionali, come l’Oratorio-Centro Giovanile, la Scuola e Centro Professionale e la Parrocchia.
Dopo, altre opere e servizi con i quali si tenta di andare incontro ai giovani e rispondere alle nuove sfide che ci presentano. Tra queste diamo una speciale importanza alle opere e servizi per i giovani in difficoltà.
Molte di queste nuove presenze educative e pastorali tra i giovani si danno anche nelle opere tradizionali e costituiscono un segno del loro sforzo di rinnovamento e qualificazione pastorale.
I . L’ORATORIO-CENTRO GIOVANILE
1. L'ORIGINALITÀ DELL'ORATORIO SALESIANO
Descriviamo l'Oratorio come opera a sé, che oggi realizza la missione salesiana nel campo dell'educazione informale, cioè più libera e spontanea di quella scolastica istituzionale.
Storicamente, l'Oratorio è la prima delle opere stabili di Don Bosco, che ha dato origine a tutte le altre. Gli aspetti fondamentali dell’Oratorio-Centro Giovanile salesiano si enucleano quindi dall’azione di Don Bosco e dal suo evolversi rispetto ad altri modelli ed istituzioni di questo genere.
1.1 L’ispirazione originale
L’Oratorio di Don Bosco, che prendeva il nome da un’istituzione esistente, si distinse da altri che lo avevano preceduto o gli erano contemporanei.
Sono proprio le trasformazioni operate da Don Bosco che indicano ancora oggi le caratteristiche della pastorale oratoriana. Queste trasformazioni sono sostanzialmente sei:
° dalla prestazione di un “servizio” di catechesi, alla presenza-partecipazione nella vita del giovane con i suoi bisogni e problemi.
° dal “tempo limitato” al “tempo pieno”, occupando tutta la giornata domenicale e prolungandosi durante la settimana attraverso contatti personali e attività.
° da un programma catechistico limitato ad un programma educativo pastorale potenzialmente integrale; il gioco, altre forme di espressione giovanile come il teatro, la musica e il canto, la scuola, i gruppi... sono elementi di questo programma.
° dall’istituzione centrata sugli adulti alla comunità di ragazzi centrata nella partecipazione giovanile, l’essere insieme, l’apertura a tutti.
° dalla centralità del programma, alla centralità delle persone e dei rapporti interpersonali.
° dal carattere parrocchiale allo slancio missionario, aperto ai giovani che non sapevano neppure a che parrocchia appartenessero, e non vedevano nella parrocchia un punto di riferimento, né per la loro vita religiosa, né per i loro problemi umani.
1.2 La nuova situazione attuale
Con l’evolversi dell’azione di Don Bosco e il suo estendersi, non sono mutati i principi ispiratori, né i tratti caratteristici, ma le situazioni socio-educative e i fenomeni culturali che hanno modificato la condizione giovanile richiedono il loro aggiornamento.
Alcune manifestazioni sono:
- è nata una nuova concezione del tempo libero che occupa sempre di più la vita dei giovani, in quantità, in pluriformità di possibilità e risorse, con le nuove possibilità educative o di svuotamento delle persone ( consumismo), fino a divenire una caratteristica culturale;
- sono sorti nuovi ambienti ed agenzie educative: lo sviluppo dello sport, del turismo giovanile, la musica, i mezzi di comunicazione sociale, l’aumento dell’associazionismo culturale, sociale, ricreativo, religioso...offrono nuove possibilità di protagonismo giovanile;
- le stesse istituzioni scolastiche si sono preoccupate di integrazioni molteplici che vanno al di là degli aspetti strettamente didattici, con un maggiore inserimento nel territorio e con varietà di attività nel tempo libero;
- si è incrementata la lontananza-estraneità tra giovani e Chiesa, tra vita giovanile e le istituzioni educative e pastorali, che trovano difficoltà ad essere una proposta evangelica significativa per gli adolescenti e i giovani.
1.3 Verso una nuova sintesi
La riflessione fatta dai Capitoli Generali XX, XXI e XXIII offre i punti di convergenza a cui si è arrivati a livello di Congregazione.
Secondo essi l’Oratorio-Centro Giovanile va concepito come una realtà espressa in molteplici forme di realizzazione possibili, ma con alcune caratteristiche essenziali:
° Un ambiente di ampia accoglienza aperto a una gran diversità di giovani, soprattutto i lontani, di una vasta zona; con una gran diversità di proposte e di livelli di appartenenza; caratterizzato per un protagonismo giovanile e una relazione personale così significativa, che lo fa un ambiente di riferimento e di irradiazione per i giovani all’intorno.
L'Oratorio-Centro Giovanile infatti, pur essendo una realtà unitaria per ispirazione e finalità, differenzia le specifiche fasce d'età - ragazzi, adolescenti e giovani - per la metodologia, le proposte, gli obiettivi concreti e gli spazi di azione.
° Un centro capace di offrire un'autentica educazione umana, che sa cogliere i valori positivi presenti nella società e cultura in cui vivono i giovani, e favorire la loro assimilazione; in particolare, una connotazione caratteristica dell'Oratorio è la promozione delle valenze educative delle più diverse forme di impiego del tempo libero.
° Un programma di evangelizzazione missionaria rivolto in forma prioritaria ai giovani più lontani per offrire loro, attraverso il risveglio e l’approfondimento della loro domanda di vita e di compagnia, un cammino di educazione alla fede adatto alle loro situazione e sensibile alla realtà ecumenica e interrreligiosa nella quale vivono.
° Una presenza cristiana nel mondo giovane e nella società civile ( opera di frontiera tra il religioso e il civile, tra il secolare e l’ecclesiale), capace di offrire risposte educative ed evangeliche significative alle sfide e alle urgenze più sentite, specie quelle che si riferiscono ai lontani, e capace anche di promuovere un ambiente di apertura interculturale, interrraziale, ecumenica e interreligiosa.
Oggi poi si aprono nuove prospettive per l'Oratorio-Centro Giovanile per rispondere ad esigenze diversificate per aree geografiche, religiose e culturali che vivono i giovani, come ad esempio: gli oratori notturni, le presenze itineranti per giovani a rischio, gli oratori di zona o quartiere collegati in rete tra di loro, le presenze di tipo oratoriano gestite o guidate interamente da laici con riferimento al PEPS ispettoriale
2. LA COMUNITÀ EDUCATIVO-PASTORALE DELL'ORATORIO-CENTRO GIOVANILE SALESIANO
2.1 Caratteristiche della CEP dell’Oratorio-Centro Giovanile
La comunità Educativo-Pastorale (CEP) negli Oratori-Centri Giovanili prende caratteristiche proprie che scaturiscono dalla sua natura stessa che si appoggia soprattutto nell’ambiente di libertà, caratterizzato per l’accoglienza, la relazione amichevole e la partecipazione attiva degli stessi giovani.
2.1.1 Un'incisiva presenza nel mondo dei giovani
La CEP degli Oratori-Centri Giovanili, come soggetto animatore di questa dinamica comunitaria, ha queste caratteristiche:
° una grande capacità di avvicinamento e condivisione con il mondo dei giovani, attenti alle loro domande e bisogni;
° flessibilità e creatività per adattarsi sempre di più alla diversità e spontaneità dell’ambiente oratoriano;
° una coscienza chiara e condivisa della proposta e del progetto che favorisca l’unità di criteri e la convergenza d’interventi, evitando la dispersione e l’individualismo;
° accoglienza e attenzione alle singole persone, superando le relazioni piuttosto funzionali;
° un ampio spazio alla partecipazione e responsabilità degli stessi giovani;
2.1.2 Il protagonismo giovanile nella CEP dell’Oratorio-Centro Giovanile Salesiano
L’Oratorio è uno spazio educativo pastorale specialmente adatto per promuovere una partecipazione sempre più intensa nella vita dei giovani. Iniziamo il dialogo con i ragazzi fin dai primi incontri, per motivarli, coinvolgerli sempre di più e corresponsabilizzarli gradualmente nelle attività e nei gruppi che prescelgono.
Il Consiglio della CEP dell’Oratorio-Centro Giovanile deve curare in maniera speciale le strutture di partecipazione capaci di offrire ai giovani la più ampia responsabilità possibile accanto agli educatori adulti.
2.1.3 La CEP aperta ed inserita nella Chiesa e nel territorio
° L'Oratorio e il Centro Giovanile sono momenti e luoghi particolarmente significativi, anche se non unici, per l’avvicinamento e l’evangelizzazione dei giovani nella pastorale d’insieme.
Molti Oratori-Centri Giovanili appartengono a una parrocchia, o sono una presenza di Chiesa in una zona pastorale.
Il loro inserimento nella Chiesa si manifesterà con rapporti di vicendevole appartenenza. Per questo:
- qualificare il Progetto Educativo-Pastorale Salesiano dell’Oratorio in convergenza con le linee della Pastorale diocesana per essere una proposta significativa di Pastorale Giovanile;
- essere inseriti responsabilmente nelle strutture di partecipazione (consiglio pastorale della parrocchia e/o zona), apportando la propria sensibilità e preoccupazione giovanile;
- condividere iniziative, momenti di dialogo, programmi educativi e pastorali con le comunità parrocchiali della zona favorendo un mutuo arricchimento.
° L’Oratorio-Centro Giovanile è una presenza educativa nel mondo dei giovani; per questo il suo rapporto con il territorio deve essere stretto: una comunità oratoriana che sappia dialogare con la realtà circostante, con le istituzioni sociali ed educative del quartiere e della città e favorirne la trasformazione.
Ecco alcune azioni significative in questo senso:
- conoscere il territorio;
- collegamento e accordi di collaborazione con altre realtà sociali ed ecclesiali operanti nel territorio;
- momenti di porte aperte e disponibilità degli ambienti per attività del territorio confacenti con le finalità del Centro;
- sforzo creativo di programmazione e di proposta a favore del territorio;
- partecipare insieme ad altre organizzazioni che collaborano nella Pastorale Giovanile
2.2 L’animazione della CEP dell’Oratorio-Centro Giovanile
Essendo la CEP dell’Oratorio-Centro Giovanile una realtà molto aperta e partecipata ha bisogno di una animazione sistematica che garantisca una identità salesiana chiara e sicura nel continuo adattarsi alle mutevoli necessità giovanili, e un sistematico processo educativo che dia unità e articolazione alla pluralità di proposte ed esperienze.
2.2.1 Alcuni elementi fondamentali di questa animazione
° Articolare la massa giovanile in diversi gruppi di attività e di formazione secondo i loro interessi: promuovere la più ampia responsabilità possibile dei giovani sull’ambiente e la vita dell’Oratorio; suscitare la partecipazione e l’associazionismo giovanile attorno al Movimento Giovanile Salesiano.
° Allargare la corresponsabilità degli adulti che sappiano condividere con i giovani un ambiente di amicizia, una proposta educativa di vita e una esperienza di famiglia e comunità. La loro presenza è un elemento di stabilità e maturità importante nella vita mutevole dell’Oratorio. Tra gli adulti, la cui presenza consideriamo importante nell’Oratorio-Centro Giovanile, elenchiamo gli adulti con compiti specifici di animazione, i genitori dei ragazzi, specialmente coloro che desiderano collaborare all’azione educativa, e i membri della Famiglia Salesiana.
° Curare la formazione dei laici educatori e dei giovani animatori; investire persone e risorse in un continuo sforzo di qualificazione educativa, cristiana e salesiana degli educatori e soprattutto dei giovani più maturi e capaci di responsabilità attraverso la scuola d’animatori, campiscuola, corsi, ritiri, convegni, ecc. …
° Promuovere la presenza e l’inserimento significativo dell’Oratorio-Centro Giovanile nel territorio e nella Chiesa locale, con una attenzione particolare ai lontani e giovani a rischio, mediante la conoscenza da parte della CEP delle zone di normalità e di disagio del territorio, così come dei punti rete sociali ed ecclesiali operanti in esso; promuovendo iniziative concrete di ricerca dei ragazzi dove sono, soprattutto nelle zone prive di servizi e di risposta educativa ai loro bisogni e interessi; fino al massimo di coinvolgimento, come parti di un coordinamento permanente per la promozione di iniziative e servizi gestiti con altri. Formare a svolgere questa animazione, anche attraverso il volontariato, secondo uno stile di gratuità.
2.2.2 Servizi d’animazione e di governo
Sebbene tutti siano coinvolti nell'animazione, ci sono alcuni compiti specifici che conviene rimarcare.
a. La comunità salesiana
Tutta la comunità salesiana, nel suo insieme, ha un compito specifico d'animazione dell'Oratorio-Centro Giovanile. Tutti i confratelli della casa, non solo gli incaricati, sono i responsabili dell’identità salesiana, della convocazione degli adulti e dei giovani animatori nella CEP, della loro formazione permanente, dell’apertura e inserimento nel territorio e nella Chiesa locale.
L’animazione si attua con:
- la testimonianza di comunione fraterna e di apertura cordiale ai giovani,
- l’offerta di esperienze di fede e di preghiera condivisa con loro;
- la partecipazione attiva nell’elaborazione e verifica periodica del PEPS locale;
- l’apertura attenta della comunità alla realtà sociale del territorio.
b. L'incaricato dell’Oratorio- Centro Giovanile
La sua figura si ispira al Don Bosco dell’Oratorio: vocazione, simpatia e competenza per il lavoro tra i giovani, spirito apostolico, capacità di rapporti diretti e profondi con i collaboratori e di presenza incoraggiante tra i giovani, creatività ed intraprendenza per rinnovare proposte e comunicare entusiasmo, preoccupazione per l’unità operativa dell’équipe e la sua crescita in Cristo.
In profonda sintonia con la comunità salesiana:
- promuove il PEPS elaborato, attuato e verificato insieme da tutta la CEP;
- coordina tutti quelli che lavorano nell’Oratorio, i diversi gruppi e commissioni;
- promuove il loro collegamento e collaborazione con altre forze operanti per l’educazione o per il mondo giovanile nella zona e nella Chiesa locale;
- assicura l’inserimento dell’Oratorio-Centro Giovanile nella comunità cristiana parrocchiale.
c. Gli animatori, adulti e giovani
La funzione degli animatori, come parte integrante della CEP consiste:
- nell’essere punto di riferimento per i ragazzi e i giovani, vivendo i valori che proponiamo, accettando un progetto di uomo e di donna secondo il Vangelo e impegnandosi a realizzarlo progressivamente nella loro vita;
- nel vivere da vicino la realtà dei giovani, dedicare tempo per stare in mezzo a loro, condividere e apprezzare ciò che loro piace e favorire la loro maturazione integrale;
- nell’animare il progetto dell’Oratorio-Centro Giovanile attraverso la responsabilità e il coordinamento dei diversi gruppi e attività proposte, facendo sempre in modo che i giovani siano protagonisti e corresponsabili;
- nel favorire la relazione tra le persone e i gruppi in un clima di ascolto e di rispetto di tutti;
- nel lavorare in équipe e mantenersi in un continuo processo di formazione come educatori.
Il servizio dell’animazione si svolge all’insegna del volontariato e della gratuità. Se per qualche impegno più oneroso o professionale, soprattutto in relazione ad attività di associazioni civilmente riconosciute presenti nell’Oratorio, conviene un compenso economico o un contratto di lavoro, sia fatto sempre secondo la legge e con assoluta trasparenza, procurando di viverlo sempre nello stile del volontariato.
d. Il Consiglio dell’Oratorio
I ruoli d’animazione descritti si uniscono in organismi. Tra questi consideriamo importante il Consiglio dell’Oratorio-Centro Giovanile o Consiglio della CEP dell’Oratorio ( Cf. CG24, 161).
La sua composizione e il suo funzionamento ubbidiscono a schemi e criteri dinamici, ma anche di continuità, secondo gli orientamenti dell’Ispettore con il suo Consiglio ( CG24, 171).
I suoi compiti saranno dunque:
- promuovere e verificare il piano pastorale annuale secondo le richieste emergenti della condizione giovanile e gli orientamenti del PEPS;
- coordinare le varie proposte educative delle associazioni e dei gruppi, e curare l’armonizzazione e l’integrazione tra i vari momenti di promozione umana, di evangelizzazione e catechesi, di celebrazione liturgica e di impegno caritativo e missionario;
- favorire l’associazionismo salesiano, lo scambio d’informazione e il coordinamento tra i diversi gruppi e associazioni;
- mantenere un rapporto stretto con il territorio e con tutti quelli che lavorano per l’educazione dei giovani, favorendo interventi e proposte idonee alle situazioni di emarginazione e rischio e d’indifferenza religiosa;
- aiutare la crescita religiosa e “professionale” di tutti i membri della CEP attraverso una sistematica formazione.
All’interno e in dipendenza dal Consiglio si possono costituire gruppi o commissioni con l’incarico specifico dei grandi settori di attività. Tra queste è importante la commissione pastorale e la commissione economica
3. LA PROPOSTA EDUCATIVO-PASTORALE
La proposta che offriamo nell’Oratorio-Centro Giovanile offre ai giovani la possibilità di fare una autentica esperienza di vita giovanile che li aiuti a conoscere con piacere il mondo e a giudicarlo alla luce del Vangelo, a prendere coscienza sempre più precisa di sé, degli altri, dell’essere uomini tra uomini nella società e nella Chiesa; a vivere con vivacità la propria giovinezza e a costruire un progetto di vita ispirato al Vangelo. Tale proposta si attua con un itinerario centrale e con itinerari specifici a seconda degli interessi dei giovani, per cui ogni giovane, tramite le diverse possibilità di partecipazione agli interventi che si offrono, può situarsi nell’itinerario secondo il proprio livello di crescita.
3.1 Contenuto della proposta
Questa proposta si concretizza in tre aspetti complementari:
3.1.1 La convocazione giovanile
Il primo elemento della proposta dell’Oratorio-Centro Giovanile Salesiano è la sua capacità d’interessare i ragazzi e i giovani per fare emergere in loro il senso dell’umano, aiutare il sorgere delle domande, far emergere quanto di religioso porta in sé il giovane, per tradizione, ambiente o famiglia.
Questa convocazione si fa attraverso:
° un ambiente aperto e ricco di proposte e attività secondo i diversi interessi dei giovani;
° lo sforzo degli animatori per farlo conoscere e per invitare;
° l’accoglienza personale e l’aggancio ad un gruppo che permetta loro una partecipazione attiva
° la ricerca dell’incontro e il dialogo personale.
3.1.2 Un cammino educativo
Questa convocazione giovanile apre a una proposta di creatività personale e libera e di socializzazione che sviluppi le risorse positive delle persone e gruppi, promuova un processo di crescita nelle diverse dimensioni della persona secondo i valori della Spiritualità Salesiana.
Questa esperienza suppone:
° una proposta multipla e varia ( sportiva, ricreativa, culturale, sociale...) che ricopre gli aspetti più significativi della vitalità e del processo evolutivo del giovane;
° la partecipazione alla programmazione, realizzazione e revisione delle attività della comunità oratoriana, attraverso diversi gruppi e commissioni;
° la graduale e reciproca conoscenza, la stima vicendevole, la capacità d’incontro e condivisione;
° esperienze di solidarietà e di servizio gratuito agli altri, proporzionate all’età ed evoluzione;
° momenti di formazione attorno alle esperienze della stessa vita quotidiana, su temi educativi, culturali o sociali significativi.
3.1.3 Un processo di evangelizzazione
Lo sviluppo di questo cammino si apre ad una proposta di fede, che conduca ad un incontro personale con Cristo e si sviluppi in un itinerario di crescita nella fede, verso la ricerca dell’identità cristiana, secondo la Spiritualità Giovanile Salesiana e l’opzione vocazionale.
Questa proposta evangelizzatrice deve essere:
° missionaria, secondo il livello dei più lontani, che risvegli l’interesse e la voglia di fare cammino,
° positiva, fatta a partire dalla vita, secondo le aspirazioni e bisogni dei giovani;
° ricca e svariata, in proporzione alle possibilità e ai ritmi di maturazione;
° consistente e impegnativa, verso una crescita sistematica e progressiva, fino ad una opzione vocazionale cristiana.
3.2 Mediazioni fondamentali
° Il gruppo
L’Oratorio-Centro Giovanile salesiano fa la scelta della vita di gruppo e dell’associazionismo salesiano come una esperienza educativa fondamentale.
Offre una proposta articolata di gruppi e associazioni molteplici secondo gli interessi giovanili attorno ai quali si organizzano: gruppi spontanei dove prevalgono i leaders naturali e gli interessi immediati, e gruppi proposti con una loro specifica strutturazione ed itinerario formativo (gruppi sportivi, d’impegno culturale, sociale, di formazione e di approfondimento religioso, di sensibilizzazione missionaria, di animazione interna, ecc. …).
In questi gruppi favoriamo:
- la crescita del senso di appartenenza all’ambiente unitario della CEP dell’Oratorio e al Movimento Giovanile Salesiano;
- l’apertura dagli interessi più immediati e superficiali a interessi più profondi fino assumere un impegno di servizio agli altri tanto all’interno come verso l’esterno;
- l’accettazione e valutazione delle esperienze di vita dello stesso gruppo e dell’ambiente, fino a suscitare la ricerca di nuove esperienze che aiutino ad approfondire gli interrogativi religiosi e la domanda di senso;
- un processo di formazione sempre più sistematico ed esplicitamente cristiano;
- l’associazionismo tra i gruppi per crescere nella capacità di creare aggregazione, crescere nella solidarietà, produrre e diffondere una propria cultura in dialogo e confronto con altre culture presenti nel territorio, partecipare alla vita civile al servizio della gioventù. A tutti i gruppi si propone di coordinarsi nel Movimento Giovanile Salesiano.
° Le attività
L’attività è il momento specifico dell’Oratorio-Centro Giovanile, come le ore d’insegnamento lo sono nel campo scolastico.
L’attività è il anche il nesso di comunicazione tra il gruppo e il “più grande numero”. Il primo prepara, propone, assicura la permanenza e la progressività; la massa partecipa, si arricchisce, matura.
In ciascuna attività cerchiamo di:
- rispondere ad una necessità della vita dei giovani, scoprendo e sviluppando le loro intrinseche possibilità educative;
- stabilire obiettivi formativi secondo il PEPS dell’Oratorio-Centro Giovanile, privilegiando quelle di maggior contenuto e ricchezza;
- coordinarla ed aprirla agli altri ambienti e realtà del territorio per non perdere la visione dell’insieme.
Tra queste le attività più ricorrenti nell’Oratorio-Centro Giovanile sono il gioco e lo sport, tanto quello spontaneo come quello organizzato; ma non meno rilevanti devono essere quelle della musica e del teatro, i campeggi e il turismo giovanile, i campiscuola o di lavoro, ecc. ...
E’ importante che tutte queste attività si inseriscano nell’insieme della vita dell’Oratorio-Centro Giovanile, siano coordinate e favoriscano momenti e incontri comuni.
° Esperienze di servizio e di solidarietà
Pensiamo che le possibilità dell’Oratorio-Centro Giovanile si allargano attraverso la prestazione dei servizi richiesti dalla maturazione dei giovani e dalle domande del quartiere: assistenza scolastica, orientamento vocazionale o professionale, corsi serali, consultori, iniziative sociali al servizio del territorio, ecc...
Questi servizi rispondono
- alle necessità dei più bisognosi,
- all’ispirazione evangelica e alla specificità salesiana nei contenuti e nelle modalità d’intervento,
- alle possibilità concrete del personale che presta i suddetti servizi.
Suggerimenti bibliografici per l'approfondimento
FLORIS F. - DEL PIANO M., L'Oratorio dei giovani. Una proposta di animazione, LDC, Leumann (Torino), 1992.
VECCHI J., (a cura di) voce Oratorio in ISTITUTO DI TEOLOGIA PASTORALE, Dizionario di Pastorale Giovanile, LDC, Roma 1989, pp.615-621.
II. LE SCUOLE E I CENTRI PROFESSIONALI SALESIANI
1. L’ORIGINALITÀ DELLE SCUOLE E DEI CENTRI PROFESSIONALI SALESIANI
1.1 I salesiani nella scuola
La scuola salesiana nasce nell’Oratorio di Valdocco per rispondere alle necessità concrete dei giovani e s’inserisce in un progetto globale di educazione e di evangelizzazione dei giovani, soprattutto i più bisognosi.
Il settore scuola si è sviluppato molto nella Congregazione in risposta alle esigenze degli stessi giovani, della società e della Chiesa, fino a diventare un movimento di educatori saldamente attestati sul fronte scolastico.
Consideriamo la scuola come una mediazione culturale privilegiata di educazione in cui si può dare una risposta sistematica ai bisogni dell’età evolutiva; come una istituzione determinante nella formazione della personalità, perché trasmette una concezione del mondo, dell’uomo e della storia (Cf. SC 8); e come una delle forme più importanti di promozione umana e di prevenzione dell’emarginazione.
Riconosciamo il valore fondamentale della scuola come ambito dove il Vangelo illumina la cultura e si dà una efficace integrazione tra il processo educativo e il processo di evangelizzazione. Questa integrazione costituisce un’alternativa educativa importante nell’attuale pluralismo della società.
Ci inseriamo nel movimento che educa ed evangelizza attraverso la scuola, apportando il patrimonio pedagogico ereditato da S. Giovanni Bosco e accresciuto dalla tradizione susseguente ( Cf. CG21 130).
In questo impegno, l'attuale realtà socio-politica e culturale, i nuovi orientamenti di rinnovamento scolastico nei diversi Stati e la stessa realtà interna delle scuole, l’attuale presenza comune di ragazzi e ragazze, con un intreccio di molti, e talvolta divergenti, elementi legali, finanziari, lavorativi, didattici, ecc. ... presentano nuove e complesse difficoltà e sfide alle quali, nei diversi luoghi in cui ci troviamo, stiamo cercando di rispondere con una maggiore qualità educativa, con professionalità e significatività, fedeli alla nostra identità carismatica.
1.2 I Salesiani nei Centri Professionali (CFP)
Come la scuola, i CFP nascono nell’oratorio di Valdocco: Don Bosco, nella sua opzione educativa pastorale per i giovani bisognosi, ha una grande preoccupazione per il mondo del lavoro e i suoi problemi più urgenti (immigrazione dei giovani nella città, impreparazione per il lavoro industriale, sfruttamento, abbandono…). Molto presto organizza nell’Oratorio piccoli laboratori che poi diventeranno le Scuole di “arti e mestieri” e, con Don Rua, nascono le Scuole Professionali. Allo stesso tempo aiuta i giovani nella ricerca del lavoro procurando loro contratti di lavoro, per evitare che siano sfruttati. Con la vocazione e presenza del Salesiano Coadiutore, questo servizio e preparazione sarà arricchito.
La formazione professionale diventa patrimonio della Congregazione Salesiana e una delle richieste più sentite nella società. Attualmente abbiamo una grande varietà di Scuole e Centri di formazione professionale formali e non formali.
Come Don Bosco, i Salesiani sono convinti che con questo tipo di opera aiutano i giovani degli ambienti popolari non solo a prepararsi ed inserirsi creativamente nel mondo del lavoro, ma anche nella loro crescita integrale. In questo modo favoriscono una visione umana ed evangelica del mondo del lavoro stesso.
La nostra società tecnologica in continuo progresso, e la realtà interna di questi centri, ci presentano alcune difficoltà e sfide di indole tecnica, finanziaria, legale e pedagogica, alle quali dobbiamo rispondere coraggiosamente con una maggiore qualità educativa, fedeli alla nostra identità carismatica.
1.3 Aspetti fondamentali delle scuole e dei CFP salesiani
Le Scuole e i CFP salesiani sono due strutture di formazione sistematica con caratteristiche proprie, ma sempre in profondo rapporto. Non c’è vera scuola salesiana che non avvia al lavoro, né c’è vero CFP salesiano che non tenga conto dell’assimilazione sistematica della cultura. I principali aspetti caratteristici di questi centri educativi si possono esprimere cosi:
1.3.1 Centri che offrono un’educazione efficiente e qualificata
Offrono una proposta educativa-culturale di qualità,
- privilegiando l’aspetto educativo su quello meramente di istruzione;
- con una attenzione continua e critica ai fenomeni della cultura e della comunicazione sociale;
- con una impostazione pedagogico-metodologica processuale, che favorisca l’interazione educativa superando impostazioni didattiche ripetitive;
- dove i giovani sono il centro e le loro domande un punto di riferimento; li orientano e accompagnano verso il loro progetto di vita;
- offrendo una visione umana ed evangelica del lavoro;
- con una qualificazione professionale e di identità salesiana in continuo aggiornamento.
1.3.2 Centri ispirati ai valori evangelici, con una proposta di crescita nella fede
Hanno una chiara identità cattolica, espressa soprattutto nella testimonianza degli educatori, nel progetto, nel suo funzionamento interno e nel confronto con altri progetti e istituzioni educative (Cf. SC 66).
Offrono una proposta educativa pastorale aperta ai valori degli ambienti plurireligiosi e pluriculturali, che:
- impostano tutta la loro attività alla luce della concezione cristiana della realtà, di cui Cristo è il centro (Cf. SC 33);
- orientano i contenuti culturali e la metodologia educativa secondo una visione di umanità, di mondo, di storia ispirati al Vangelo (Cf. SC 34);
- promuovono l’apertura e l’approfondimento dell’esperienza religiosa e trascendente;
- ripensano il “messaggio evangelico”, accettando l’impatto del linguaggio e gli interrogativi della cultura.
Favoriscono la costituzione di una comunità di fede, che sia l’animatrice del processo di evangelizzazione (Cf. SC 53).
Si mantengono in comunione con la Chiesa e attuano creativamente i suoi indirizzi.
1.3.3 Centri portatori dello spirito e pedagogia salesiana:
La scuola e i CFP salesiani raggiungono le loro finalità con lo stile, lo spirito e il metodo educativo di Don Bosco (CG21 131):
- animati, orientati e coordinati nello stile oratoriano;
- cercano di creare una famiglia educante, centrata sui giovani, che trovano in essi la “loro casa” (Cost. 40);
- sottolineano la personalizzazione dei rapporti educativi, fondati sulla fiducia, il dialogo, la gioia e la responsabilità;
- assumono l'integralità della vita dei giovani, rendendo partecipi gli educatori degli interessi giovanili, promuovendo attività del tempo libero come il teatro, lo sport, la musica, l’arte;
- educano evangelizzando ed evangelizzano educando, cioè armonizzano, in unità inscindibile, sviluppo umano e ideale cristiano;
- preparano ad affrontare degnamente la vita familiare, di lavoro, sociale, ecclesiale...
Il vissuto di questi aspetti offre un tratto molto tipico e differenziante dei nostri centri educativi salesiani.
1.3.4 Centri con una consapevole funzione sociale:
Le nostre scuole e i CFP si propongono di contribuire alla costruzione di una società più giusta e degna dell’uomo:
° promovendo una sistematica formazione sociale dei loro membri;
° privilegiando la formazione professionale dei giovani e l’accompagnamento nel loro inserimento nel mondo del lavoro;
° diventando centri di animazione e di servizi culturali ed educativi per il miglioramento dell’ambiente; si privilegiano quei curricoli, specializzazioni e programmi che rispondono alle necessità dei giovani della zona ( Cf. CG21, 129,131);
° adoperando uno stile di vicinanza e di solidarietà attraverso la disponibilità delle persone e dei locali, l’offerta di servizi di promozione aperti a tutti, la collaborazione con altre istituzioni educative e sociali;
° promuovendo modelli culturali alternativi: una cultura centrata nella vita, aperta alla gratuità e alla comunione; una cultura che favorisca l’apertura a Dio.
1.3.5 Centri di educazione popolare aperti ai più bisognosi
“La scuola salesiana sia popolare per la sua collocazione, per la cultura e gli indirizzi che privilegia e per i giovani che accoglie. Organizzi servizi alla popolazione della zona, come corsi di qualificazione professionale e culturale, di alfabetizzazione e di ricupero, fondi per borse di studio e altre iniziative” (R. 14). Per questo le nostre scuole e i CFP:
- cercano di ubicarsi nelle zone più popolari e danno preferenza ai giovani più bisognosi;
- evitano ogni condizione discriminatoria o realtà di esclusione;
- richiedono disponibilità e apertura ai valori che il PEPS propone;
- privilegiano il criterio della promozione di tutti su quello della selezione dei migliori;
- cercano di creare le condizioni “economiche” che rendano possibile l’uguaglianza di opportunità.
2. LA CEP NELLE SCUOLE E NEI CFP SALESIANI
La realizzazione del PEPS nella scuola e nei CFP salesiani richiede la convergenza delle intenzioni e delle convinzioni da parte di tutti i suoi membri ( Cfr. SC 59). Indirizzano i loro sforzi alla formazione della CEP, che sia allo stesso tempo soggetto e ambiente di educazione.
2.1 Compiti della CEP nella scuola e nei CFP salesiani
In questi anni si cerca di passare da un modello istituzionale a un modello comunitario; da una delega educativa in alcune persone specialmente consacrate ad esso ( religiosi, professori...) ad un impegno attivo di tutti quelli che sono interessati nel fatto educativo. La CEP è il nuovo soggetto della responsabilità educativa.
Nel capitolo sulla CEP si sono presentate le caratteristiche e dinamismi generali; adesso sviluppiamo le caratteristiche proprie della CEP delle scuole e dei centri professionali salesiani.
• Curare la professionalità educativa attraverso una accurata formazione permanente
La CEP della scuola e dei CFP deve armonizzare la necessaria professionalità e formalità della struttura scolastica con il carattere familiare tipico dello stile salesiano.
Questo comporta:
- promuovere tra tutti i suoi componenti la condivisione dei valori educativi espressi nel PEPS; dal consenso sui valori umani di base procedere, per via di confronto e approfondimento, verso i valori e gli obiettivi più esplicitamente cristiani;
- assicurare una progettazione e programmazione elaborata, condivisa e valutata con la partecipazione di tutti;
- curare un processo sistematico di formazione permanente di tutti i membri della CEP, per aggiornare le loro competenze educative, didattiche e salesiane e sviluppare la loro vocazione educativa e cristiana;
- assicurare il buon funzionamento dei diversi organismi, determinando i compiti specifici e lo spazio di intervento decisionale delle diverse componenti della comunità educativa, curando la valutazione e il rispetto delle diverse competenze e funzioni.
• Animare processi educativi sistematici, attraverso:
- una adeguata pedagogia e progettazione dell’azione educativa;
- uno stretto rapporto tra obiettivi educativi, didattici, e pastorali;
- una revisione costante della coerenza educativa dei contenuti delle singole discipline e aree culturali;
- la qualificazione della metodologia dell’insegnamento e del lavoro educativo;
- l’offerta di un orientamento professionale e personale di qualità;
- una verifica sistematica dei risultati educativi ottenuti alla luce degli obiettivi previsti nel PEPS.
• Favorire uno stile di relazioni secondo il Sistema Preventivo, che promuova:
- Una informazione adeguata e regolare tra i diversi settori e livelli della CEP;
- la presenza-assistenza degli educatori tra i giovani, favorendo la partecipazione degli adulti alle attività dei giovani;
- rapporti ispirati alla fiducia e al dialogo tra educatore e giovane, tra direzione e settori, tra servizi pedagogici e utenti, nelle attività di docenza ed educative;
- una gestione giusta, efficiente, efficace e sempre attenta ai bisogni delle persone.
• Sviluppare un rapporto specifico con i genitori e le famiglie dei giovani:
- favorendo la loro collaborazione nella determinazione dell’indirizzo educativo generale, nel sostegno economico e materiale della scuola e nella valutazione sulla sua efficacia;
- promuovendo un processo sistematico di formazione e di abilitazione educativa;
- assicurando momenti di dialogo e confronto tra loro e gli altri membri della CEP.
• Concretizzare criteri e strategie per affrontare la complessità di situazioni legali, economiche, di rapporto con lo Stato, ecc. ... che possono condizionare la realizzazione del progetto educativo pastorale salesiano.
• Inserirsi attivamente nel dialogo culturale, educativo e professionale in atto nel territorio e nella Chiesa locale:
- cercando di essere sempre propositivi;
- assicurando un sistematico contatto con il mondo delle imprese, per facilitare un inserimento giusto dei giovani nel mondo del lavoro e un loro accompagnamento educativo.
• Accompagnare i giovani oltre la formazione sistematica, promuovendo processi specifici di presenza significativa nella vita degli Ex-allievi.
2.2 Strutture di partecipazione e di responsabilità
Le strutture mirano a creare le condizioni per una sempre maggiore comunione, condivisione e collaborazione tra le diverse componenti della CEP, al servizio della formazione culturale e professionale, umana e cristiana dei giovani.
Queste strutture variano secondo i Paesi e le loro diverse legislazioni scolastiche; per questo, ogni Ispettoria deve definire le modalità concrete delle strutture e responsabilità più convenienti, ma si devono sempre tenere in conto:
° Il direttore della comunità salesiana, che secondo la nostra identità carismatica è nella CEP il primo promotore dell’unità e dell’identità salesiana (CG24, 172).
° Il coordinatore pastorale, che insieme ad un’équipe, anima l’azione evangelizzatrice curando la sua profonda integrazione nel processo didattico ed educativo;
La funzione del Consiglio della CEP - richiesta dal CG 24, 171 - può essere realizzata da qualcuno degli organismi già esistenti, secondo gli orientamenti dell’Ispettoria.
3. LA PROPOSTA EDUCATIVA PASTORALE NELLE SCUOLE E I CFP SALESIANI
3.1 La Dimensione educativa culturale, punto di riferimento
La dimensione educativa culturale, impostata sulla prospettiva dell’evangelizzazione, è il nucleo della proposta educativa pastorale delle scuole e dei CFP; essa richiede:
° Formare la persona dal di dentro, liberandola dai condizionamenti interiori che potrebbero impedirle di vivere pienamente la sua vocazione, ed abilitandola per un’espansione delle sue capacità creative e per una sana affettività;
° Fondare la loro azione didattica su una particolare concezione della persona umana, che:
- matura la coscienza attraverso la ricerca della verità e l’adesione interiore ad essa;
- sviluppa la libertà responsabile e creativa attraverso la conoscenza e la scelta del bene;
- cresce nella capacità di relazione, solidarietà e comunione con l'umanità, basate sul riconoscimento della dignità della persona;
- si abilita alle responsabilità storiche, fondate sul senso della giustizia e della pace.
° Sottolineare e sviluppare l’aspetto etico e religioso della persona, aprendo così al trascendente e disponendo a ricevere il messaggio originale di Cristo.
° Realizzare una mediazione culturale, capace di mettere a confronto le aspirazioni e le situazioni che oggi vivono i giovani con le esperienze dell’umanità, espresse nel patrimonio culturale.
° Promuovere un cammino di educazione alla fede, attraverso la testimonianza comunitaria e la diversità di proposte.
3.2 Priorità della loro funzione educativo–culturale
La scuola salesiana e il CFP centrano la loro funzione culturale-educativa su queste priorità:
° Educare integralmente, più che istruire o trasmettere sapere.
° Offrire un sapere (i contenuti, valori, e significati, espressi nel curriculum che renda i giovani:
- consapevoli dei problemi del mondo d’oggi, in primo luogo quelli del loro ambiente, sensibili ai valori in gioco,
- costruttivamente critici riguardo alle giustificazioni e alle soluzioni che si prospettano,
- e capaci di costruire una concezione vitale di umanità, mondo, storia.
° Aiutare i giovani ad acquisire quelle capacità tecniche e professionali che li
rendano competenti ed efficaci nell’azione, specialmente il lavoro.
° Formare atteggiamenti o strutture relativamente stabili nella personalità dei giovani (autostima, socializzazione, partecipazione, autonomia, solidarietà, responsabilità, volontà...), che permettano loro di agire da uomini liberi e li orientino verso la comprensione critica della realtà e la comunione solidale con le persone, verso l’apertura al trascendente.
° Abilitare i giovani alla comprensione dei molteplici linguaggi, all’uso dei mezzi e delle forme di espressione su cui si fondano la comunicazione e la possibilità di arricchirsi del processo culturale, e di contribuire al suo sviluppo.
3.3 La prospettiva evangelizzatrice della scuola salesiana e i CFP
L’impegno educativo culturale della scuola e i CFP è ispirato al Vangelo e orientato verso l’evangelizzazione; questa proposta si esprime attraverso alcune priorità:
La scuola salesiana e i CFP cercano di aiutare il giovane a fare una sintesi tra fede e cultura.
Per questo, propongono un itinerario di apertura al trascendente e di educazione alla fede che:
- prende i giovani nella situazione in cui si trovano e si impegnano a sostenerli e orientarli a compiere i passi verso la pienezza di umanità a loro possibile;
- privilegia gli ultimi e i più poveri, con un linguaggio facile e immediato, con un ambiente accogliente e lo stile di rapporto familiare;
- si adegua al passo di ogni giovane, curando soprattutto i primi passi nelle diverse aree del cammino (Cf. CG23, 102-111).
Per quelli aperti alla fede cristiana, sviluppano un itinerario di crescita progressiva verso Cristo, l’uomo perfetto, secondo le quattro aree che ci propone il CG 23, cioè verso::
- la maturità umana;
- l’incontro autentico con Gesù Cristo;
- una intensa appartenenza ecclesiale;
- un impegno per il Regno (Cf. CG23, 112-116).
Per coloro che sono di altre religioni, offrono una proposta di accompagnamento nella crescita della religiosità e nella loro apertura al trascendente.
3.4 Principali interventi della proposta:
a. L’ambiente educativo:
Ci proponiamo di dare vita ad un ambiente comunitario scolastico permeato dello spirito evangelico di amore fraterno e libertà, in cui, prima ancora di averne chiara nozione, il giovane possa fare esperienza della propria dignità, e rendersi interlocutore cosciente di Dio (Cfr. SC 55), perché ne percepisce la presenza e l’azione attraverso la testimonianza e i segni cristiani.
Per questo occorre soprattutto:
- qualificare i rapporti educativi e creare un ambiente favorevole, fondato sulla ragionevolezza delle esigenze, sulla valorizzazione della vita quotidiana e sulla carità come metodo educativo di accompagnamento e crescita.
- curare le esperienze che intessono il quotidiano scolastico:
- i doveri di studio, di ricerca e di lavoro;
- l’incontro con le persone e la partecipazione alle iniziative comuni;
- la disciplina personale e quella richiesta dall’organizzazione scolastica;
- il rispetto e la cura degli strumenti, attrezzature e locali in cui si svolge la vita scolastica;
- il senso di appartenenza ad una CEP;
- esperienze di solidarietà e collaborazione di fronte a situazioni di disagio, emarginazione e ingiustizia.
b. Le attività didattiche e tecniche
I contenuti sistematici delle diverse discipline vengono offerti come conoscenze da acquisire, verità da scoprire, tecniche da dominare, interrogativi e valori da assimilare; a questo aiuta la chiarezza di contenuti, l’impostazione pedagogica, e soprattutto la concezione culturale che si offre.
Questo comporta:
° riorganizzare la massa d’informazioni intorno a certi nuclei, affinché emergano le domande fondamentali che la scienza e la cultura cercano di risolvere;
° confrontare costantemente le conoscenze acquisite con la percezione che i giovani hanno della realtà personale e sociale;
° mettere in rilievo il tipo di esperienza umana che sottostà alle diverse discipline, aiutando i
giovani a cogliere, apprezzare e assimilare i valori umani compresi nei fatti presentati e approfonditi;
° accettare e far sorgere delle domande di senso, e portarle al limite della riflessione possibile;
° aprire alla cultura universale, mettendo in contatto con le espressioni dei diversi popoli e con il patrimonio di valori condivisi dall’umanità.
c. Il metodo didattico-educativo
Scegliamo come metodo la personalizzazione delle proposte e la collaborazione vicendevole. Quindi:
. adottiamo una didattica attiva, che sviluppi negli allievi la capacità di scoperta e faccia maturare abiti di creatività e di crescita culturale autonoma;
. favoriamo un’opportuna complementarità e integrazione tra lavoro personale e lavoro di gruppo;
. promuoviamo l’interdisciplinarità attraverso la quale le diverse scienze offrono apporti complementari;
. valutiamo non solo i risultati finali, ma soprattutto il processo di sviluppo umano in atto, la capacità d’imparare e di ricerca verso una crescita culturale autonoma;
. adoperiamo il più possibile il linguaggio totale (parola, immagine, suono, audiovisivo, espressione corporale, ecc. ...) all’interno di un processo di interazione comunicativa.
d. L’orientamento verso la professionalità
Consideriamo importante mettere nella scuola, e ancor più nei CFP, le radici da cui si svilupperà la professionalità. Tutto deve guidare allo svolgimento del proprio lavoro con crescente competenza e con reale soddisfazione, con il senso dei limiti e il rispetto dei compiti degli altri, nella consapevolezza della complementarità del lavoro d’insieme e della sua importanza per la crescita sociale.
e. L’evangelizzazione del sapere, della tecnica e dell’azione educativa
La scuola salesiana e i CFP cercano di stabilire un dialogo vitale e un’integrazione tra sapere, educazione e Vangelo. Nella disparità di concezioni e prospettive, nella diversità di religioni, presentano il riferimento a Cristo e al suo Vangelo come il criterio di valutazione per discernere i valori che orientano la persona umana verso una vita piena.
Per questo:
. aiutano a scoprire la profonda coerenza tra la fede e i valori che la cultura persegue;
. rilevano la funzione del Vangelo nella cultura (elevare le espressioni autentiche, rigenerare e trasformare gli aspetti meno umani) e il valore della cultura riguardo al Vangelo (incarnare il messaggio evangelico, e aiutare la sua comprensione più profonda);
. aiutano a capire la realtà del lavoro e della tecnica secondo i valori del Vangelo;
. cercano di sviluppare la cultura come capacità di comunione, di servizio e di responsabilità verso gli altri, e non come mezzo di affermazione e arricchimento ( Cfr. SC 56);
. abilitano agli atteggiamenti che predispongono i giovani ad una comprensione vitale e ad una risposta favorevole al Vangelo.
f. L’insegnamento religioso:
L’insegnamento religioso rientra normalmente nei programmi scolastici, ed è considerato come un elemento fondamentale dell'azione educativa;
. aiuta i giovani a scoprire la dimensione religiosa della realtà umana, a cercare il senso ultimo della vita e ad orientarsi verso una scelta cosciente e libera di vivere con impegno e coerenza;
. offre una visione positiva e aperta della dottrina cristiana che facilita l’annuncio esplicito;
. promuove un dialogo critico e positivo con le altre aree della conoscenza e con le altre religioni;
. risveglia il desiderio di un’ulteriore educazione alla fede in seno alla comunità cristiana.
g . Le attività complementari, integrative, di sostegno e le proposte libere:
L’educazione integrale richiede di completare il programma scolastico con altre attività. La scuola salesiana e i CFP danno un ampio spazio alle attività del tempo libero e di cortile (artistiche, ricreative, sportive, culturali...), tendendo a diventare scuola a tempo pieno.
Tra queste attività di tempo libero troviamo alcune più dirette all’evangelizzazione, come:
° attività offerte a tutti di annunzio, di orientamento e di proposta, che cercano di seminare i valori evangelici in tutti i giovani;
. brevi incontri giornalieri predisposti per l’insieme o per gruppi ( “buongiorno”, ecc.);
. attività proposte nei tempi forti dell’anno liturgico e nella preparazione ai sacramenti (per esempio le celebrazioni);
. incontri e giornate di riflessione;
. attività proposte per quelli che desiderano approfondire:
. la preparazione ai sacramenti;
. giornate di riflessione;
. celebrazioni liturgiche con gruppi speciali...
° L’associazionismo: la scuola e i CFP salesiani danno spazio, favoriscono e accompagnano i diversi gruppi (di studio-ricerca, culturali, ricreativi, artistici, di servizio comunitario, di volontariato, di crescita cristiana, di orientamento vocazionale, di impegno cristiano...), trovando in loro una mediazione privilegiata di educazione ed evangelizzazione.
h . L’orientamento educativo e vocazionale
In tutti gli interventi educativi tendiamo a far maturare e vivere un progetto di sé realistico, orientato verso gli altri, che superi quanto aliena l’uomo dalla sua vocazione o lo riduca nelle sue dimensioni:
. riguardo alla vita affettivo-sessuale (stato di vita);
. alla collocazione professionale (lavoro);
. alla scelta socio-politica;
. al significato ultimo e totale dell'esistenza.
A questo aiuta l’ufficio-dipartimento di orientamento psicopedagogico e professionale.
Secondo il livello di fede e di età, la scuola aiuta a discernere i segni della chiamata di Dio ad un particolare stato di vita cristiana. E’ importante curare i giovani animatori e volontari.
Sebbene tutti gli educatori siano disponibili per il colloquio personale, ci saranno alcune persone più disponibili per questo dialogo; anche chi presta il servizio di psico-orientamento aiuterà in questo.
i. La progettazione educativa – didattica
Tutti gli elementi ed interventi detti precedentemente devono essere tradotti in un progetto (PEPS della scuola o CFP) realizzato e animato tramite una qualificata progettazione educativa – didattica di base, per una azione integrale e organica.
Suggerimenti bibliografici per l'approfondimento
CENTRO SALESIANO REGIONAL (a cura), Proceso educativo salesiano y culturas emergentes. Actas encuentro laitnoamericano de estudio. Cumbayá – Ecuador 15-25 mayo 1994, Gráficas modelo, Cayambe, 1994.
DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE SALESIANA- NANNI C. (ed.), Scuola salesiana e profezia in Europa. Atti del Convegno Europeo della Scuola salesiana, Editrice SDB, Roma 1996. L’opera scolastica salesiana, pp. 7-14. Documenti conclusivi, pp. 163-170.
VAN LOOY L. – MALIZIA G., Formazione professionale salesiana: Memoria e attualità per un confronto. Indagine di campo, Roma, LAS, 1997
In particolare si segnala:
Parte Prima:
Cap. 1: PRELLEZO J.M. (ed.), Dai Laboratori di Valdocco alle Scuole Tecnico-Professionali Salesiane. Un impegno educativo verso la gioventù operaia, o.c., pp.19-51.
Cap.2: MALIZIA G. - SARTI S. - PIERONI V., Il quadro teorico e l'indagine sul campo, o.c., pp. 53-92.
Parte Terza:
Cap.7: SARTI S., Il Sondaggio in Africa e Madagascar, o.c., pp.195-215.
Cap.8: CALIMAN G., Il Sondaggio sull'America, o.c., pp.217-236.
Cap.9: PURAYIDATHIL T., Il Sondaggio sull'Asia/Australia, o.c., pp. 237-259.
Cap.10: MALIZIA G. - PIERONI V., Il Sondaggio sull'Europa, o.c., pp. 261-279.
Parte quarta:
Cap11: VAN LOOY L., Un bilancio in prospettiva di futuro, o.c., pp.283-340.
VAN LOOY L. – MALIZIA G., Formazione professionale salesiana. Proposte in una prospettiva multidisciplinare, Roma, LAS, 1998
DOMENECH A., La Pastorale Giovanile Salesiana e il mondo del lavoro. ACG 368, settembre 1999.
ZANNI N., Educazione tecnica.. Formazione professionale, In FSE/UPS, Dizionario di Scienze dell’Educazione, LDC/LAS/SEI, Torino 1996, pp. 368-369; 438-440.
III. LA PARROCCHIA AFFIDATA AI SALESIANI
1. L’ORIGINALITA' DELLA PARROCCHIA SALESIANA
L’ansia apostolica di Don Bosco sempre viva nel cuore dei Salesiani, il rinnovato aspetto della Parrocchia come presenza territoriale della Chiesa e le necessità pastorali delle Chiese locali hanno portato la Congregazione ad aprirsi largamente al ministero parrocchiale. Nelle Costituzioni la Parrocchia è indicata esplicitamente tra le varie presenze in cui realizziamo la nostra missione, “rispondendo alle necessità pastorali delle Chiese particolari in quelle zone che offrono un adeguato campo di servizio alla gioventù e ai ceti popolari” (Reg. 15; Cf. Cost. 42). L’impegno dei Salesiani nel campo parrocchiale si esprime attraverso le parrocchie affidate alla Congregazione e le parrocchie missionarie. I Salesiani, inseriti in una chiesa particolare, offrono così nell'istituzione parrocchiale, con il loro carisma, un apporto originale e specifico.
1.1 La Parrocchia, presenza della Chiesa in un territorio
Il Concilio Vaticano II presenta la Chiesa, popolo di Dio, come:
° segno e strumento di comunione, convocata e radunata per iniziativa dello Spirito; unita per la fede in Gesù Cristo e per i Sacramenti; partecipa del dono della vita trinitaria nell’amore e del servizio nella vita comunitaria
° servizio, fermento del Regno nella storia umana, è inviata al mondo per annunciare Gesù Cristo come salvezza e farlo presente con le parole e con le opere;
° arricchita dei doni dello Spirito, in quanto i suoi membri, persone e gruppi, sono stati arricchiti dallo Spirito Santo con vocazioni, carismi e ministeri diversi e complementari, tutti al servizio della crescita del Corpo di Cristo nella storia e per la sua missione nel mondo ( Cf. CG24, 61-68).
La Parrocchia, espressione visibile di questa Chiesa, appare con queste caratteristiche:
- comunità di fedeli, animati da un solo Spirito, capace di fondere insieme tutte le differenze umane che vi si trovano e inserirle nell’universalità della Chiesa; comunità di fedeli che vive le diversità aperta a vari carismi, rispettando le diverse fasi e la varietà dei cammini nella crescita della fede; che si esprime e si realizza in modo speciale nella celebrazione dell'Eucaristia domenicale
. in una diocesi: cellula della Chiesa particolare, presieduta dai presbiteri a nome del Vescovo, in comunione con le altre parrocchie;
. territoriale: rende presente la Chiesa in un territorio concreto;
.con una missione globale: accompagna i fedeli nell’educazione e crescita della loro fede lungo tutta la loro esistenza;
.missionaria: è aperta all’evangelizzazione dei lontani e collabora con l’annuncio del Vangelo “ad gentes”;
. aperta al territorio: accoglie ogni persona, per il solo fatto che tutti sono creati da Dio a sua immagine e sono figli di Dio.
1.2 La Parrocchia affidata ai salesiani, presenza della Chiesa in un territorio, con il carisma salesiano
La Congregazione con il suo carisma giovanile e popolare apporta alla Chiesa locale uno stile caratteristico per animare e guidare una parrocchia. Le nostre Costituzioni, Regolamenti e i documenti del CG 20 e del CG 21 concentrano questo apporto in alcuni tratti che distinguano la parrocchia affidata alla Congregazione:
- per l’attenzione ai giovani, soprattutto ai più poveri. Questa scelta preferenziale è legata ad atteggiamenti più che a programmi, come una opzione e una dinamica presente in tutte le manifestazioni della comunità parrocchiale;
- ubicata in un ambiente popolare con adeguato campo di servizio (Reg.25 ; CG 21, 141; 407);
. animata da una comunità religiosa impegnata nella costruzione di una comunità cristiana vicina, accogliente, disponibile, che sia soggetto e ambiente della crescita umana e cristiana,
. e uno stile caratteristico di progetto pastorale che evangelizza educando ed educa evangelizzando secondo una specifica spiritualità e modalità pedagogica (Sistema Preventivo) e così curi l’integrazione di evangelizzazione e promozione umana.
- con impegno pastorale che consideri l’Oratorio e il Centro Giovanile come parte integrante del progetto pastorale;
- con rafforzamento di una catechesi sistematica per tutti
- con favoreggiamento dello sviluppo della vocazione di ogni persona
- con la ricerca missionaria dei lontani, particolarmente i giovani più bisognosi, nei loro ambienti e luoghi di ritrovo. (Cf. Reg. 26).
2. LA PARROCCHIA-COMUNITÀ ( LA CEP DELLA PARROCCHIA)
La Parrocchia ha come specifico di essere “porzione” della Chiesa universale in un preciso territorio: è il volto della Chiesa che la gente incontra vicino alla propria casa, là dove vive; è la comunità di fedeli. Perciò “Quando i Salesiani sono chiamati dal Vescovo alla cura pastorale di una zona (...), assumono, di fronte alla Chiesa, l’esaltante impegno di costruire - in piena corresponsabilità con i laici - una comunità di fratelli, riuniti nella carità, per l’ascolto della Parola, la celebrazione della Cena del Signore e per l’annuncio del messaggio di Salvezza” (CG20, 416)
Questa è anche una delle caratteristiche fondamentali della Pastorale Salesiana, la corresponsabilità comunitaria e la costruzione della comunità (Cf. Cost.35; 44; 47).
2.1 Alcuni criteri
° Vivere la Parrocchia come comunità di comunità presuppone un tessuto di relazioni umane autentiche e coinvolgenti; come una casa di incontro e di dialogo, piuttosto che come una struttura di servizi religiosi.
° Vivere la Parrocchia implica essere in comunione con Cristo; è il luogo in cui viene celebrata la fede vissuta e condivisa.
° Vivere la Parrocchia vuol dire essere in comunione con molte persone sia al suo interno che verso l’esterno.
Questo comporta:
- realizzare le diverse iniziative cercando la comunione delle persone per costruire il Regno;
- vivere questa comunione presenti nel mondo, come segno e fermento per la comunità umana e di trasformazione del Regno.
- pensare la sua organizzazione promuovendo la corresponsabilità di tutti quelli che hanno accolto la fede, al servizio dei quali si collocano i ministeri;
- collegare con altre “agenzie" sociali ed educative presenti in loco
2.2. Elementi di questa opzione comunitaria
° L'esperienza e la testimonianza di vita fraterna della comunità religiosa salesiana come segno significativo del Vangelo è una forza straordinaria per la costruzione della comunione parrocchiale.
° La comunità salesiana nel nucleo animatore della comunità cristiana parrocchiale s'impegna a costruire, stimolare, rendere visibile la comunità dei fedeli nell’annuncio della Parola, nella celebrazione dei Sacramenti e nel servizio alla fraternità. In questo sforzo di animazione della comunità cristiana è fondamentale la formazione dei laici, fino a far diventare la Parrocchia un centro di formazione cristiana dei laici.
° L’articolazione della comunità parrocchiale in gruppi e comunità minori nelle quali si dia una maggiore comunicazione, un impegno più intenso, una più reale partecipazione e una relazione visibile tra tutti questi gruppi e la comunità. In questo senso, promuovere l’associazionismo ecclesiale con una speciale attenzione alla Famiglia Salesiana e al Movimento Giovanile Salesiano.
° Una programmazione e realizzazione comunitaria della missione, attraverso:
- un progetto pastorale unitario e organico (progetto parrocchiale);
- elaborato, realizzato e verificato con la partecipazione attiva di tutti, attraverso i Consigli e le Assemblee.
° L’apertura a tutti e l’inserimento nel territorio per potenziare la comunione nella comunità umana della zona .
2.3 Responsabilità e Strutture
2.3.1 Alcuni criteri
° Unità organica della pastorale parrocchiale
La Parrocchia accoglie il Popolo di Dio con la sua variegata ricchezza di vocazioni, carismi e ministeri. Promuove lo sviluppo e la comunione di tutti questi al servizio della missione.
La Parrocchia salesiana arricchisce questa comunione con l’apporto del proprio carisma. La Spiritualità Giovanile Salesiana e il Sistema Preventivo di Don Bosco devono orientare e caratterizzare la convergenza dei diversi carismi e servizi presenti in essa.
° Comunità corresponsabile
Le strutture devono facilitare e promuovere la partecipazione corresponsabile di tutti i fedeli nella missione comune espressa nel Progetto pastorale;
Devono anche potenziare la comunione operativa di tutti e la convergenza e complementarità delle persone, interventi e strutture attorno a questo progetto pastorale condiviso.
° Unità del progetto salesiano nel territorio e nella Chiesa locale
La Parrocchia salesiana, quando è presente nel territorio insieme con altre opere salesiane ( Oratorio-Centro giovanile, Scuola, convitto, ecc. ...), promuove con esse una speciale condivisione, collaborazione e dialogo per realizzare insieme una pastorale unitaria che sviluppi nel territorio l’unica missione salesiana.
° Apertura alla Chiesa locale e all’Ispettoria
La Parrocchia salesiana vive la sua presenza e la sua azione pastorale nella Chiesa a partire dal proprio carisma. Il servizio parrocchiale aiuta i Salesiani a sperimentare con maggior intensità l’appartenenza e i legami con la Chiesa locale; ma allo stesso tempo offre una collaborazione specifica, arricchita dalla specificità del carisma salesiano e della predilezione per i giovani.
Per questo la Parrocchia salesiana deve fare riferimento tanto alle linee pastorali della diocesi come al PEPS dell’Ispettoria.
2.3.2 Principali responsabilità e strutture
a. “La Parrocchia salesiana ha come responsabile e animatrice la comunità religiosa” (CG21, 138). La Parrocchia è affidata il primo luogo alla comunità religiosa salesiana. Questa comunità dunque, riconoscendo la responsabilità che il Codice di Diritto Canonico conferisce al parroco:
° assume gli orientamenti della pastorale diocesana inserendo in esse la ricchezza del proprio carisma pastorale;
° promuove l’elaborazione e attuazione del PEPS nella Parrocchia;
° si fa responsabile, insieme al Parroco, della formazione e animazione spirituale dei fedeli e degli laici con missione pastorale;
° orienta i membri della Famiglia Salesiana , in particolare i Cooperatori, ad essere i primi collaboratori del Parroco.
b. Il Direttore della comunità salesiana ha una responsabilità specifica, in quanto primo responsabile delle attività apostoliche della comunità: cura l’unità e l’identità salesiana della comunità e stimola la corresponsabilità dei confratelli nella realizzazione del Progetto pastorale parrocchiale (Reg. 29). Per questo è membro del Consiglio pastorale della Parrocchia.
c. Il Parroco è il responsabile immediato della missione parrocchiale affidata dal Vescovo alla Congregazione Salesiana. Per il suo popolo rappresenta il Vescovo, ma allo stesso tempo rappresenta la Congregazione.
Cura la formazione della comunità parrocchiale, la presiede e ne ha la diretta responsabilità.
In comunione con il Direttore e con la comunità salesiana promuove nel progetto pastorale della Parrocchia le caratteristiche salesiane.
d. Il Consiglio pastorale, segno espressivo della comunione e partecipazione nella Parrocchia, assume d’accordo con i compiti prescritti dal Codice di Diritto Canonico e dagli orientamenti della Chiesa locale, la funzione che il CG 24 assegna al Consiglio della CEP o dell'opera ( CG 24, 160. 171).
e. Diverse commissioni e consulte che animano secondo il PEPS parrocchiale le diverse aree di attività; tra queste ha una speciale importanza la commissione o équipe animatrice della Pastorale Giovanile, coordinata normalmente sia dal vicario della Parrocchia sia da un Salesiano/laico, direttore dell’Oratorio-Centro Giovanile (CG20, 432).
f. L’Assemblea parrocchiale, espressione del senso di comunità cristiana e di corresponsabilità, è espressione della realizzazione della CEP nella Parrocchia.
3. LA PROPOSTA EDUCATIVO-PASTORALE DELLA PARROCCHIA SALESIANA
3.1 La Parrocchia Salesiana: centro di evangelizzazione e di educazione alla fede
Sviluppare una pastorale di evangelizzazione vuol dire contribuire “alla diffusione del Vangelo e alla promozione del popolo” (Cost.42), non accontentandosi della semplice accoglienza delle persone e della celebrazione dei sacramenti, e farne un centro irraggiante del Vangelo.
3.1.1. Il suo significato
Nello sforzo di evangelizzare una zona, la Parrocchia salesiana assume un criterio e si ispira ad una scelta fondamentale: la fusione esistenziale tra “evangelizzazione - promozione - educazione”; annuncia il Vangelo e presenta la persona di Gesù dal di dentro dell’uomo e dall’interno dei problemi umani, come elemento di trasformazione e cambio delle situazioni meno umane verso la pienezza dell’uomo in Dio. La Parrocchia salesiana compie questa scelta fondamentale secondo “lo stile e lo spirito del nostro Progetto Educativo Pastorale”(CG 21, 140) che “è una ricca sintesi di contenuto e metodi; di processi di promozione umana e, insieme, di annuncio evangelico e di approfondimento della vita cristiana” (CG 21, 80), che diventa lo strumento operativo della Parrocchia.
3.1.2. Tratti qualificanti dell’evangelizzazione della Parrocchia salesiana
° Favorisce il processo di umanizzazione e di promozione delle persone e dell’ambiente:
- condivide le preoccupazioni e le aspirazione della gente e illumina cristianamente gli affari temporali e la vita quotidiana della comunità e del quartiere;
- stabilisce un stretto dialogo e collaborazione con le realtà e istituzioni educative sociali presenti nel territorio;
- promuove la formazione cristiana della coscienza e sviluppa nella comunità cristiana un atteggiamento di solidarietà e di impegno di fronte alle situazioni di povertà e di emarginazione;
° Offre una proposta di evangelizzazione, rivolta soprattutto ai lontani, e di catechesi:
- continuata e sistematica, con un itinerario di educazione alla fede secondo i diversi livelli, ma curando soprattutto la catechesi dei giovani e degli adulti (Cf. CG23, 116-157);
- incarnata, che cura d’illuminare con il Vangelo le diverse situazioni della vita (professione, famiglia, vita sociale, politica...);
- che inizia le famiglie all’educazione cristiana dei figli, a partire dalla catechesi battesimale.
° Promuove una vita liturgica e sacramentale che apra e approfondisca l’incontro personale e comunitario con Gesù Cristo:
- curando un processo di educazione alla preghiera e alla celebrazione cristiana;
- con una speciale attenzione agli elementi che favoriscono una vera esperienza di Dio;
- centrata nell’Eucaristia e nella Penitenza;
- favorendo la partecipazione piena dei fedeli;
- assumendo la vita della comunità umana e la sensibilità giovanile.
° Evidenzia i valori della Spiritualità Salesiana risaltando la sua dimensione laicale e giovanile (CG23, 158-161; CG24, 89-100).
° Cura l’orientamento vocazionale dei fedeli, specialmente dei giovani:
- orientando e accompagnando lo sviluppo della vita cristiana, con una attenzione speciale per qualificare le famiglie e i genitori come educatori dei figli;
- presentando a tutti le diverse vocazioni nella Chiesa, con un accenno speciale alla vocazione salesiana;
- accompagnando con speciale cura gli animatori e responsabili delle associazioni e movimenti, i giovani adulti e i fidanzati... nel cammino di maturazione della loro vocazione;
- facendo una proposta vocazionale specifica ai giovani più disponibili per la vita religiosa e sacerdotale e di ministero laicale.
- offrendo una proposta concreta di adesione a uno dei gruppi della Famiglia Salesiana(CG 24, 124).
° Promuove la formazione della comunità cristiana attraverso:
- una proposta associativa a tutti i fedeli, specialmente ai giovani,
- con pluralità di offerte,
- facilitando il loro protagonismo,
- e la qualità della vita del gruppo, nonché l’apertura al territorio.
3.2 La Parrocchia salesiana: una scelta prioritaria dei giovani
La Parrocchia esprime la totalità del popolo di Dio, che vive in un territorio. Tenendo presente una comunità completa di persone interdipendenti nella loro crescita umana e cristiana, la Parrocchia salesiana compie la scelta prioritaria dei giovani, specialmente dei più poveri.
3.2.1 Il suo significato
La preferenza per i giovani è in primo luogo un’ottica e una prospettiva che interessa tutta la comunità parrocchiale e la sua pastorale, che si esprime poi in diverse iniziative settoriali:
° una pastorale che sceglie la linea educativa curando in tutte le sue attività e programmi la maturazione integrale delle persone;
° una pastorale che promuove un atteggiamento di attenzione, avvicinamento e d’interpolazione con il mondo dei giovani;
° una pastorale che apre spazi alla partecipazione attiva dei giovani e favorisce l’incontro e il dialogo di essi con gli adulti.
3.2.2 Prospettive° Sviluppare nella comunità cristiana parrocchiale una attenzione speciale per il mondo dei giovani, un atteggiamento positivo e d’interesse e una migliore conoscenza dei loro concreti problemi di vita.° Rendere la Parrocchia un luogo d’incontro e di dialogo tra le generazioni e un punto di riferimento per la domanda religiosa e per la ricerca di senso.° Offrire ai giovani una proposta di educazione alla fede veramente missionaria
- che privilegi i più poveri e i lontani;
- adeguata al passo di ogni giovane;
- realizzata in comunità;
- verso la scoperta della propria vocazione e la maturità cristiana (Cf. CG23, 102-111).
3.2.3 Linee d’intervento
Quali risorse attivare in una Parrocchia salesiana per approssimarsi a questi obiettivi? Verso quale direzione orientare gli sforzi? Quali elementi promuovere e sviluppare?
° Una comunità salesiana con vocazione giovanile: la parrocchia salesiana non è un ritiro dal mondo giovanile, ma un'altra forma di essere presente tra i giovani. Vivere questo suppone nei SDB della comunità parrocchiale:
presenza positiva e cordiale nel mondo giovanile;
approfondimento sistematico con preoccupazione pastorale della realtà giovanile;
volontà e capacità di accoglienza e dialogo in incontri occasionali e sistematici.
° Una comunità parrocchiale con capacità di aprirsi ai giovani e di educarli. Questo implica:
favorire un clima di gioia e di ottimismo;
sviluppare una sistematica formazione cristiana degli adulti perché possano essere modelli di riferimento per i giovani;
offrire spazi, momenti e iniziative d’incontro e di dialogo tra giovani e adulti;
avere una attenzione speciale verso i giovani adulti e promuovere la loro formazione e corresponsabilità nella vita parrocchiale;
motivare, sostenere e capacitare per la missione educativa i genitori e altri educatori della comunità.
° Un ambiente giovanile di educazione e di evangelizzazione: l’Oratorio-Centro Giovanile
come luogo di accoglienza con un programma formativo concreto;
come luogo di irradiazione verso il territorio con iniziative missionarie di ricerca, incontro e dialogo con i lontani;
articolato organicamente con la pastorale parrocchiale.
° Gruppi e movimenti ecclesiali e comunità giovanili, soprattutto l’offerta del MGS:
pluralità di proposte all'interno del PEPS;
preoccupazione formativa ed evangelizzatrice;
attenzione speciale agli animatori.
° Apertura al territorio e alle loro diverse proposte di educazione ed evangelizzazione (scuole, grandi convocazioni giovanili, progetti sociali...) e ai nuovi spazi di socializzazione giovanile, collaborando con altre istituzioni educative e sociali.
Suggerimenti bibliografici per l'approfondimento
SCABINI P. (ed.), Parrocchia, in ISTITUTO DI TEOLOGIA PASTORALE - UPS, Dizionario di Pastorale Giovanile, o.c., pp. 654-667.
VIGANO' E., La Parrocchia salesiana come collaborazione alla pastorale della Chiesa particolare con la ricchezza di una vocazione specifica, in: La Parrocchia Salesiana come collaborazione alla pastorale della Chiesa particolare con la ricchezza di una vocazione specifica. Atti Convegno dei Parroci (Roma-Pisana 14-18 ottobre 1991; Como-Salesianum 20-24 ottobre 1991), Roma 1992, pp. 119-296.
IV. OPERE – SERVIZI SOCIALI PER GIOVANI IN SITUAZIONE DI RISCHIO
L’opzione per la gioventù povera, abbandonata e pericolante è stata sempre nel cuore e nella vita della Famiglia Salesiana, da Don Bosco fino ad oggi.
Questa ha realizzato dappertutto una grande varietà di risposte, di strutture e di servizi per i giovani poveri, seguendo la scelta educativa ispirata al criterio preventivo.
La nuova situazione delle nostre società ci sfida a nuove risposte. La povertà cresce sempre di più fino a presentare una dimensione tragica, che colpisce molte persone e comunità tra le quali moltissimi giovani, fino a divenire una realtà strutturale e globale. Possiamo parlare anche di “nuove povertà” e quindi di “nuove forme di emarginazione – esclusione sociale” tra le quali ci colpiscono in modo particolare quelle che compromettono le possibilità di crescita dei giovani, creando nuove povertà giovanili, disagio e per alcuni anche devianza.
Per vocazione, come Salesiani non possiamo rimanere tranquilli davanti a questa situazione che troviamo adesso, non solo nel cosiddetto Terzo Mondo, ma dovunque, anzi, essa ci spinge e ci impegna ad offrire risposte alle situazioni più urgenti dei giovani in situazione di rischio (CG 21, 158; CG 22, 6.72; CG 23, 203-214).
All’interno del PEPS ispettoriale nei diversi luoghi rispondiamo a questo impegno in tutte le nostre opere e presenze, attraverso un nuovo stile di presenza e accoglienza di tutti, un servizio educativo integrale centrato nella persona, soprattutto dei più bisognosi, la formazione sociale e la promozione di una cultura della solidarietà, l’impegno per la giustizia e la trasformazione della società ( Cf. Cost. 33).
Nonostante l’attenzione precedente, molti dei nostri destinatari preferenziali (i più poveri e bisognosi) si trovano in alcune situazioni di forte esclusione sociale e di disagio che richiedono da parte nostra presenze più specifiche in risposta alle loro necessità (opere – servizi sociali per giovani in situazione di rischio); in queste opere specifiche, con un’attenzione educativa di prevenzione, di accoglienza, di accompagnamento per il ricupero …, offriamo loro risposte concrete, in un cammino di crescita integrale. Dappertutto si danno risposte creative, a seconda del contesto, con varie opere o servizi: per ragazzi che vivono nella strada, abbandonati – orfani – con problemi di famiglia, giovani carcerati o con problemi giudiziali, o di tossicodipendenza, per giovani drop-out, per giovani di settori popolari rischiosi, per gli emigrati, i rifugiati, i profughi – dislocati, per gruppi etnici…
1. L'ORIGINALITÀ DELLE OPERE – SERVIZI SOCIALI PER GIOVANI IN SITUAZIONE DI RISCHIO
Molte di queste opere e servizi presentano un modello nuovo dal punto di vista pedagogico e salesiano, e richiedono competenza professionale, programmi specializzati, collaborazione con altre istituzioni civili. In queste opere si stanno sviluppando anche le forme migliori di partecipazione laicale e di volontariato.
Questa realtà esige da noi di esplicitare l’identità salesiana della nostra risposta e prevenzione delle diverse forme di disagio, e di condividere con i laici questa specificità, per costruire insieme un progetto educativo salesiano.
Ecco gli elementi fondamentali di questa identità:
1.1. Un ambiente familiare animato da una comunità
I giovani in situazione di rischio, la maggioranza dei quali con problemi familiari, hanno bisogno di un ambiente di famiglia, in cui trovino le condizioni e l’ambiente favorevole per ristrutturare e riorientare adeguatamente la loro vita, vivere un rapporto e dialogo spontaneo ed educativo nell’autonomia e interdipendenza, per crescere insieme nella solidarietà, reciprocità e servizio vicendevole.
Questo ambiente ha bisogno di un'animazione comunitaria, nella quale la comunità SDB, insieme agli educatori laici, ha un ruolo irrinunciabile nel nucleo animatore.
1.2. La scelta dell’educazione
La povertà e l'emarginazione non sono solo un fenomeno puramente economico, ma “una realtà che tocca la coscienza delle persone e sfida la mentalità della società. L’educazione è dunque un elemento fondamentale per la loro prevenzione e per il loro superamento ed è pure il contributo più specifico ed originale che come Salesiani possiamo dare” (Lettera del Rettor Maggiore J. E. VECCHI, Si commosse per loro, o.c., p.29).
Educhiamo a partire dalla convinzione e dalle motivazioni personali, con l’amabilità e una relazione personale di accoglienza e di dialogo, accoglienza e accettazione incondizionate che risvegliano l’autostima e la consapevolezza della propria dignità e valore.
1.3. La preventività
Un aspetto molto importante in queste opere e servizi è il criterio della preventività che, accettando i giovani come li troviamo (in situazione di rischio, colpiti da queste situazioni, o in quella che viene chiamata “devianza“), tenta di favorire le condizioni perché vivano una vita degna, di evitare il peggioramento della situazione negativa e della devianza, di rendere le persone capaci di autonomia e di gestire con responsabilità la propria vita, e di trasformare le situazioni sociali e culturali che sono alle radici dell’emarginazione.
A seconda del tipo di giovani che ci sono in queste opere, alcune hanno interventi diretti di ricupero o di rieducazione. Sappiamo che l’intervento nel recupero non è il nostro campo specifico, ma “la forza educativa del sistema preventivo si mostra anche nella capacità di ricupero dei ragazzi sbandati che conservano delle risorse di bontà” (CG 22, 72); Don Bosco presenta il suo sistema come il più adeguato alla rieducazione dei ragazzi, toccati dalla delinquenza o comunque gravemente emarginati.
1.4. L’impostazione sociale – politica
La risposta salesiana all'emarginazione – esclusione giovanile ha necessariamente anche una impostazione sociale e politica; in questo senso, queste opere e servizi salesiani promuovono una cultura dell'altro, della sobrietà, della disponibilità a condividere gratuitamente, in un'opera di ampia prevenzione, di accoglienza e di supporto di chi ne ha bisogno; e collaborano alla trasformazione delle realtà di esclusione sociale, ed alla costruzione della giustizia, la pace, e la salvaguardia del creato.
1.5. L’ispirazione evangelica e l’intenzionalità evangelizzatrice
Tutto il nostro impegno educativo è ispirato al vangelo e indirizzato ad aprire i giovani a Cristo.
In queste opere e servizi non si cerca soltanto di rispondere ai problemi e bisogni primari dei destinatari, ma li si aiuta a sviluppare tutte le risorse della persona, verso una promozione umana - sociale, aperta ai valori religiosi e del vangelo.
Con quest'azione educativa si annuncia e si attua la Salvezza, offrendo in tutti gli elementi dell’opera un'immagine evangelica, e condividendo con i giovani una proposta e un cammino di fede nelle misura delle loro possibilità.
1.6. La professionalità e il senso vocazionale
Un'azione educativa di qualità richiede una professionalità strettamente collegata con un profondo senso vocazionale, tanto nel singolo educatore, come nell'insieme della comunità.
Questo senso vocazionale rende gli educatori sensibili alla persona di ogni giovane, specialmente i più poveri, e li impegna con più motivazione in una formazione sistematica e adeguata per affrontare con competenza la complessità delle situazioni di disagio, gestire con efficacia i lunghi e complessi processi educativi e di ricupero e lavorare in stretta collaborazione con altri professionisti.
2. LA COMUNITÀ EDUCATIVA PASTORALE DI QUESTE OPERE – SERVIZI
Don Bosco, con l’Oratorio, vuole offrire ai giovani abbandonati una vera famiglia dove possano crescere e prepararsi per la vita; per questo considera così importante la comunità.
In tutte le nostre presenze, ma soprattutto in queste, si deve superare “quella forma eccessivamente individuale di agire per cui alcune di queste opere venivano considerate come retaggio di confratelli singoli che forse avevano avuto il merito di desiderarle e iniziarle,” e avanzare verso “una maggiore integrazione delle iniziative e dei confratelli nel progetto ispettoriale”(VECCHI J., Si commosse per loro, o.c., p.19).
2.1 Caratteristiche della CEP nelle opere - servizi nel campo del disagio giovanile
La CEP in queste opere – servizi, nella sua configurazione e crescita, favorisce lo spirito di famiglia attraverso:
• L’organizzazione e il vissuto molto familiare: che tutti, incominciando dagli educatori abbiano qualità umane, cioè contatto con i giovani, avvicinamento, familiarità, presenza, assistenza, amorevolezza... Non solo si lavora per i giovani poveri, ma lo si fa in solidarietà e comunione con loro.
• Una chiara identità della nostra originalità e proposta da parte di tutti gli animatori, specialmente i laici, vissuta con professionalità e senso vocazionale.
Questo esige da parte loro di:
° approfondire continuamente le motivazioni che guidano le scelte e rinnovare i valori del Sistema Preventivo che le ispirano;
° avere la preparazione necessaria per lo svolgimento del progetto con vera professionalità nella complessità delle situazioni di disagio, lavorando in équipe e in stretta collaborazione con altri professionisti, come sociologi, psicologi, medici, avvocati...;
° curare una approfondita conoscenza della realtà giovanile nel mondo dell’esclusione sociale – emarginazione, della cultura che c’è all'interno e sul territorio, e gestire con efficacia i lunghi e complessi processi educativi e di ricupero;
° approfondire lo studio del Sistema Preventivo, per attualizzarlo nelle situazioni quotidiane;
° promuovere una formazione continua sulla dimensione sociale della carità e su come attuarla nell'opera (CG23 209-214), e sulla spiritualità della povertà.
• Il coinvolgimento e protagonismo di tutti, specialmente dei giovani. Questa esperienza sarà una scuola per loro, nel senso che diventano educatori degli stessi giovani, sia nel processo, sia nel suo sbocco, assumendo il servizio di educatore nella stessa opera o in un'altra.
• Una chiara definizione dei compiti e delle responsabilità dei diversi organismi e funzioni all’interno dell’opera, curandone la collaborazione e complementarità; con chiarezza nella definizione e gestione dei programmi e di finanziamento, di fronte alle altre istituzioni civili o ecclesiali alle quali si deve fare riferimento.
• Strutture e mezzi adatti alla realtà dei giovani e al loro inserimento socio – familiare; con fiducia nella Provvidenza, procurando che la prima preoccupazione siano i giovani e la loro educazione; aperti alla collaborazione e collegamento con altre opere e istituzioni simili.
2.2 Alcuni aspetti pratici da tenere in conto in queste CEP
° Innanzi tutto, la realizzazione e l'esperienza della CEP, anche se semplice e flessibile, secondo i criteri approvati dall'Ispettore e dal suo Consiglio;
° l’elaborazione e realizzazione del PEPS con la partecipazione di tutti, secondo le linee del PEPS ispettoriale;
° un rapporto di comunicazione e di aiuto con le altre opere della Ispettoria, sviluppando una complementarità di proposte e di interventi in rete;
° un collegamento e interrelazione sistematica con le famiglie, con il territorio e le sue istituzioni, con gli specialisti professionali e con i volontari, con altre istituzioni o associazioni che lavorano sullo stesso campo, promuovendo allo stesso tempo l’autonomia e l’interdipendenza.
3. LA PROPOSTA EDUCATIVO-PASTORALE IN QUESTE OPERE – SERVIZI
3.1 Finalità della nostra proposta
° Offrire ai “giovani in situazioni di difficoltà speciale” un cammino di crescita integrale dove possano affrontare il disagio, sviluppare le loro risorse positive e diventare buoni cristiani e onesti cittadini; più in concreto:
- offrire risposte alle loro necessità primarie, soprattutto di sopravvivenza e sicurezza, perché possano ritrovarsi nella normalità con autostima e superare atteggiamenti di dipendenza;
- promuovere la loro qualifica culturale e tecnica, per inserirsi con normalità nella vita di famiglia, di lavoro, sociale e politica;
- aiutarli a sperimentare e ad assimilare personalmente i valori educativi, religiosi ed evangelici d'autonomia, libertà, responsabilità, amore, servizio, autodisciplina, tolleranza ...;
- aiutarli a scoprire ed a esperimentare la presenza amorosa e paterna di Dio nella propria vita, e accompagnarli con pazienza e con fiducia nella loro progressiva apertura alla fede cristiana.
° Aiutare a creare una nuova mentalità e cultura “che susciti cambiamenti di criteri e visioni attraverso gesti e azioni… Si tratta di promuovere una cultura dell’altro, della sobrietà…della disponibilità a condividere gratuitamente, della giustizia, intesa come attenzione al diritto di tutti alla dignità della vita, e più direttamente, di coinvolgere persone e istituzioni in un’opera di ampia prevenzione, di accoglienza e di supporto di chi ne ha bisogno” (VECCHI J., Si commosse per loro, ACG 359, p.31-32).
° Rendere concreta la partecipazione e l’impegno liberatore per la giustizia e la pace (Cost. 33):
- impegnandoci nella difesa dallo sfruttamento socio-politico-culturale dei minori (bambini – adolescenti – giovani) e dei più deboli;
- essendo profeticamente loro portavoce;
- contribuendo alla costruzione di una società più degna dell’uomo;
- aiutando la trasformazione di questa realtà strutturalmente ingiusta (peccato strutturale);
- formando i giovani alla “dimensione sociale della carità”.
3.2 Caratteristiche della nostra proposta educativa pastorale in queste opere
3.2.1 Una proposta integrale e organica
La proposta parte da un atteggiamento di avvicinamento e di accoglienza gratuita di questi giovani, suscitando un processo educativo che sviluppa il meglio che portano dentro, le loro risorse intensamente umane e perciò coincidenti con valori evangelici, aiutandoli ad integrarsi positivamente nel proprio ambiente sociale e preparandoli all’incontro con Gesù Cristo (CG23, 291-292).
Questa proposta, realizzata in molti modi e in tempi diversi, a seconda delle esigenze di ogni ragazzo, offre risposte specifiche e molte volte rapide alle loro difficoltà e bisogni.
La testimonianza degli educatori e della comunità educativa, l’ambiente di accoglienza e di famiglia, la difesa e promozione della dignità personale, diventano un annuncio del Cristo e del suo progetto di salvezza e un'offerta di liberazione e di pienezza di vita.
3.2.2 Con un taglio educativo preventivo
La nostra proposta educativa, sebbene sia di assistenza e protezione sociale, non rimane solo in un aiuto materiale contingente e di emergenza, ma va alle radici della situazione, trovando le cause vere, perché gli interventi possano prevenirle e trasformarle.
La prevenzione, quindi, non è indirizzata soltanto ad alleviare il disagio, o prevenirne gli effetti; è, piuttosto, un'azione sistematica nella rete sociale: sui giovani che vivono le situazioni di disagio a qualsiasi livello (in situazione di rischio, colpiti da queste situazioni, o in quella che viene chiamata “devianza“), sulla società stessa, le sue istituzioni, i processi. Essa vuole influire a livello strettamente educativo (le singole persone), a livello culturale (maturazione di una nuova mentalità sociale), e a livello politico (l’esercizio del potere per il bene comune).
3.2.3 Animata con pazienza , gradualità, e professionalità
La situazione propria dei giovani che arrivano a queste opere, e il nostro stile preventivo, fanno sì che lo sviluppo della proposta sia portato avanti da parte degli educatori:
- con speranza e ottimismo realista, che nascono dall’amorevolezza degli educatori, manifestano la loro fede nell’educazione e la convinzione nella forza umanizzante della grazia di Cristo;
- con gradualità, che nasce dal processo educativo, sa incontrare ognuno dove si trova, stimolare alla crescita personale e comunitaria secondo un itinerario proposto dal PEPS dell’opera;
- con professionalità, cioè con educatori che non solo hanno l’identità salesiana, ma la preparazione necessaria per questo servizio.
3.2.4 Diviene anche una proposta di trasformazione per il territorio e la realtà sociale
Il lavoro educativo di queste opere, mentre prepara e aiuta i giovani per un inserimento nel territorio, deve promuovere anche una trasformazione della mentalità dell’ambiente, e collaborare a trasformare la realtà sociale. Nella continua riflessione sulla realtà di povertà – emarginazione che ci circonda, agisce sull’ambiente in cui vive il giovane, soprattutto la famiglia, suscitando una sistematica collaborazione tra le diverse istituzioni e gli educatori presenti.
3.3 Interventi:
Sebbene ogni opera attui il suo intervento secondo le proprie situazioni e possibilità, qui ne suggeriamo alcuni progressivi, da curare continuamente:
Davanti al territorio:
. analisi continua della realtà concretizzando le sfide che presenta;
. proporvi o realizzarvi interventi specifici;
. collaborare con altre istituzioni all’elaborazione di politiche educative, familiari, giovanili, urbanistiche... capaci di prevenire e superare le cause strutturali del disagio;
. fare la scelta specifica dell’attenzione dei più deboli, specialmente i giovani.
Con i giovani presente nell’opera - servizio:
- Avvicinarsi, interessarsi e conoscere la loro situazione, condividere i loro interessi nel loro mondo.
- Offrire un’accoglienza familiare nella casa salesiana, che faccia crollare la barriera della diffidenza e risvegli la voglia di iniziare un processo educativo;
- Proporre interventi concreti secondo i bisogni primari come:
. risposte alle necessità di sopravvivenza: cibo, casa, letto, salute...;
. risposte alle necessità di sicurezza: casa che accoglie nella familiarità – vicinanza, amorevolezza...
. interventi di ristrutturazione/ricupero (se occorrono)
. risposta alla necessità di rapporti di crescita: aiutare i giovani perché abbiano un rapporto normale con se stessi, con gli altri (una sana convivenza con i compagni e tutti i membri della CEP), e con le cose che stanno al loro servizio (senso di appartenenza).
- Iniziare interventi più sistematici ed impegnativi per un cammino di crescita integrale:
. studio e scuola (alle volte non formale): inserzione critica nel sapere e nella cultura;
. formazione tecnica – professionale: preparazione qualificata per il lavoro;
. attività di tempo libero (sport, musica, teatro, arte, lettura...), accompagnato dagli educatori;
. possibilità di orientamento professionale e di dialogo educativo pastorale con gli educatori; anche possibilità di dialogo – orientamento cristiano e vocazionale;
. partecipazione ad eventi - celebrazioni del territorio;
. esperienze che portino da piccoli impegni ad impegni più grandi;
. possibilità di associarsi in gruppi – movimenti;
. conoscere il loro mondo religioso e offrire loro esperienze che stimolino la crescita della loro dimensione religiosa;
. l’insegnamento religioso;
. primo annuncio cristiano: "buongiorno", "buonanotte", giornate di riflessione...;
. catechesi: di prima Comunione, di Cresima...;
. celebrazioni nella casa o partecipazione nella parrocchie o altri luoghi;
. formazione di animatori cristiani.
- Orientarli nella crescita della dimensione sociale della carità.
- Aiutarli nell’inserimento normale e con autonomia - libertà - responsabilità nella vita sociale, nella famiglia di origine, nella famiglia che costituiscono, nel lavoro, nell’impegno sociale...
- Accompagnarli nello sviluppo della loro vita familiare, lavorativa, sociale e cristiana.
- Offrire una formazione specifica, che li renda capaci di essere educatori degli stessi giovani in difficoltà.
Suggerimenti bibliografici per l'approfondimento
FERRAROLI L., Disagio, Emarginazione, In FSE/UPS, Dizionario di Scienze dell’Educazione, LDC/LAS/SEI, Torino 1996, pp.304-305; 371-372.
MASINI V., Emarginazione, In FSE/UPS, Dizionario di Scienze dell’Educazione, LDC/LAS/SEI, Torino 1996, pp. 371-372 .
DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE SALESIANA – UPS/FSE, Emarginazione giovanile e pedagogia salesiana, LDC, Torino 1987. Tutto il volume serve, ma soprattutto:
VECCHI J., Salesiani ed emarginazione giovanile in Europa, pp. 78-96,e le conclusioni dei tre seminari fatti nel 1996:
Europa e Nordamerica. Le conclusioni, pp.142-145; America Latina. Le conclusioni, pp. 290-293; Asia e Pacifico. Le conclusioni, pp.400-401.
VECCHI J., Si commosse per loro. Nuove povertà, missione salesiana e significatività. In ACG 359, pp. 3-36.
VECCHI J., Il nostro impegno per ragazzi e giovani a rischio. In Dossier PG Esperienze a confronto., N. 2, 1987, pp.63-70.
DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE SALESIANA – VIS, Ragazzi di strada. Meeting internazionale, Roma, 7-11 dicembre, 1998, Roma, SDB, 1999.
SEPSUR, La familia salesiana y la evangelización de los más pobres. Curso regional de Pastoral juvenil, Resistencia – 26 al 30 de julio de 1999. CUADERNOS DE PASTORAL JUVENIL – 37
DBYA – INDIA (a cura di M.C. George), Don Bosco national Forum for street and working children/youth (DBNF-SWC/Y), New Delhi, DBYA, 1998
DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE SALESIANA – DBI, Don Bosco 2000. Lotta alle nuove povertà e all’esclusione sociale dei giovani in Europa. Atti del Seminario di cooperazione europea dei responsabili nazionali del Movimento Don Bosco, Benediktbeuern, 04-08 gennaio 2000, Roma, SDB, 2000.
DBYA - India (a cura di M.C. George), The Young at Risk, New Delhi, DBYA, 2000.
DBYA - India (a cura di M.C. George), Consultation on The Young at Risk, New Delhi, DBYA, 2000.
V. NUOVE FORME DI PRESENZA SALESIANA TRA I GIOVANI
Di fronte alle nuove richieste giovanili, si percepisce la difficoltà delle attuali forme istituzionali per dare risposte adeguate alle domande di educazione e di educazione alla fede. Si constata una progressiva lontananza tra il mondo degli adulti e il mondo dei giovani; una lontananza umana, culturale e religiosa, che rende difficile un vero dialogo e comunicazione tra i loro riferimenti fondamentali e quelli degli adulti. Nonostante la sostanziale efficienza organizzativa delle strutture e l’impegno operativo degli educatori, si avverte una certa impotenza davanti a questa nuova situazione.
Nella società complessa e pluralista assistiamo al sorgere di nuovi luoghi o forme di educazione della gioventù, che propongono modelli e creano stili di vita che affascinano le masse giovanili; si pensi alla scuola parallela dei mass-media, alle aggregazioni attorno agli interessi musicali e sportivi, al turismo, alle nuove forme di impegno sociale ed ecclesiale, all’area vitale del tempo libero, nuovo luogo di identificazione personale.
Una delle forme di presenza tra i giovani più ampia e comprensiva è il Movimento Giovanile Salesiano (MGS).
1. IL MOVIMENTO GIOVANILE SALESIANO
1.1. Movimento Giovanile Salesiano – Un’espressione privilegiata della pedagogia di Don Bosco
La tendenza associativa, la vita dei gruppi, l’ispirazione comunitaria è stata una esperienza quasi spontanea nella vita di Don Bosco, un'inclinazione della sua indole naturalmente portata alla socialità e all’amicizia. L’associazionismo giovanile è un’esigenza indispensabile nel tipo di progetto preventivo e popolare voluto da Don Bosco (Cf. ACS 294, 17).
Attraverso una pluralità di gruppi e associazioni giovanili vogliamo assicurare una presenza educativa di qualità nei nuovi spazi di socializzazione dei giovani, e animarli verso una significativa esperienza di vita ecclesiale.
1.2 Il Movimento Giovanile Salesiano tra i Movimenti ecclesiali
Tra i frutti del rinnovamento che lo Spirito Santo ha generato partendo dal Concilio Vaticano II, vi sono i Movimenti ecclesiali, che “sono espressioni provvidenziali della nuova primavera suscitata dallo Spirito” (Giovanni Paolo II 31/5/98).
“Il termine (Movimento) viene spesso riferito a realtà diverse fra loro, a volte persino per configurazione canonica. Se, da un lato, essa non può certamente esaurire né fissare la ricchezze delle forme suscitate dalla creatività vivificante dello Spirito di Cristo, all’altro sta però ad indicare una concreta realtà ecclesiale a partecipazione in prevalenza laicale, un itinerario di fede e di testimonianza cristiana che fonda il proprio metodo pedagogico su un carisma preciso donato alla persona del fondatore in circostanze e modi determinati”. (Giovanni Paolo II, Congresso, 4).
Tra queste nuove espressioni della vita ecclesiale lo Spirito ha suscitato nella realtà salesiana il Movimento Giovanile Salesiano.
1.3 Caratteristiche del MGS
Il Movimento Giovanile Salesiano (MGS) è una delle forme di presenza tra i giovani più ampia e comprensiva.
E’ un Movimento a carattere educativo offerto a tutti i giovani, per farli soggetti e protagonisti della loro crescita umana e cristiana, con slancio missionario, aperto ai lontani, con una volontà di incidenza nel territorio e nella società civile e d’inserimento e apporto alla Chiesa locale.
I gruppi e le associazioni giovanili che, pur mantenendo la loro autonomia organizzativa, si riconoscono nella spiritualità e nella pedagogia salesiana, formano in modo implicito o esplicito il Movimento Giovanile Salesiano.
1.3.1. Elementi di identità del MGS
Sono due gli elementi di identità che caratterizzano il MGS:
• il riferimento alla Spiritualità Giovanile Salesiana (SGS) e alla pedagogia salesiana:
- la persona di Don Bosco, iniziatore nella Chiesa d’una forma concreta di vita cristiana, la SGS, e d’una prassi educativa, il Sistema Preventivo Salesiano, è il riferimento unificante per tutti i gruppi ed associazioni.
• Il collegamento tra i gruppi:
- esso si esprime nella condivisione dei valori e idee-forza e nel coordinamento di iniziative comuni, che diventano occasioni significative di dialogo, di confronto, di formazione cristiana e di espressione giovanile (Cf. CG23, 275-277).
1.3.2 Scelte fondamentali del MGS
Questi elementi si concretizzano in alcune scelte importanti:
° La scelta educativa, che pone l’accento sul cammino di crescita delle persone, che lo apre a tutti i giovani, soprattutto i più poveri e lontani, con la volontà di accompagnarli sino alla pienezza della vita cristiana (la santità). L’attenzione degli educatori si rivolge alla persona del giovane più che alle strutture di aggregazione.
° La scelta associativa-ecclesiale, che apre l’esperienza di gruppo ad una realtà più ampia di comunicazione, condivisione e collaborazione fino a trasformarla in una esperienza di Chiesa.
° La scelta formativa, che dà sempre la priorità al processo di crescita integrale e permanente delle persone, al servizio del quale articola le diverse attività ed iniziative.
° La scelta apostolica, che impegna i giovani a formarsi nel servizio gratuito per gli altri, condiviso, approfondito e celebrato insieme.
° La scelta civile, per divenire uno strumento di esperienza e formazione sociale e per essere presenti con efficacia nella società, ai livelli in cui si decidono le politiche giovanili.
Queste scelte si traducono in alcuni elementi operativi che guidano la vita dei gruppi del Movimento:
- la varietà di gruppi e associazioni secondo gli interessi dei giovani, curando soprattutto quelli più adatti ai giovani più poveri; senza gruppi di base non ci può essere MGS;
- un cammino di esperienza comunitaria attorno alla persona di Don Bosco e ai valori della SGS; questo riferimento a Don Bosco e ai valori della sua spiritualità sono il punto di convergenza e la fonte di ispirazione qualificanti di tutti i gruppi e associazioni che fanno riferimento al MGS;
- l’impegno apostolico dei giovani tra gli stessi giovani; SDB, FMA e giovani assieme, al servizio della Chiesa e della società;
- gli animatori, che vivono e fanno propria la proposta salesiana nei gruppi e associazioni;
- gli incontri e la festa , come momenti di comunicazione, di formazione e di esperienza di vita.
1.3.3. Elementi per l’animazione del MGS
Anche se le realtà sono molto diverse, alcuni aspetti dell’animazione sono fondamentali:
- promuovere un organismo ispettoriale e interispettoriale di coordinamento con la partecipazione dei giovani;
- progettare una proposta formativa offerta ai diversi gruppi ed associazioni come punto di
riferimento per il loro piano di formazione;
- considerare la formazione degli animatori ed educatori la carta vincente del Movimento;
- creare una rete di informazione e di collegamento tra i diversi gruppi e associazioni e anche tra loro e gli altri gruppi e associazioni nella Chiesa e nel territorio (incontri, fogli o riviste, iniziative d’insieme, ecc..);
- considerare i luoghi salesiani come luoghi di incontro spirituale e di proposta cristiana;
- considerare il delegato PG con la sua équipe promotore dell'insieme del MGS.
1.4. Gli ambiti di interesse e di impegno del MGS
Le espressioni del MGS sono molteplici e manifestano la variegata proposta associativa salesiana. Questa si colloca a diversi livelli e in vari tipi dei gruppi che descriviamo brevemente.
° L’area dell'ampia accoglienza: si tratta di amare le cose dei giovani e i loro interessi (sportivi, ricreativi, ecc.) per coinvolgerli in un progetto di vita, per educare non come singoli, ma come comunità, in relazione, dialogo, collaborazione e condivisione con le famiglie e con la società.
° L’area della formazione umana che sviluppa la creatività, la capacità di progettazione e competenza nella realizzazione, la capacità di sognare e creare, la capacità di utilizzare il linguaggio dei mass media, ecc.
° L’area dell’animazione culturale, sociale e politica che punta con particolare attenzione alla conoscenza della realtà sul territorio, all'impegno sociale e politico che si gioca su alcuni valori di solidarietà: lo sviluppo, la pace, la giustizia, la mondialità, l'ecologia, ecc.
° L’area della formazione religiosa e cristiana che impegna i gruppi e le associazioni a qualificare il messaggio religioso e cristiano che hanno come finalità specifica e prioritaria, per accompagnare i giovani nella loro crescita religiosa e nel loro itinerario di educazione alla fede.
1.5. Le convocazioni giovanili
Gli incontri giovanili sono uno degli elementi caratterizzanti il MGS, come occasioni significative di comunicazione tra i gruppi e di circolazione dei messaggi e dei valori della Spiritualità Giovanile Salesiana.
In questi anni si stanno moltiplicando questi grandi momenti d'incontro. Nell’arco di un anno diverse Ispettorie vivono giornate in cui si intensifica il dialogo fra tutte le componenti giovanili che costituiscono il MGS.
Il clima di festa è una caratteristica di queste convocazioni, ma l’educatore deve anche curare i contenuti; la convocazione nel suo insieme deve risultare un vero annuncio e un momento forte di appello e rilancio della proposta educativo-pastorale. Per questo occorre:
- prevedere nella varietà dei momenti e delle espressioni un’accurata convergenza dei contenuti su ciò che interessa la qualità e significatività della proposta educativa ed evangelizzatrice;
- inserire l’incontro nell’insieme del processo educativo dei gruppi, pensando un conveniente cammino di preparazione, e un "dopo-incontro" che porti l’esperienza alla vita di ogni giorno;
- curare la preparazione e partecipazione di un numero proporzionato di animatori, specialmente giovani, consapevoli degli obiettivi proposti.
2. NUOVE FORME E SERVIZI EDUCATIVI
Nell'insieme del mondo salesiano si sono sviluppate nuove realtà e aggregazioni giovanili, nuove forme educative, servizi o opere per rispondere ai nuovi bisogni di contatto e di presenza nel mondo giovanile. Senza voler essere esaustivi eccone alcuni:
. associazioni e servizi nel campo del tempo libero, come lo sport, il turismo, la musica e il teatro...;
. volontariato nelle sue diverse forme;
. servizi specializzati di formazione cristiana e di animazione spirituale (case di spiritualità e di ritiri);
. programmi di animazione vocazionale (comunità proposte, centri d’accoglienza vocazionale, campi-scuola vocazionali...);
. presenze nel mondo universitario (pensionati universitari, animazione della pastorale universitaria; accoglienza e attenzione agli universitari...);
. altre forme di presenza nei mass media, e nel campo pastorale specificamente missionario, animati dai rispettivi Dicasteri per la Comunicazione Sociale e per le Missioni.
2.1 Caratteristiche di queste nuove forme di presenza
Tutte queste nuove forme di presenza sono realtà leggere, capaci di rispondere e di adattarsi alle mutevoli necessità e urgenze con maggiore libertà d’azione e di iniziativa; utilizzano maggiormente le possibilità della comunicazione con l’ambiente naturale dei giovani, piuttosto che la stabilità di un ambiente fisico; privilegiano la spontaneità dei rapporti e la libertà di adesione, la centralità delle persone più che la struttura e il progetto; in esse è relativamente più facile coinvolgere gli stessi giovani nella consapevolezza che il cammino da compiere insieme è nelle loro mani; coltivano un legame di fondo tra diverse realtà e lavorano in mutua interazione con altre istituzioni e servizi in un territorio cercando di offrire una risposta globale alle situazioni. Sono, dunque, espressione di una forma di presenza nel mondo giovanile e strumenti efficaci di risposta alle nuove urgenze educative ed evangelizzatrici.
2.2 Criteri di identità salesiana
Questi nuovi spazi e forme educative sono anche esposti ad alcuni pericoli che possono ridurre la loro efficacia educativa ed evangelizzatrice, come per esempio l'individualismo nella gestione, un’identità debole e poco definita, una provvisorietà di realizzazioni e precarietà di progetto che rendono difficile la continuità dei processi educativi di lunga durata.
Conviene dunque presentare alcuni elementi e criteri che aiutino ad orientare queste nuove forme di presenza e ad articolarle positivamente con le tradizionali all'interno del progetto dell'Ispettoria. Eccone alcuni:
- chiarezza della finalità educativa e pastorale salesiana ( Cost. 41);
- apertura al criterio permanente di discernimento e rinnovamento: ogni attività e opera è “per i giovani casa che accoglie, parrocchia che evangelizza, scuola che avvia alla vita e cortile per incontrarsi da amici e vivere in allegria” ( Cost.40);
- realizzazione comunitaria; la comunità salesiana è sempre il soggetto della missione ( Cost.44);
- integrazione nel progetto ispettoriale con una permanente interazione e collaborazione tra le diverse opere e servizi educativo-pastorali dell’Ispettoria (Cost.58).
3. SERVIZI DI ANIMAZIONE DEL TEMPO LIBERO
3.1 Il valore educativo pastorale salesiano del tempo libero
Le attività di tempo libero, sport, turismo, cultura, musica, teatro, ecc., sono realtà che aggregano molti giovani, anche lontani, che cercano di soddisfare i loro tipici interessi; sono presenti in tutte le nostre opere.
Questo tipo di intervento educativo viene oggi considerato di grande valenza sociale e di rilevanza preventiva; è un modo nuovo di ricreare l’ambiente oratoriano suscitato da Don Bosco a Valdocco: il cortile fu per lui il luogo prediletto per una azione educativa pastorale.
3.2 Caratteristiche dell’animazione di attività di tempo libero
Esiste nel mondo salesiano una grande varietà di iniziative, gruppi e associazioni che sviluppano la proposta educativo-pastorale salesiana in questi ambiti con pluralità di stili di azione, forme di organizzazione, e quantità di partecipanti. Ma in tutti possiamo individuare alcuni elementi comuni che caratterizzano la loro identità:
- la centralità del giovane nell'opera educativa e in tutte le attività e progetti;
- il gruppo e l’esperienza associativa come scelta educativa privilegiata ed essenziale per una maturazione umana integrale;
- il tempo libero come un tempo liberato dai condizionamenti consumistici e disponibile per l’espressione, sviluppo e approfondimento degli interessi giovanili;
- la formazione integrale, personale e sociale dei ragazzi e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa attraverso lo sviluppo dei loro interessi;
- lo stile educativo dell’animazione;
- la partecipazione e protagonismo dei laici, soprattutto degli stessi giovani;
- la presenza attiva nel territorio, per offrire un progetto di uomo e di società ispirato esplicitamente alla visione cristiana e al sistema educativo di Don Bosco.
3.3 Criteri e linee operative
• Integrare tutti questi gruppi e associazioni di attività di tempo libero ( gioco, sport, turismo, musica, teatro, cinema, ecc...) nel processo educativo-pastorale che favorisce:
. la scoperta e lo sviluppo delle energie positive e delle risorse e valori che il giovane ha dentro di se;
. l’offerta di esperienze positive e di qualità educativa, come l’incontro amichevole, l'allegria della condivisione, lo sforzo per ottenere un obiettivo, l’autodisciplina, la capacità di creatività, ecc.,
. le domande e gli interessi sempre più profondi e di più qualità umana e cristiana, fino a coinvolgerli in un processo esplicito di crescita umana e cristiana.
• Congiungere il protagonismo dei giovani, sempre centrale, con la presenza attiva e significativa degli educatori tra loro, per creare insieme un ambiente di famiglia e di relazione personale, in se stesso segno e testimone del Vangelo.
• Pensare la necessaria organizzazione al servizio del processo educativo-pastorale e d’una presenza significativa nel sociale. Queste attività hanno bisogno di strutture e organizzazione efficaci e competenti, e anche di fonti di risorse economiche; si tratta di realtà e processi necessari, ma anche carichi di rischi; per questo si deve curare molto:
. la selezione dei responsabili e la loro formazione, procurando che condividano i criteri e gli obiettivi del PEPS che s’integrano nella CEP;
. i criteri di distribuzione dei soldi, privilegiando gli aspetti più educativi , al servizio dei giovani più bisognosi;
. la scelta dei progetti di collaborazione e dei “partners”.
• Facilitare il senso di appartenenza dei diversi gruppi e associazioni ad un progetto e ambiente educativo più ampio e integrale, per superare il pericolo di settorialismo. Questo suppone:
. far partecipare i responsabili ed animatori dei diversi gruppi ed associazioni presenti in un’opera salesiana all’unica CEP, sentendosi responsabili solidalmente dell' ambiente educativo;
. promuovere esperienze di condivisione, collaborazione e di apertura agli altri gruppi attraverso informazioni reciproche, momenti d’incontro e celebrazione insieme, collaborazione a iniziative e attività d’insieme, il condividere la formazione, ecc...;
. favorire una certa comunicazione di beni al servizio dei bisogni dell’insieme.
4. IL VOLONTARIATO SALESIANO
4.1. Un’esperienza in crescita
Nella realizzazione della missione salesiana, attraverso la Pastorale Giovanile Salesiana noi animiamo sia lo spirito del volontariato (servizio, solidarietà – dimensione sociale della carità, gratuità, disponibilità nei confronti delle persone in difficoltà…), sia il volontariato stesso (tutte le forme specifiche di volontariato educativo organizzato), perché sia vissuto in ognuna delle nostre comunità educative pastorali (CEP).
In questi anni si è sviluppata nelle Ispettorie e nel MGS una molteplicità di gruppi ed associazioni di volontariato, soprattutto giovanile. Il CG24 ha riconosciuto la realtà del volontariato come un nuovo stile di apertura all’altro, soprattutto nel campo della povertà e dell’emarginazione, una sfida contro le ingiustizie e gli egoismi imperanti, un esito vocazionale significativo ed una valida conferma del cammino educativo percorso dai giovani insieme con gli SDB ( Cf. CG24, 26).
Il volontariato giovanile salesiano è anche una indicazione importante della ricchezza e vastità della irradiazione del carisma di Don Bosco e del protagonismo giovanile nella dedizione e impegno nella pastorale e promozione umana.
Esistono una grande pluralità di realizzazioni del volontariato salesiano: volontariato nelle opere dell’Ispettoria o nei territori di missione; volontariato sociale tra i più poveri, o volontariato educativo (animatori) o volontariato direttamente evangelizzatore; volontariato a lunga durata (un anno o più), o di breve tempo; il servizio sociale sostitutivo del servizio militare (obiezione di coscienza)…
Molte Ispettorie stanno facendo una riflessione e piano di lavoro sul volontariato, arrivando quindi ad assumerlo nella loro pastorale organica. La Congregazione attraverso i Dicasteri della Pastorale Giovanile, Famiglia Salesiana e Missioni ha offerto un quadro di riferimento generale per l’animazione di questa esperienza.
4.2 Identità del volontariato salesiano:
Alla luce di questo documento e delle esperienze fatte in questo ultimo tempo ci riferiamo a queste caratteristiche:
° Caratteristica laicale e giovanile: il volontario salesiano è un laico, uomo o donna, maggiorenne, che dopo una adeguata preparazione, si pone al servizio disinteressato dei giovani e del ceto popolare, dedicando una attenzione prioritaria ai più poveri, nella linea della missione salesiana, per un certo tempo.
° Caratteristica educativa: promuove una risposta competente, creativa e continuata ai bisogni emergenti, con iniziative di educazione e di promozione umana.
° Caratteristica socio-politica: propone, in collaborazione con istituzioni civili ed ecclesiali, una azione in vista della trasformazione della società e della rimozione delle cause dell’ingiustizia.
° Caratteristica evangelica: si impegna e vive un peculiare stile di presenza, ispirato al Vangelo; accetta la scelta cristiana di educare evangelizzando e di evangelizzare educando, e favorisce il proposito missionario.
° Caratteristica comunitaria salesiana: vive in équipe e comunità all’interno di una struttura organizzata, praticando il Sistema Preventivo di Don Bosco con cuore oratoriano, ispirandosi alla Spiritualità Giovanile Salesiana.
° Caratteristica organica: si realizza organizzativamente all’interno della PG Salesiana con un piano concreto di sviluppo, e con un coordinamento ispettoriale e/o interispettoriale.
4.3 Il volontariato salesiano nella PG
° Il volontariato propone alla PG una strada per riscoprire i valori delle origini salesiane, per attivare nuove modalità di intervento pastorale, per dedicare una attenzione qualificata ai giovani adulti aperti alla solidarietà, anche se le loro motivazioni di fede appaiono ancora deboli. Offre possibilità di dialogare e collaborare con altre agenzie educative, in vista della promozione sociale dei più poveri.
° La PG propone al volontariato un cammino globale di maturazione e itinerari formativi specifici. Offre il vissuto della Spiritualità Giovanile Salesiana e criteri di significatività per l’azione apostolica.
Mette a contatto con una ricca tradizione educativo - preventiva (il cuore oratoriano) e in comunicazione con altre esperienze giovanili, ecclesiali e civili. Così aiuta il volontario a vivere la sua vocazione battesimale e l’accompagna nel discernimento e nella sua scelta vocazionale specifica nella Chiesa o nella FS.
4.4 L’animazione del volontariato salesiano
Per orientarlo è necessaria un'azione di animazione concreta e sistematica che esige di:
• promuovere la sensibilizzazione dei SDB e comunità:
- conoscenza e apertura ai valori del volontariato e alla sua importanza nella missione salesiana;
- accoglienza cordiale del volontario nel proprio progetto rispettando la sua identità laicale
- collaborazione per l’elaborazione e pratica del piano ispettoriale di promozione e animazione del volontariato inserito nel progetto educativo - pastorale ( Cf. CG24, 126).
• favorire l’esperienza comunitaria dei volontari:
- curando l'esperienza dello spirito salesiano di famiglia tra loro, con i SDB e gli altri collaboratori
- attraverso un'educazione quotidiana alla accettazione delle persone, al lavoro insieme, alla comunicazione di vita, alla condivisione della fede;
- offrendo momenti quotidiani di comunicazione, di preghiera, di distensione, come pure spazi di partecipazione e campi di corresponsabilità all’interno della comunità educativo - pastorale o della comunità salesiana;
con modalità diverse secondo il tipo di volontariato, la durata, lo stato di vita dei volontari, il loro numero, la presenza o meno di un Salesiano o di altri membri della Famiglia Salesiana.
• curare la loro formazione attraverso:
- un contatto sistematico con una comunità salesiana, dove impara a vivere e agire secondo i criteri del sistema educativo salesiano;
- la conoscenza diretta della realtà, la riflessione e la condivisione delle situazioni, l’approfondimento delle motivazioni, la programmazione e realizzazione insieme;
- un accompagnamento personale che orienta il proprio processo di maturazione;
- il gruppo di appartenenza con un programma concreto di formazione generale e specifica;
- alcune esperienze speciali di formazione (campi di lavoro, vacanze impegnate, esperienze all’estero di breve durata...);
- una chiara prospettiva vocazionale, o come laico impegnato nella Chiesa o nella Famiglia Salesiana, o nella vita religiosa o sacerdotale;
• sviluppare alcuni strumenti di animazione nella comunità locale ed ispettoriale:
- La responsabilità dell’animazione e coordinamento ispettoriale compete al Delegato ispettoriale per la PG e alla sua équipe, attraverso un incaricato di questo settore.
Questo incaricato:
. promuove il volontariato organizzato, sensibilizza i confratelli e i laici;
. cura la formazione dei volontari, attraverso un piano ispettoriale;
. coordina, d’intesa col Delegato di PG, le diverse iniziative di volontariato nell’Ispettoria;
. mantiene rapporto con l’incaricato ispettoriale per le missioni e con il Delegato per la FS;
. si collega con altre Ispettorie, con gli organismi civili ed ecclesiastici;
. appoggia coloro che rientrano dalla esperienza di volontariato all'estero.
Il responsabile locale del volontariato, d’accordo con il responsabile locale di Pastorale, anima e coordina la promozione e formazione dei volontari in ogni opera salesiana.
• promuovere anche una forma di coordinamento ispettoriale, interispettoriale, nazionale o regionale, organizzando, se è possibile, Organizzazioni Non Governative (ONG) che, - operanti sia sul piano nazionale sia internazionale - in collaborazione con altre istituzioni della Chiesa e della società, favoriscano la formazione dei volontari, la promozione di progetti di promozione umana con l’inserimento di volontari, e la ricerca di finanziamenti pubblici o privati.
5. SERVIZI SPECIALIZZATI DI FORMAZIONE CRISTIANA E DI PASTORALE VOCAZIONALE
C’è una ricerca di spiritualità nei giovani, soprattutto i più grandi e gli animatori. Nel MGS si è fatto uno sforzo di approfondimento e di condivisione dei valori della Spiritualità Giovanile Salesiana fino ad esplicitare la proposta del CG23.
Il CG24 ha ribadito la convinzione che la spiritualità è la fonte di comunione tra SDB e laici e ha proposto la Spiritualità Salesiana come l’elemento centrale del processo di formazione.
Alla luce di queste attese negli ultimi decenni sono sorte nella Congregazione diverse iniziative e servizi di formazione cristiana e di educazione alla spiritualità, come esperienze di ritiro, scuole di preghiera, case di spiritualità, centri di formazione pastorale e catechistica, Santuari, ecc... Queste iniziative hanno anche una forte incidenza vocazionale; oggi la vocazione può maturare nel giovane solo se egli vive una profonda e incarnata spiritualità.
Questi servizi costituiscono una nuova forma di presenza salesiana tra i giovani, sempre più necessaria ed urgente.
5.1 Servizi di esperienza e di formazione cristiana (case di ritiro e di spiritualità, scuole di preghiera, centri di formazione pastorale e catechistica...)
Per dare a queste iniziative più qualità e consistenza conviene che si configurino secondo alcuni criteri:
° assicurare la presenza di una équipe di SDB e altri membri della FS; organizzare queste case non semplicemente come luoghi di ospitalità, ma come comunità o équipe di persone che accoglie, accompagna e condivide con i giovani una stessa esperienza spirituale.
° con un programma preciso di approfondimento e pedagogia spirituale, con diverse proposte e livelli secondo i bisogni dei diversi gruppi dei destinatari; superare la semplice offerta di iniziative isolate per presentare un cammino preciso di iniziazione e di approfondimento spirituale.
° dare speciale importanza alla pedagogia della preghiera e dell'ascolto della Parola di Dio; offrire esperienze di preghiera, d’ascolto della Parola e di partecipazione ai Sacramenti secondo i valori della Spiritualità Giovanile Salesiana; curare soprattutto l’aspetto dell’iniziazione e dell'accompagnamento, per aiutare i giovani a fare una vera esperienza vissuta e sentita in forma personale.
° offrire a tutti i giovani la possibilità di un dialogo personale con qualche Salesiano o animatore durante l’incontro e di un accompagnamento sistematico, se lo desidera.
° sviluppare sempre il tema vocazionale, aiutando i giovani a situare la propria vita davanti al Signore e al suo progetto di salvezza.
Esistono altri servizi pastorali che si pongono più in là della presenza salesiana in un'opera, sia nella Chiesa locale (come ad esempio i SDB impegnati nella pastorale vocazionale diocesana, o che seguono movimenti giovanili non salesiani), sia anche in luoghi non salesiani (come ad esempio l'incaricato della formazione degli educatori di una zona). Questi servizi pastorali siano assunti in accordo con l'Ispettore e in coerenza con il PEPS ispettoriale.
5.2 Servizi e comunità vocazionali
Nello sforzo di ricerca di nuove vie per la Pastorale Vocazionale sono nate e si sono consolidate alcune esperienze o servizi di animazione ed orientamento vocazionale (comunità di accoglienza, comunità proposta, centri di orientamento vocazionale, ecc...) che in genere offrono ai giovani l’opportunità di fare una esperienza concreta della vita e missione salesiana, di condividere ed approfondire sistematicamente il tema vocazionale e d’un accompagnamento più curato e immediato.
È importante che queste presenze assicurino:
- la presenza di una comunità salesiana aperta ed accogliente, che assicuri una testimonianza vocazionale significativa per i giovani, una esperienza di vita fraterna e di missione salesiana, un accompagnamento sistematico del processo di maturazione vocazionale di ognuno;
- una stretta relazione e collaborazione con le altre comunità dell’Ispettoria nella loro responsabilità di animazione vocazionale secondo il piano ispettoriale di Pastorale Vocazionale;
- la partecipazione specializzata nelle iniziative di animazione pastorale, curandone specialmente la dimensione vocazionale;
- la collaborazione con i centri di Pastorale Vocazionale della Chiesa locale e degli altri istituti religiosi.
5.3 Santuari
Un Santuario è un centro di spiritualità popolare che può avere una notevole importanza nell’evangelizzazione e nell’itinerario di educazione alla fede del popolo e anche dei giovani.
Molti dei Santuari curati da noi sono luoghi significativi per lo sviluppo e l’esperienza della Spiritualità Salesiana: centri di irradiazione della devozione mariana, come il Santuario di Maria Ausiliatrice di Torino e tanti altri sparsi per il mondo; luoghi di comunicazione e condivisione dello spirito salesiano attraverso la figura di Don Bosco; centri di rivitalizzazione della vita cristiana attraverso la vita liturgica, la partecipazione all’Eucaristia, al Sacramento della Riconciliazione, e la preghiera; punti di riferimento e meta di pellegrinaggi di persone, gruppi e popolazioni.
Questo ci obbliga a qualificare la pastorale del Santuario attorno ad un progetto pastorale fortemente e profondamente motivato e significativo per l’evangelizzazione del popolo e dei gruppi giovanili. Ecco alcuni aspetti da curare in modo speciale in questo rinnovamento:
. la qualità dell’accoglienza, che offra alle persone che vivono situazioni di lontananza o di povertà religiosa, l’occasione di sentirsi ascoltate, capite e incoraggiate a sviluppare il seme di fede che le ha portate al Santuario;
. una proposta forte di evangelizzazione, che apra all’incontro con Gesù Cristo e il suo Vangelo attraverso un’esperienza di conversione. Per questo, offrire spazi e possibilità per la preghiera e per la partecipazione ai Sacramenti, in maniera speciale per il Sacramento della Riconciliazione;
. l’opportunità di un dialogo e di un accompagnamento spirituale serio. Il Santuario può diventare una mediazione importante per la maturazione cristiana di molti giovani nella loro ricerca vocazionale;
. una sintesi dinamica e creativa tra la qualità evangelica e la sensibilità e il linguaggio della religiosità popolare; tra la pratica religiosa e le preoccupazioni, speranze e bisogni della vita familiare, comunitaria e sociale del popolo.
6. PRESENZE PASTORALI NEL MONDO DELL'UNIVERSITÀ
Le nuove esigenze della PG ci portano sempre più ad aprirci alla fascia alta della giovinezza, dove gli universitari sono parte considerevole, animatori, volontari, catechisti, collaboratori, ... Ma il lavoro pastorale diretto con gli universitari e ancora più la presenza pastorale nel mondo dell’università e della cultura offre possibilità nuove di sviluppo alla nostra missione giovanile:
L’età giovanile si è allungata, gli studi universitari sono diventati accessibili ai giovani delle classi popolari, l’intera categoria si trova sempre più in situazione di abbandono e a rischio.
Questa presenza è richiesta dal principio della continuità educativa, che vuole il prolungamento nell’accompagnamento educativo oltre il periodo dell’adolescenza.
Ci permette la cura e la formazione di vocazioni in senso lato e in senso specifico, di cui il mondo universitario è luogo privilegiato.
Il mondo universitario è luogo pastorale importante che ci permette di offrire un contributo di qualità al mondo della cultura, dell’educazione e del lavoro e di contribuire ad una sintesi tra fede e cultura.
6.1 Diversi livelli e tipi di opere
L’azione pastorale nel mondo universitario si sviluppa in un triplice livello strettamente relazionato:
- come pastorale della cultura universitaria, che si fa attenta all’evangelizzazione e all’animazione cristiana della cultura universitaria, in sé e per sé ed in vista della sintesi personale e comunitaria, di fede e cultura e di cultura e vita;
- come pastorale degli universitari, che cura la promozione umana e la formazione cristiana della popolazione universitaria;
- come dimensione della Pastorale Giovanile e della pastorale d’insieme, che si rende cosciente del fatto che una consistente fascia della popolazione giovanile, cui si dirige l’azione pastorale, si trova in tale condizione esistenziale anche quando si incontra in altri ambienti.
Queste prospettive educativo-pastorali orientano le diverse realizzazioni pratiche della presenza salesiana nel campo universitario. Queste si possono raggruppare in tre tipi o forme:
- istituzioni universitarie gestite dalla Congregazione;
- pensionati o residenze per universitari;
- diversi servizi di animazione pastorale universitaria, come cappellanie universitarie, strutture pastorali parrocchiali o diocesane appositamente rivolte ad universitari, ecc. ...
6.2 Quadro di riferimento
• Pedagogia dell’ambiente comunitario
È convinzione profonda dello spirito salesiano che la formazione avvenga anzitutto per il tramite dell’ambiente e del clima che in esso si respira. In queste presenze questo ambiente deve conformarsi con alcune caratteristiche specifiche:
- un ambiente di qualità umana, culturale ed evangelica, capace di suscitare e promuovere nei giovani interessi ed esperienze di qualità;
- che faccia appello alla responsabilità e alla partecipazione comunitaria, cercando il coinvolgimento e l’impegno personale degli stessi giovani;
- con una pluralità di proposte differenziate ( ricreative, culturali e religiose) adeguate ai reali bisogni delle persone.
• Pedagogia della mediazione culturale
La presenza educativo-pastorale nell’ambito universitario deve abilitare i giovani:
- alla integrazione del sapere verso la formazione integrale della persona;
- all’apertura ai molteplici livelli e forme di approccio alla realtà, quelli della razionalità scientifica e tecnologica o della efficienza e produttività economica, e quelli della ragione analogica e simbolica;
- al dialogo interculturale;
- allo sviluppo della dimensione etica del sapere e della professione attraverso una riflessione critico-valutativa sulle conquiste del sapere e della scienza e la ricerca degli assi portanti della cultura come il campo privilegiato per un dialogo tra fede e cultura e la sintesi tra cultura e vita;
- al dialogo sistematico e interdisciplinare con la fede, verso la formazione di una mentalità cristiana.
• Pedagogia dell’impegno e confronto con la propria realtà culturale, sociale ed ecclesiale
È importante evitare una separazione tra la domanda e ricerca di senso nell’ambito intellettuale e soggettivo e la pratica sociale e comunitaria, per superare il rischio di cadute nell’individualismo e nella ricerca ossessiva di un successo slegato dall’insieme della vita personale e da quella comunitaria. Questo è particolarmente grave, quando si tratta di giovani con particolari capacità personali e con speciali compiti nella società e nella Chiesa. Per questo si deve curare:
- un’educazione alla responsabilità etica e civile e alla formazione socio-politica;
- l’offerta di esperienze di volontariato e di servizio gratuito alla comunità e al territorio;
- la partecipazione attiva nelle iniziative culturali, sociali e religiosi esistenti o proposte;
- l’inserimento e la collaborazione con altre organizzazioni e strutture civili ed ecclesiali che operano nell’ambito del territorio e della Chiesa locale.
• Pedagogia dell’accompagnamento personale
In questo momento della sua vita il giovane universitario ha bisogno di aiuto per trovare chiarezza, per approfondire la sua vita con valori cristiani e umani e per orientarsi nella ricerca delle opzioni adulte. Questo richiede di:
° offrirgli una proposta di accompagnamento fatta di accoglienza, di disponibilità e di amicizia, di rapporto interpersonale, di senso della gradualità, di discernimento delle concrete situazioni che sono vissute e del loro migliore e possibile sviluppo;
° presentargli i diversi cammini vocazionali, per aiutarlo a prendere coscienza della sua vocazione e missione nella società e nella Chiesa.
Suggerimenti bibliografici per l'approfondimento
Movimento Giovanile Salesiano
DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE DELLA CONGREGAZIONE SALESIANA, Il Movimento Giovanile Salesiano come espressione della Spiritualità Giovanile Salesiana. Atti del Convegno Europeo di Sanlucar la Mayor 1992. Roma 1993
BOSCO G.B., Il Movimento Giovanile Salesiano. In DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE, Il cammino e la prospettiva 2000. Documenti PG 13. Roma 1991, pp.123-147.
DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE SALESIANA, Gruppi giovanili salesiani. Dossier PG Esperienze a confronto 6. Roma 1990.
Volontariato
DICASTERI PER LA PASTORALE GIOVANILE, PER LE MISSIONI E PER LA FAMIGLIA SALESIANA, Volontariato e missione salesiana, Roma, 1985.
DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE, Esperienze di volontariato salesiano. Dossier PG 10. Roma 1995.
DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE, Formazione al volontariato salesiano. Dossier PG 11. Roma 1996.
DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE, Giovani come tutti, ma… Testimonianze di volontari. Dossier 12. Roma 1996.
Nei tre dossier si presentano esperienze e materiali interessanti.
SEPSUR, Voluntariado juvenil, En “Cuadernos de pastoral juvenil – 36”, mayo 1998.
Centri di animazione vocazionale
DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE, Pastorale vocazionale salesiana. “vieni e vedi”. Dossier PG Esperienze a confronto 4. Roma 1989.
PER LA PASTORALE GIOVANILE, Salesiani…Come… Perché?… Dossier. Esperienze a confronto 5. Roma 1989.
Con alcune esperienze illuminanti e alcuni indicazioni e criteri di azione.
Presenza tra gli universitari
NANNI C., (a cura) Salesiani e pastorale tra gli universitari. Roma 1988.